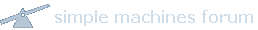|
Admin
Utente non iscritto
|
 |
« Risposta #30 inserito:: Giugno 23, 2009, 02:39:29 pm » |
|
23/6/2009 Cinque toppe da cucire MICHELE AINIS Alla fine della giostra, il referendum abrogativo ha abrogato il referendum. Quando 8 elettori su 10 disertano le urne, quando i 3 quesiti elaborati da Guzzetta vanno a ramengo come i 21 che li hanno preceduti, quando insomma da 14 anni nessun referendum riesce a scavalcare il quorum, tanto vale fargli un bel funerale. Il referendum è morto, ne parleranno semmai i libri di storia, né più né meno dei plebisciti che a metà ’800 scandirono l’unità d’Italia. O almeno è morta la creatura che negli Anni 70 ci consegnò divorzio e aborto, che negli Anni 80 ci tolse il nucleare, che negli Anni 90 - con altri due referendum sulle leggi elettorali - chiuse la prima Repubblica, inaugurando la seconda. Sicché, prima di ogni riflessione sul (non) voto, c’è subito un appello da rivolgere ai partiti: tirate fuori dalla tomba questo strumento di democrazia diretta, riscrivetene le regole, restituiteci la seconda scheda che nel 1947 i costituenti donarono al popolo italiano. Appello temerario, perché proprio i partiti hanno fin qui indossato i panni del carnefice. In primo luogo tenendolo per 22 anni in quarantena (la legge istitutiva è del 1970): chi nasce malaticcio, difficilmente diventerà un atleta. In secondo luogo frodando a più riprese i risultati, come accadde nel 1993 per il referendum sul finanziamento pubblico ai partiti: abrogato dal 90% dei votanti, ma immediatamente riesumato sotto falso nome («rimborso elettorale»). In terzo luogo - e questa è storia più recente - organizzando l’astensione: siccome c’è un 20% d’italiani che non va mai a votare, basta convincerne un altro 30% e il gioco è fatto. Ma davvero in questo gioco vince a mani basse il sistema dei partiti? No, nessuna democrazia - nemmeno la più partitocratica - può stare in piedi senza un popolo. E il popolo italiano di questi tempi non rifiuta solo i referendum, rifiuta per esempio le elezioni provinciali (55% d’astenuti ai ballottaggi), rifiuta governo e Parlamento (con un tasso di sfiducia 4 punti più alto rispetto alla media europea: Eurostat 2007), rifiuta in blocco anche i partiti (se ne sente rappresentato il 14,1% appena: Eurispes 2008). Ecco perché è diventato urgente ricucire il dialogo fra la politica e la società civile. Con la riforma del bicameralismo, con il federalismo, con tutti gli ismi che vi pare, ma altresì con un’iniezione di democrazia diretta. E non ci venite a raccontare che stavolta i quesiti erano troppo tecnici, troppo sofisticati. Nel 1993 lo era altrettanto il referendum Segni sulla legge elettorale del Senato, ma ottenne l’82% dei consensi. Non diteci che le iniziative referendarie hanno successo solo se incrociano un tema che scalda le coscienze, quando nel 1995 il 57% degli elettori votò sulle rappresentanze sindacali e sul soggiorno cautelare. Trovate piuttosto gli strumenti per sconfiggere il clima di disillusione, se non di frustrazione, che segna la nostra vita collettiva. E tra questi strumenti non dimenticate il referendum, «gemma della Costituzione» (la definizione è di Norberto Bobbio). Ha bisogno d’un vestito nuovo, o almeno di qualche rattoppo. Anzi: le toppe necessarie sono cinque, come le dita d’una mano. Primo: via la possibilità d’abrogare singole parole, spezzoni di frasi, segni di punteggiatura. Ne vengono fuori quesiti incomprensibili, non era questa l’intenzione dei costituenti. Torniamo al modello del referendum oppositivo, e perciò abrogativo di un’intera legge, o quantomeno dei suoi singoli articoli. Secondo: affianchiamogli il referendum propositivo, dato che l’iniziativa legislativa popolare è carta straccia, destinata ai cestini delle Camere. È per questa lacuna che ha preso piede la moda dei referendum fatti con le forbici, per incanalare un’energia di cambiamento che altrimenti non ha sfogo. Terzo: anticipiamo il giudizio della Consulta prima che si raccolgano le firme, ma anticipiamo pure il calendario dei referendum, perché in caso contrario voteremo proposte fabbricate nella notte dei tempi, com’è appena accaduto. Quarto: blindiamo il risultato per una legislatura almeno, basta con i raggiri e le furbate. Quinto: teniamoci pure il quorum, ma ridimensionato, collegandolo al numero effettivo dei votanti nelle ultime elezioni. Sempre che, ovviamente, ci sia ancora qualcuno che ha voglia di votare. michele.ainis@uniroma3.it da lastampa.it |
|
|
|
|
 Registrato
Registrato
|
|
|
|
|
Admin
Utente non iscritto
|
 |
« Risposta #31 inserito:: Luglio 04, 2009, 12:21:51 pm » |
|
4/7/2009 L'ossessione della sicurezza genera insicurezza MICHELE AINIS All’indomani del nuovo reato d’immigrazione clandestina, alla vigilia del prossimo reato d’intercettazione malandrina, resta in sospeso una domanda: quanti ancora vogliamo sbatterne in galera? Africani itineranti, giornalisti intraprendenti, e poi a seguire drogati impenitenti, automobilisti imprudenti, mendicanti e postulanti, perfino chi ha una casa da affittare, se putacaso sbaglia l’inquilino. Ma questa domanda se ne tira dietro una seconda: c’è in Italia un pozzo così largo e profondo da ospitare i rifiuti umani che gettiamo via dalla cucina? No, non c’è. C’è piuttosto un intero paese chiuso a chiave dentro il Belpaese. È grande quanto L’Aquila prima del terremoto, supera la popolazione di Teramo e Rovigo, ha il doppio d’abitanti rispetto a Enna, Aosta, Nuoro, Belluno, ma non dispone degli stessi chilometri quadrati. Vive in stanze dove si fanno i turni per dormire, talvolta in compagnia di qualche topo, talvolta sottoterra come a Favignana. È il paese dei galeotti: 63.460 residenti a giugno, 70 mila entro il prossimo dicembre, dato che le new entries sono mille al mese. Significa due volte e mezzo la popolazione carceraria del 1990, significa una cifra mai più raggiunta da quando Togliatti nel 1946 firmò la prima amnistia della Repubblica. Ma siccome la capienza dei nostri penitenziari (peraltro spesso fatiscenti) è di 43 mila posti, significa altresì che 20 mila detenuti sono in soprannumero, con un tasso d’affollamento che tocca il 160% in Lombardia, Friuli, Veneto, Sicilia, nonché il 193% in Emilia Romagna. Questo trattamento da sardine in scatola pone in primo luogo una questione di decenza, perché è indecente trattare i carcerati peggio delle bestie, quando le sevizie agli animali sono punite dalla legge. Pone in secondo luogo una questione d’ordine, perché col caldo la situazione finirà per surriscaldarsi ulteriormente, mentre gli agenti penitenziari sono 5 mila meno dell’organico. Pone in terzo luogo una questione di legalità, che a propria volta si traduce nell’offesa a tre principi dichiarati dalla Carta. Primo: il «senso di umanità» cui deve corrispondere la pena. Secondo: la presunzione d’innocenza, che evidentemente non vale per quel 52% di detenuti in attesa d’una sentenza definitiva di condanna. Terzo: l’eguaglianza «senza distinzione di razza», dato che la carcerazione preventiva colpisce il 43% degli italiani, ma il 58% degli extracomunitari. D’altronde vorrà pur dire qualcosa se nelle ultime due settimane sia il Capo dello Stato, sia il presidente della Corte costituzionale hanno manifestato il loro allarme. E d’altronde perfino in California - dove le galere sono le più gonfie al mondo - nel febbraio scorso una Corte federale ha imposto a Schwarzenegger di liberare un terzo dei detenuti entro il prossimo triennio. Sicché serve a ben poco baloccarsi con l’idea delle celle galleggianti, o fantasticare su un piano d’edilizia carceraria che aggiungerebbe 17 mila posti entro il 2012, come ha promesso il governo a inizio anno. Staremmo comunque sotto il necessario, e oltretutto fin qui ogni nuovo carcere ci ha messo non meno di 10 anni prima che gli operai togliessero il disturbo. Meglio, molto meglio, cancellare quel comma della legge Fini-Giovanardi sulle droghe che tiene dentro il 40% dei detenuti, perché non distingue fra consumo e spaccio. Meglio allargare le misure alternative al carcere, dato che nel 2008 la recidiva ha toccato soltanto lo 0,45% dei casi. Meglio infine smetterla con l’abuso dei delitti e delle pene. Anche perché, se diventiamo tutti criminali potenziali, il questurino o il giudice potrà mettere in galera chi gli sta meno simpatico. E infine l’ossessione della sicurezza avrà generato la più acuta insicurezza. michele.ainis@uniroma3.it da lastampa.it |
|
|
|
|
 Registrato
Registrato
|
|
|
|
|
Admin
Utente non iscritto
|
 |
« Risposta #32 inserito:: Luglio 17, 2009, 05:08:20 pm » |
|
17/7/2009 Se la forma diventa sostanza MICHELE AINIS La promulgazione delle leggi è l’atto più rituale del nostro ordinamento. Nel caso della legge sulla sicurezza, Napolitano lo ha consumato nel modo più irrituale, accompagnandolo con una lettera carica di dubbi e di riserve. Da qui un diluvio di reazioni, dal plauso del presidente della Camera Fini al biasimo dell’ex presidente del Senato Pera. Ma da qui anche una doppia questione: di metodo e di merito, giuridica e politica. E almeno questa volta il metodo giuridico precede il merito politico, la forma condiziona la sostanza. Cominciamo allora da una domanda in punta di diritto: esiste la promulgazione con riserva? No, non esiste. Se il Presidente ha qualche riserva sulla legge che dovrebbe promulgare, non ha che da rinviarla al Parlamento, imponendo un nuovo voto, e magari talune correzioni. In altri termini, la riserva presidenziale si traduce nel rinvio, e dunque nel rifiuto di promulgazione. Infatti il rifiuto - a differenza del consenso - è sempre accompagnato da un messaggio motivato alle due Camere, come vuole l’articolo 74 della Costituzione. Significa perciò che nella circostanza Napolitano ha usato in modo distorto i suoi poteri? La risposta è un altro no, per almeno due specifiche ragioni. In primo luogo, le regole costituzionali hanno uno stampo diverso da quelle del codice stradale. Nella fattispecie l’automobilista è la politica, sicché la regola deve riflettere l’elasticità della politica, per calzarle come un guanto. Non per nulla negli ultimi anni si contano vari precedenti di promulgazioni accompagnate da una lettera presidenziale al governo e al Parlamento. È successo durante il settennato Ciampi, è successo in altre tre occasioni durante questo settennato. Dunque la regola si è via via innervata d’una prassi che la rende meno rigida, meno perentoria. Come d’altronde è già accaduto in sorte all’altro garante delle nostre istituzioni, la Consulta. Dovrebbe pronunziare unicamente sentenze d’accoglimento o di rigetto delle questioni che le vengono sottoposte; ha forgiato viceversa un intero arsenale di strumenti processuali, dalle sentenze manipolative a quelle monitorie, che fanno salva la legittimità costituzionale delle leggi, ma aggiungono un monito al legislatore affinché rimedi ai propri errori. Come ha fatto, per l’appunto, il presidente. In secondo luogo, rendere noti i propri dubbi, illustrare pubblicamente le ragioni del proprio operato, è sempre un elemento di trasparenza della vita democratica. Napolitano ci ha abituato già a questo costume intellettuale, per esempio quando ha spiegato ai giornalisti le sue scelte dopo la crisi del governo Prodi, all’atto di conferire un incarico a Marini. Un’altra prassi irrituale, ma non certo eversiva. Semmai è irrituale la confezione di leggi che si risolvono in altrettanti fritti misti, com’è il caso della legge sulla sicurezza. Tre soli articoli, ma un totale di 128 commi, che a loro volta modificano più di 200 disposizioni normative. Perle giuridiche, come una norma modificata da due distinte norme della legge di modifica. Sanzioni inapplicabili, che in nome della sicurezza generano maggiore insicurezza. Ecco, è qui che la forma diventa un problema di sostanza. Napolitano lo ha pubblicamente denunciato, pur senza accendere il rosso del semaforo. E la sua denuncia è insieme giuridica e politica. Perché la cattiva forma delle leggi è sempre figlia della cattiva politica. michele.ainis@uniroma3.it da lastampa.it |
|
|
|
|
 Registrato
Registrato
|
|
|
|
|
Admin
Utente non iscritto
|
 |
« Risposta #33 inserito:: Luglio 31, 2009, 11:41:55 pm » |
|
31/7/2009 Democrazia zoppa d'Italia MICHELE AINIS Ancora qualche giorno, poi il Parlamento andrà in vacanza. Ma in realtà le vacanze dei parlamentari durano dall’avvio della legislatura. Anzi: i nostri rappresentanti non sono in ferie, sono già in pensione. Pensionamento anticipato, come succede nelle aziende in crisi. Perché le due Camere hanno ormai una funzione puramente ornamentale. Non dettano più l’agenda del Paese, semmai la scrivono sotto dettatura. I dati sono fin troppo eloquenti. Per esempio quelli diffusi il mese scorso dall’Osservatorio civico sul Parlamento italiano. Su 4.016 proposte legislative depositate alla Camera e al Senato, soltanto 68 si sono trasformate in legge. Neanche poche, giacché fra i nostri guai c’è il gran numero di leggi e di leggine che abbiamo sul groppone. Ma il guaio maggiore dipende dalla circostanza che fra queste 68 leggi, 61 sono nate su iniziativa del governo: il 90%. Dunque l’officina del diritto ha traslocato, il suo nuovo indirizzo è a palazzo Chigi. Per conseguenza i parlamentari della maggioranza sono i più assidui nelle votazioni (83% di presenze), quando c’è da mettere un timbro sugli ordini del Capo; diventano altrettanti desaparecidos se si tratta di prendere parola in aula, o d’imbastire a propria volta qualche iniziativa (il Pdl ha il più basso grado d’efficienza: 2,01 in una scala da 0 a 10). Ma in generale solo 24 onorevoli su un migliaio lavorano a pieno ritmo. Colpa loro? Forse. Ma sta di fatto che in Parlamento non c’è più lavoro. Perfino il sindacato ispettivo sul governo è via via sfumato come un ricordo dell’infanzia, se è vero che attualmente sono appena 2 le commissioni bicamerali d’inchiesta: quella sulla mafia e quella sui rifiuti. L’asservimento delle Camere al governo dipende da tre cause. Una originaria: la legge elettorale, che ha trasformato gli eletti in nominati, privandoli d’indipendenza e dignità. Due successive: l’abuso dei decreti legge e dei voti di fiducia. I primi sono ormai una quarantina in questo scorcio di legislatura, benché i costituenti ne avessero immaginato l’adozione soltanto dopo un terremoto. Quanto alle fiducie, fin qui ne abbiamo contate 23, per lo più imposte dall’esecutivo durante la conversione dei decreti, com’è appena accaduto sul decreto anticrisi. Una tenaglia perfetta, stretta alla gola delle assemblee parlamentari in nome dell’urgenza. Ma che cos’è la questione di fiducia? Uno strumento estraneo alla Costituzione, che però il governo sfodera come una sorta di ricatto: o fai come ti dico o tutti a casa. Sicché i parlamentari non votano più misure normative, bensì continue dichiarazioni d’amore verso la carovana dei ministri. Hai fiducia, mi vuoi bene? Dimmelo di nuovo, dimmelo una volta a settimana. Tutto questo sarebbe perfino ridicolo, se non fosse viceversa tragico. In primo luogo perché la smobilitazione delle Camere implica uno sfratto per l’opposizione, dato che quest’ultima ha casa proprio lì, non certo nelle stanze dell’esecutivo. Quando si chiede alle minoranze di collaborare, o almeno d’evitare grida e strepiti, bisognerebbe almeno dire dove si trovi la sede del confronto, quale edificio abbia rimpiazzato il Parlamento. In secondo luogo perché il nuovo andazzo nega l’attributo basilare delle democrazie: il principio di pubblicità. Le discussioni parlamentari sono per definizione pubbliche, ma chi mai viene a sapere quale mano ha scritto il decreto del governo o il maxiemendamento? E chi potrà appurare di quali occulte trattative siano figli questi testi? In terzo luogo - e soprattutto - perché l’eclissi delle Camere ci restituisce un sistema sbilanciato, dove il potere non ha contropoteri, dove la separazione cara al vecchio Montesquieu gira in subordinazione, in accentramento verticale del comando. No, non c’è da rallegrarsi del nuovo abito che indossano le nostre istituzioni. In quest’ultimo anno è andata in crisi la democrazia rappresentativa, ma altresì quella diretta, dopo il fiasco del referendum elettorale, con un misero 23 per cento di votanti. Significa che la democrazia italiana è zoppa di ambedue le gambe. O chiamiamo di corsa un ortopedico, o altrimenti dovremo rassegnarci alla sedia a rotelle. michele.ainis@uniroma3.it da lastampa.it |
|
|
|
|
 Registrato
Registrato
|
|
|
|
|
Admin
Utente non iscritto
|
 |
« Risposta #34 inserito:: Agosto 11, 2009, 11:24:07 am » |
|
11/8/2009 Se l'obiezione diventa malattia MICHELE AINIS C’è un’infezione che giorno dopo giorno fiacca il nostro organismo collettivo. E c’è anche un untore, ci sono una mano e un disegno all’origine di questa malattia. La malattia a sua volta può ben essere letale, perché s’esprime nella disobbedienza alla legge, allo Stato, agli istituti della democrazia. Sia pure in nome di nobili principi, così come era nobile la causa di Antigone, murata viva in una grotta da Creonte per essersi ribellata alla giustizia umana, obbedendo alla legge non scritta che alberga nelle coscienze individuali. Obiezione di coscienza, ecco infatti come noi moderni designiamo tale atteggiamento. Ma negli ultimi mesi le obiezioni si moltiplicano, si alimentano l’una con l’altra, con la benedizione dell’oracolo più autorevole e potente: il Vaticano. Il caso della pillola abortiva - che ha innescato un appello del cardinal Bagnasco ai medici italiani per sabotarne la somministrazione - non è che l’ultimo in ordine di tempo. E d’altronde lo stesso Bagnasco aveva auspicato a più riprese che cresca l’obiezione di coscienza alla legge 194 sull’aborto, anche se abbiamo ormai raschiato il fondo del barile: 70% di ginecologi obiettori nel 2007 (erano il 58% nel 2005). Nel frattempo un centinaio di religiosi (fra i quali l’ex direttore della Caritas) invitano alla disobbedienza contro il reato d’immigrazione clandestina. Domani sarà la volta del testamento biologico, se le nuove norme suoneranno troppo permissive alle gerarchie ecclesiastiche. A meno che la futura legge non preveda espressamente la clausola di coscienza, come è già accaduto nel 1978 per la regolamentazione dell’aborto e nel 2004 per la fecondazione assistita. Tanto ormai l’obiezione sta diventando un fenomeno di massa, sicché il Vaticano fa proseliti pure in campo avverso: il ginecologo radicale Silvio Viale ha appena annunciato un’«obiezione laica» contro le regole che imporrebbero tre giorni di ricovero coatto per assumere la Ru486. Un caso fra i tanti, al pari del farmacista di Fiumicino che il mese scorso ha rifiutato di vendere la pillola del giorno dopo, o al pari delle scuole genovesi che hanno dichiarato obiezione di coscienza contro l’obbligo di denunciare i clandestini. Naturalmente può ben darsi che una legge sfidi le nostre convinzioni più profonde. In quest’ipotesi è lecito sfidarla a propria volta, o forse è doveroso. Se la legge m’impone di giustiziare ogni ebreo che incontro per strada devo oppormi, anche a costo della vita, come Antigone. Ma cosa rischia il ginecologo che nega assistenza a una coppia sterile o a una donna che ha deciso dolorosamente d’abortire? E dov’è l’evento eccezionale quando l’obiezione di coscienza s’applica alle occasioni più svariate? Dov’è il sentimento individuale se la medesima reazione viene sapientemente organizzata o incoraggiata da un’istituzione terza, che plasma le coscienze dall’alto del Cupolone? Poi, certo, il Vaticano avrà le sue ragioni. Ragioni forti, se durante l’incontro fra Obama e Benedetto XVI quest’ultimo ha chiesto garanzie proprio sull’obiezione di coscienza, definendola «la grande sfida» che attende ogni nazione. Noi però, su quest’altra sponda del Tevere, vediamo soprattutto una sfida allo Stato, alla sua residua autorità. Vediamo il rischio di un’anarchia di massa, in cui ciascuno fa un po’ come gli pare. Tanto una coscienza, buona o cattiva, ce l’abbiamo tutti. Sicché di questo passo dovremo forgiare tante leggi per quante sono le coscienze. michele.ainis@uniroma3.it da lastampa.it |
|
|
|
|
 Registrato
Registrato
|
|
|
|
|
Admin
Utente non iscritto
|
 |
« Risposta #35 inserito:: Settembre 03, 2009, 05:21:31 pm » |
|
3/9/2009 Se si rovescia la grammatica della politica MICHELE AINIS Passi quando i politici si querelano a vicenda. Negli ultimi tempi è successo per esempio tra Vendola e Gasparri, così come succede a giorni alterni tra Di Pietro e Berlusconi, ora perché il primo accusa il secondo di riempirsi le tasche attraverso gli accordi commerciali con la Libia, ora perché il secondo accusa il primo d’aver scroccato la laurea grazie all’aiuto dei servizi segreti. In tutti questi casi la querela non è che uno strepito di carte bollate, è un urlo scritto, nemmeno il più assordante nel gran baccanale cui ci ha reso avvezzi la politica. E oltretutto si risolve quasi sempre in una bolla di sapone, tanto parlamentari e consiglieri regionali sono insindacabili per le opinioni espresse, come peraltro sanno fin troppo bene gli stessi interessati. Ma quando il politico di turno cita in giudizio un organo di stampa, allora no: qui s’apre un fronte di tutt’altro genere. È il fronte su cui si è acquartierato il presidente del Consiglio, sparando le sue cartucce giudiziarie contro Repubblica, El País, Nouvel Observateur, infine l’Unità. Sia detto per chiarezza: Berlusconi non è il primo, e di questi tempi non è neppure il solo. Nel marzo 2008 un altro presidente del Consiglio - Romano Prodi - querelò Il Giornale per diffamazione. Nell’ottobre 1999 Massimo D’Alema - anche lui in quell’epoca al timone del governo - chiese 3 miliardi di lire a Forattini per una vignetta troppo aspra. Marco Travaglio ha incassato querele dal medesimo D’Alema, oltre che da Schifani e vari altri. Ma la querela viaggia ormai sulle rotte periferiche, oltre che su quelle nazionali. Esposti alla critica, ma pure all’invettiva Durante l’ultima campagna elettorale per il sindaco di Firenze, il futuro vincitore - Matteo Renzi - l’ha brandita contro due giornalisti dell’Espresso. Il sindaco della Spezia ha appena querelato un giornalista e l’ex direttore del Giornale. Quello di Parma ha sporto denunzia contro tre giovani che lo sbeffeggiavano su Facebook. E via via, l’elenco potrebbe continuare per un libro intero. Si dirà: forse che i politici non hanno diritto a tutelare la propria onorabilità ferita? Certo che sì, anche se spesso ne inalberano una concezione un po’ eccessiva, un po’ troppo narcisa. Dimenticando per un verso che il loro ruolo pubblico li espone alla critica ma talvolta pure all’invettiva; e d’altronde se un arbitro di calcio dovesse denunziare tutti coloro che gli gridano insulti dagli spalti, non basterebbero le patrie galere. Dimenticando per un altro verso che la reazione giudiziaria contro la carta stampata suona sempre come un’intimidazione, come un altolà dei governanti ai governati, se è vero che la stampa è il cane da guardia della pubblica opinione. Tanto più quando l’istanza di risarcimento colpisce non solo chi rappresenta una testata, bensì singoli giornalisti, scrittori, opinionisti: precisamente come ha fatto Berlusconi verso l’Unità, nomi e cognomi da infilzare in uno spiedo giudiziario. Un effetto paradossale E c’è infine, a mo’ di corollario in questa e altre vicende, un effetto paradossale che forse gli stessi protagonisti eviterebbero, se almeno ci riflettessero un po’ sopra. Perché sta di fatto che la politica è potere, ma lo è pure l’informazione, il Quarto potere cui Orson Welles dedicò il suo film più memorabile. Se le loro baruffe sbucano in un’aula di giustizia, significa che volenti o nolenti questi due poteri s’assoggettano al potere giudiziario, ne accettano il primato. Sarà pertanto un giudice a stabilire chi ha torto e chi ha ragione. Ma qual è mai l’oggetto del contendere? Non il rispetto d’un contratto, non l’imputazione di un crimine violento, non un fatto certo e inoppugnabile. Si tratta di parole, o meglio del tono con cui risuonano le polemiche politiche, del loro timbro generale. Dopotutto è la grammatica del nostro discorso collettivo che così finisce in tribunale, e il tribunale giudica in conclusione sul vocabolario che gli italiani dovranno recitare in pubblico. Sarebbe meglio rivolgersi all’Accademia della Crusca. michele.ainis@uniroma3.itda lastampa.it |
|
|
|
|
 Registrato
Registrato
|
|
|
|
|
Admin
Utente non iscritto
|
 |
« Risposta #36 inserito:: Settembre 17, 2009, 05:06:47 pm » |
|
17/9/2009 Inutili toni apocalittici MICHELE AINIS Diciamolo, per una volta, a voce bassa: la sentenza sul lodo Alfano non è affatto un’ordalia, un giudizio di Dio. La Consulta la dovrà scrivere da qui a un paio di settimane. È soltanto una fra le centinaia di pronunzie che i quindici giudici costituzionali adottano ogni anno (furono 449 nel 2008, quest'anno siamo già a quota 258). Certo, si tratterà di una sentenza sovraccarica d'effetti politici, ma dopotutto nel giudizio sulle leggi l'imputata è sempre la politica, dal momento che la legge costituisce la forma in cui s'esprime la decisione politica. E allora sarebbe molto meglio moderare i toni, recuperare un clima di normalità costituzionale. A cominciare dai diretti interessati. Speranza vana, se dobbiamo prendere alla lettera un paio di brani apocalittici che figurano nella memoria depositata dall'Avvocatura dello Stato. Vi si legge che in caso di bocciatura subiremmo danni «irreparabili» nel buon funzionamento degli organi elettivi. Si profila addirittura il rischio che il Premier si dimetta. S'evoca il fantasma di Giovanni Leone, che lasciò anzitempo il Quirinale dopo le polemiche sullo scandalo Lockheed. E in conclusione si decanta la specifica virtù del lodo Alfano: un ombrello contro i temporali giudiziari che altrimenti interromperebbero ogni legislatura, dato che «la sola minaccia di un procedimento penale può costringere alle dimissioni». Ora, a parte il fatto che Leone si dimise per una campagna giornalistica e non per un rinvio a giudizio, a parte il fatto che il presidente Berlusconi ha la scorza dura (in caso contrario si sarebbe già dimesso, trovandosi imputato in vari processi prima che il lodo Alfano diventasse legge), a parte il fatto che con questa logica perversa i giudici non dovrebbero neppure aprire indagini su quanti ci governano, insomma a parte tutto rimane in sospeso una domanda: è normale una difesa così, a spada sguainata? No, non è normale. Intanto, l'Avvocatura rappresenta il governo dinanzi alla Consulta, ma già Calamandrei osservava che i governi farebbero meglio a non costituirsi, rimettendosi al giudizio della Corte. In secondo luogo, non è detto che l'esecutivo (e perciò l'Avvocatura) debba per forza sostenere la legittimità dell'atto normativo sindacato: di solito succede, ma in qualche caso (sentenze n. 63 del 1966, n. 305 del 1995, n. 233 del 1996 e via elencando) succede anche il contrario. In terzo luogo, l'argomento delle dimissioni innescate da un'inchiesta giudiziaria è un argomento politico, non tecnico; dipende da una scelta discrezionale rispetto alla quale il diritto resta muto, ed è invece sul filo del diritto che corre il sindacato di costituzionalità. No, non c'è bisogno di politicizzare ulteriormente questa decisione, non c'è bisogno d'alzare la posta scaricando sulla Corte la sopravvivenza stessa della legislatura. Meglio tornare ai codici, alle norme, ai precedenti giurisprudenziali. Sarà forse più noioso, ma alla fine della giostra avremo meno danni. michele.ainis@uniroma3.itda lastampa.it |
|
|
|
|
 Registrato
Registrato
|
|
|
|
|
Admin
Utente non iscritto
|
 |
« Risposta #37 inserito:: Settembre 22, 2009, 11:00:27 am » |
|
22/9/2009 Calabria, legge ad personam e contra personas MICHELE AINIS Sarà pur vero che le leggi personali le ha inventate Berlusconi. Ma c’è chi, a sinistra, ne cavalca l’esempio. Di più: riesce a fondere in un solo atto normativo una legge ad personam e contra personas, oltre che contro le regole più elementari dello Stato di diritto. Per raccontare questa storia, bisogna immergere lo sguardo nei palazzi del potere calabrese, facendo correre all’indietro l’orologio, fino alla data del 2001. Mentre il mondo inorridisce dopo l’attentato alle Twin Towers, la Calabria approva una legge (n. 25 del 29 ottobre 2001) per assumere i portaborse alle dipendenze del Consiglio regionale, attraverso un concorso «riservato». Qualcuno nei giornali mena scandalo, ma dopotutto la stessa sanatoria si ripete in molte altre regioni. Sicché il concorso viene espletato l’anno successivo, 132 portaborse sono dichiarati idonei, ma solo 85 ottengono in premio l’assunzione. E gli altri? Non c’è più posto, la pianta organica è al completo. Però gli esclusi hanno diritto, in base alla normativa statale e regionale, allo scorrimento della graduatoria, se e quando il Consiglio regionale procederà a nuovi reclutamenti. Gioca qui infatti un principio di economia amministrativa: perché mai armare un altro bastimento concorsuale quando la figura professionale che ti serve ce l’hai già, certificata dalla vecchia commissione di concorso? Due anni dopo, nuovo concorso Invece nel 2004 la regione indice una nuova procedura concorsuale: 170 posti. Evidentemente in un paio d’anni si era aperta una voragine in quell’organico zeppo come un uovo. Fanno domanda 48.983 persone, la popolazione d’una cittadina di provincia. E infatti il concorso non si è ancora concluso, benché la Calabria ne abbia affidato la gestione a una società esterna, per risparmiare tempo, non certo per risparmiar denaro. Domanda: ma non era meglio assumere gli idonei del 2002? Sulla carta sì, ma c’è portaborse e portaborse. C’è il parente stretto d’un consigliere regionale, c’è il funzionario di partito, il cui profilo corrisponde quasi sempre agli 85 fortunati vincitori; ma c’è anche il portaborse senza troppi santi in Paradiso, oppure disgraziato, nel senso che è caduto in disgrazia nel frattempo. Tuttavia i disgraziati non s’arrendono: vanno in giudizio, e il tribunale di Catanzaro in 29 casi riconosce il loro diritto all’assunzione. Con quali conseguenze? Un danno erariale di 3 milioni e mezzo di euro, non proprio una bazzecola. Ecco, è a questo punto della storia che entra in scena Sua Maestà la Legge. Se ne rende anfitrione il presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Bova, ex diessino adesso in prima fila nel Partito democratico, nonché titolare d’una pagina su Wikipedia non troppo lusinghiera, per una pioggia di polemiche con il movimento antimafia calabrese e per una condanna della Corte dei conti (penne Montblanc in regalo ai consiglieri). Il rimedio? Una legge retroattiva, che cancelli oggi per allora il diritto allo scorrimento della graduatoria. La certezza del diritto Alla faccia degli illuministi, che a suo tempo ne vietarono l’uso perché altrimenti se ne va in fumo la certezza del diritto. E alla faccia della pubblica decenza, dato che la legge in questione (n. 27 del 2009) viene costruita nottetempo e in pieno agosto, come si fa con gli abusi edilizi. Senza uno straccio di relazione illustrativa che dia qualche informazione ai pochi consiglieri in aula. Senza neppure un passaggio in commissione, benché lo statuto della Calabria (art. 29) lo renda obbligatorio. Per intendersi: come se improvvisamente il presidente Fini tirasse fuori un foglietto dalla tasca, chiedendo ai deputati di trasformarlo in legge. Per la verità, in quella notte del 6 agosto, un consigliere (Demetrio Battaglia) osserva che nessuna assemblea legislativa può cambiare in corso d’opera le regole del gioco. Ma il presidente Bova gli risponde secco: «Per strada, qualcuno che non è il legislatore ha forzato il legislatore». Questo qualcuno è il giudice, che evidentemente a Catanzaro vive sulla strada. Poi c’è qualcuno che doveva cautelarsi dal danno erariale (da qui la legge ad personam). E qualcun altro - i 29 disgraziati - che non doveva prendere servizio (da qui la legge contra personas). Ma dopotutto questa vicenda ci consegna una nota positiva: almeno in Calabria, non è vero che le leggi si disinteressano dei destini personali. michele.ainis@uniroma3.itda lastampa.it |
|
|
|
|
 Registrato
Registrato
|
|
|
|
|
Admin
Utente non iscritto
|
 |
« Risposta #38 inserito:: Ottobre 06, 2009, 05:09:29 pm » |
|
6/10/2009 La differenza tra eguali e diseguali MICHELE AINIS Oggi la Consulta inforca un paio d’occhiali per esaminare il Lodo Alfano. In una Repubblica ideale questo giudizio si consumerebbe nel silenzio degli astanti. Nella nostra Repubblica reale è accompagnato viceversa da boatos, dichiarazioni sempre un po’ sopra le righe, sit-in di protesta preventiva, addirittura la minaccia d’elezioni anticipate. Sicché spegniamo l’audio, e proviamo a raccontare i termini giuridici su cui è chiamata a esprimersi la prossima decisione di legittimità costituzionale. L’oggetto, innanzitutto: e dunque il Lodo. Figlio a sua volta del Lodo Schifani (legge n. 140 del 2003), che circondava di una speciale immunità le cinque più alte cariche dello Stato, e che fu poi decapitato dalla mannaia della Consulta (sentenza n. 24 del 2004). Tornando nella stanza dei bottoni, il centrodestra l’ha riapprovato in una nuova edizione (legge n. 124 del 2008), escludendo dal beneficio il presidente della Corte costituzionale, dichiarando il beneficio stesso rinunziabile a domanda dell’interessato, infine ponendo un limite di tempo alla sua fruizione. Ne rimane tuttavia invariata la sostanza: ovvero la sospensione di ogni processo sui reati comuni del Premier, del Capo dello Stato, dei presidenti di Camera e Senato. E si conserva perciò inalterata la domanda: è giusto o no che quattro eccellentissimi signori siano sottratti alle regole che valgono per tutti i cittadini? Dietro le quinte del giudizio di legittimità costituzionale c’è dunque una questione d’eguaglianza. Sarà per questo che il Lodo Alfano ha subito innescato odi e furori, riattizzando i malumori del popolo italiano per i privilegi della Casta. Sennonché – diceva Aristotele – si danno due specie di eguaglianza: c’è un’eguaglianza «aritmetica» (la stessa cosa a tutti) e ce n’è una «proporzionale» (la stessa cosa agli stessi). E infatti la nostra Carta fa spazio a entrambe le categorie: alla prima quando afferma che tutti sono eguali al cospetto della legge (art. 3), alla seconda quando aumenta il prelievo fiscale per i ricchi, rendendo la tassazione progressiva (art. 53). Quale eguaglianza riflette il Lodo Alfano? Indubbiamente la seconda; si tratta però di stabilire se è ragionevole isolare una categoria di diseguali (le alte cariche istituzionali) rispetto al consorzio degli eguali. In altre parole: chi sono «gli stessi» di cui parlò Aristotele? Stando alla sentenza che a suo tempo la Consulta pronunziò sul Lodo Schifani, la risposta è perentoria: sono l’intero plotone dei ministri, sono la squadra di mille deputati e senatori che s’esibisce in Parlamento. Disse la Corte: il lodo viola il principio d’eguaglianza perché «distingue, per la prima volta sotto il profilo della parità riguardo ai principi fondamentali della giurisdizione, i presidenti delle Camere, del Consiglio dei ministri e della Corte Costituzionale rispetto agli altri componenti degli organi da loro presieduti». Insomma Berlusconi non è Obama: nel nostro ordinamento chi guida l’esecutivo è solo un primus inter pares, non c’è ragione di forgiargli una corazza più robusta di quella che indossano i ministri. Se adesso la Consulta confermerà la sua precedente decisione, vorrà dire che il principio d’eguaglianza in Italia rimane obbligatorio quantomeno fra i membri della Casta. In questo caso possiamo ipotizzare due scenari. Primo: il lodo per i presidenti, e non per i peones, potrà adottarsi ancora (d’altronde non c’è due senza tre) nella forma della legge costituzionale. Significa che verrebbe esposto all’alea di un referendum prima d’entrare in vigore, con tutti i rischi politici del caso. Secondo: si riscrive il Lodo e lo si estende anche ai peones. In questo caso la legge ordinaria sarebbe sufficiente; chissà se basteranno invece i pomodori. michele.ainis@uniroma3.itda lastampa.it |
|
|
|
|
 Registrato
Registrato
|
|
|
|
|
Admin
Utente non iscritto
|
 |
« Risposta #39 inserito:: Ottobre 08, 2009, 11:45:04 am » |
|
8/10/2009 Lezione alla politica MICHELE AINIS Lì alla Consulta avranno bisogno di un ombrello. Sentenza politica, ha subito osservato il sottosegretario Bonaiuti. La Corte è ormai al tramonto, non è più un organo di garanzia, risponde a logiche partitiche anziché costituzionali, ha aggiunto di rincalzo il costituzionalista Gasparri. E intanto Bossi, tanto per sedare gli animi, evoca i rumori della piazza. Prima d’avventurarsi in un commento a caldo su questa calda decisione, sarà bene perciò mettere nero su bianco due premesse. Uno: ogni sentenza di costituzionalità ha carattere politico. Lo capirebbe anche un bambino, dato che le pronunzie costituzionali hanno sempre una legge per oggetto, e dato inoltre che la legge rappresenta il veicolo della decisione politica. Due: non è la piazza a decidere i principi che regolano la nostra convivenza. Se lo Stato di diritto s’affida a un corpo di custodi, è perché la piazza a suo tempo mandò a morte Gesù per salvare Barabba, perché la stessa piazza durante il secolo ventesimo acclamò feroci dittatori, perché insomma le Costituzioni liberali presidiano un sistema di valori, e li sottraggono al dominio delle folle. Meglio posare l’occhio, dunque, sulle ragioni giuridiche di questa decisione. E sia pure con qualche approssimazione, dato che fin qui ne abbiamo in mano l’osso, non la polpa. Difatti in ogni sentenza - e specialmente in una sentenza di legittimità costituzionale - è la motivazione che illustra gli argomenti di cui si nutre poi il dispositivo. È la motivazione, quindi, il metro di misura che ci consente d’esprimere un giudizio ponderato, una critica, un plauso a mani aperte. Noi però non la conosciamo, perché non è ancora stata scritta. Conosciamo un comunicato di tre righe, che ci informa sull’invalidità del lodo Alfano per contrasto con gli articoli 3 e 138 della Costituzione. Il primo enunzia il principio d’eguaglianza; il secondo detta il procedimento di revisione costituzionale. Che significa questo doppio richiamo? Significa anzitutto che la Consulta ha respinto soluzioni pasticciate, che molti davano per certe nei corridoi dei palazzi romani. Dalla prima all’ultima parola No, il lodo è illegittimo dalla prima all’ultima parola, non c’è spazio per interventi di restauro. Ed è illegittimo non tanto per ciò che dice, bensì per come lo dice. Non perché elargisce una speciale immunità alle maggiori cariche istituzionali del Paese, bensì perché confeziona il dono in una legge ordinaria, anziché in una legge costituzionale. Tale massima si poteva già vedere in controluce nel più diretto antecedente della pronunzia sul lodo Alfano, ovvero la sentenza n. 24 del 2004. Ma averla posta a fondamento di quest’ultima decisione ha un valore straordinario, e per almeno due ragioni. In primo luogo, perché riafferma il primato del principio d’eguaglianza sulle volubili scelte del legislatore. Le immunità della politica infliggono altrettante deroghe all’eguaglianza di tutti i cittadini, ma la deroga è ammissibile purché sancita dalla Costituzione stessa o da una fonte normativa equipollente. Vale per i parlamentari (art. 68), per i consiglieri regionali (art. 122), per il governo (art. 96), per il Capo dello Stato (art. 90). Solo il procedimento di revisione costituzionale può introdurre un limite alla parità fra i consociati: può farlo perché è un procedimento che coinvolge anche le opposizioni, e perché quando si modificano le regole del gioco devono essere d’accordo tutti i giocatori. L’insegnamento di Hans Kelsen Non la sola maggioranza, dunque; o altrimenti non senza interrogare gli elettori attraverso un referendum, come stabilisce per l’appunto l’art. 138 della Carta. Risuona qui, del resto, l’insegnamento di Hans Kelsen, il più grande giurista del Novecento: ogni vizio materiale della legge (derivante dal suo contenuto) è in realtà un vizio formale, dipende dalla scelta della legge ordinaria anziché costituzionale. E c’è poi una seconda ragione, forse ancora più importante della prima. Gli avvocati del presidente Berlusconi avevano puntato tutte le fiches sull’espansione del suo ruolo in questo torno d’anni: un primus super pares, secondo l’immaginifica espressione di Pecorella. Se dunque nella Costituzione materiale ormai abita un Premier, la Costituzione scritta è diventata carta straccia. E se il Premier ha tutt’altro spessore rispetto ai vecchi presidenti del Consiglio, serve un’immunità tagliata su misura. Ma che cos’è la Costituzione materiale? Una nuvola che cambia forma a ogni soffio di vento, un fantasma che nessuno può toccare con le dita. Rigettando quest’impostazione, la Consulta ha altresì affermato la supremazia della Costituzione scritta, della legge scolpita su tavole di bronzo. E ha infine impartito una lezione - questa sì, non scritta - alla politica: rispettate la Costituzione, o altrimenti correggetela nelle dovute forme. michele.ainis@uniroma3.it da lastampa.it |
|
|
|
|
 Registrato
Registrato
|
|
|
|
|
Admin
Utente non iscritto
|
 |
« Risposta #40 inserito:: Ottobre 13, 2009, 09:33:45 am » |
|
13/10/2009 La Consulta arsenico e coltelli MICHELE AINIS Potremmo farne una questione di bon ton, di buona creanza nei rapporti tra le massime istituzioni del Paese. Dopotutto se una sentenza sfavorevole diventa l’occasione per urlare a squarciagola contro il Quirinale e la Consulta, per revocarne in dubbio la «lealtà», finiremo per scassare quel poco che resta del nostro Stato di diritto. E dopotutto se il confronto tra i poteri degenera in una rissa permanente, non c’è poi affatto da stupirsi quando la stessa intolleranza si propaga dalla società politica alla società civile, quando una donna, un nero o un gay vengono picchiati per la strada, come succede a giorni alterni. Ma questa vicenda d’arsenico e coltelli non offende unicamente il senso civico. No, reca un affronto alla logica, più che ai due garanti del nostro ordinamento. E infatti nei loro riguardi la doppia accusa di slealtà suona doppiamente strampalata. Il Presidente, innanzitutto. Sarebbe in mala fede perché, lui comunista, non si è impegnato a convincere quegli altri comunisti che hanno banco alla Consulta. Ma a suo tempo Napolitano ha promulgato il lodo Alfano, senza esercitare il potere di rinvio alle Camere, senza neppure manifestare una riserva, anzi rendendo esplicite le ragioni del consenso; se davvero la sentenza costituzionale metteva in gioco la sua autorevolezza, il Presidente avrebbe avuto tutto l’interesse a un disco verde. Più che sleale, dovremmo definirlo un po’ sdentato, senza denti per mordere le altre istituzioni. Ma non è così, o altrimenti è così per tutti i presidenti. Sta di fatto che ogni sentenza d’incostituzionalità demolisce una legge già in vigore, e perciò già promulgata dal Capo dello Stato: se le due decisioni fossero sempre consonanti, o nessuna legge entrerebbe mai in vigore, oppure nessuna legge verrebbe mai annullata. D’altronde su questa falsariga potremmo continuare all’infinito: è sleale il giudice di primo grado quando la sua pronunzia viene rovesciata dal giudice d’appello, è sleale la commissione Affari costituzionali quando reputa legittima una legge che il presidente rifiuta poi di promulgare, è sleale il Parlamento quando cambia 55 articoli della Costituzione (è accaduto nel 2005), e con un referendum il corpo elettorale successivamente getta la riforma nel cestino dei rifiuti. O forse è sleale la nostra stessa Carta, giacché prevede molteplici istanze di controllo, ciascuna con il suo spazio e il suo specifico raggio d’escursione. E c’è poi la Consulta, l’imputata principale. Davvero mise fuori strada il Parlamento, quando nel 2004 bocciò il lodo Schifani senza accennare all’esigenza di proteggerlo con legge costituzionale? La risposta è un triplo no. In primo luogo perché la Corte Costituzionale non pontifica sull’universo mondo, bensì risponde a quesiti puntuali e circoscritti; e cinque anni fa l’art. 138 - che detta il procedimento di revisione costituzionale - rimase fuori dalla porta per una scelta dei giudici che avevano sollevato la questione (sentenza n. 24 del 2004, punto 1 della motivazione in diritto). In secondo luogo perché, ciò nonostante, a leggere tra le righe quella prima decisione poteva già desumersi la necessità di una legge costituzionale; tanto che molti commentatori se ne accorsero, basta sfogliare le riviste giuridiche dell’epoca. In terzo luogo per una chiara affermazione della Corte: il lodo Schifani - disse - viola il principio d’eguaglianza e il diritto di difesa processuale, dopo di che «resta assorbito ogni altro profilo di illegittimità costituzionale» (punto 8 della motivazione). Assorbito, non escluso. Insomma nessuna retromarcia, nessuna inversione giurisprudenziale. Domanda: e se anche fosse? Negli Usa la Corte suprema avallò la segregazione razziale per decenni: classi differenziate nelle scuole, tavoli separati al ristorante, orari diversi per montare su un mezzo di trasporto pubblico. Poi nel 1954, con la celebre sentenza Brown, aprì finalmente ai neri il condominio riservato ai bianchi; mezzo secolo più tardi Obama è presidente. Anche la Corte italiana, nel 1961, giudicò legittima la punizione del solo adulterio femminile; ma nel 1968 ci liberò da questa odiosa discriminazione. Evidentemente qualche volta la slealtà è la madre del progresso. michele.ainis@uniroma3.itda lastampa.it |
|
|
|
|
 Registrato
Registrato
|
|
|
|
|
Admin
Utente non iscritto
|
 |
« Risposta #41 inserito:: Ottobre 21, 2009, 02:38:24 pm » |
|
21/10/2009 Le certezze garantite dalla corte MICHELE AINIS Il lodo Alfano è ormai consegnato agli archivi del diritto, come la sentenza costituzionale che ne ha decretato i funerali. Ma a leggere le 34 pagine di questa decisione, c’è un punto su cui la Consulta batte come un chiodo: la regola formale s’impone su quella sostanziale, la norma scritta è più potente di quella applicata nel nostro vissuto quotidiano. Così, il presidente del Consiglio resta un primus inter pares, benché le leggi elettorali lo abbiano trasformato in un sovrano. Così, le immunità della politica sono esclusivamente quelle scolpite sulla Carta, benché la politica a sua volta ne estenda sempre più il perimetro per proteggersi dalle incursioni giudiziarie. Così, più in generale, le garanzie costituzionali rimangono intangibili per la maggioranza di governo, benché la maggioranza vi contrapponga il consenso del popolo sovrano. Potremmo salutarla come una buona novella, una parola chiara nel buio delle Gazzette ufficiali. Non è così, o forse è così soltanto in questo caso. Perché la stessa Corte, pur sancendo il primato della regola scritta, ha dovuto ammettere al contempo l’esistenza della regola non scritta. Perché questo doppio registro normativo innesca una perenne fonte di tensione, oltre che d’incertezza circa la soglia fra il lecito e l’illecito. E perché infine l’incertezza non tocca unicamente gli equilibri tra i poteri dello Stato. Non si limita ad opporre legittimità a legittimità, di qua il governo, di là i custodi del governo. No, ci riguarda tutti, avvolge la nostra esperienza come un guanto. Le prove? Alzi la mano chi non ha mai incontrato un medico, un avvocato, un artigiano che alla fine della giostra non gli abbia sottoposto la scelta fra due prezzi: uno con fattura, uno (più basso) senza. Chi non si è mai messo in coda davanti a uno sportello sentendosi poi dire che in quell’ufficio la procedura era diversa rispetto all’ufficio dirimpetto. Chi non è mai inciampato su normative schizofreniche viaggiando su e giù lungo la Penisola. Chi non ha un conoscente assunto per chiamata diretta, quando la regola costituzionale imporrebbe la prova del concorso. Chi non ha mai partecipato a una riunione fra condomini dove l’uno oppone all’altro una diversa regola legale, ambedue vigenti, ambedue infine scalzate da una terza regola forgiata dalla prassi. Da qui un fattore d’inflazione normativa, perché la norma non scritta si somma a quella scritta, ne fa le veci in particolari circostanze, a seconda degli umori individuali. Ma da qui - per paradosso - anche un vuoto normativo, perché in altre circostanze le due norme s’elidono a vicenda. D’altronde è paradossale pure la condizione dei cittadini che in buona fede vorrebbero obbedire ai precetti del diritto, e che loro malgrado rischiano invece di violarlo. Come quel bambino cui mamma e papà, per il suo compleanno, regalano due paia di scarpe nuove. Lui indossa le scarpe comprate dalla mamma, e subito dopo patisce il rimbrotto del papà: «Non ti farò mai più un regalo, dato che non hai messo le mie scarpe». Ecco, noi tutti abbiamo solo un paio di piedi. Se la disapplicazione della legge, ovvero la sua distorta applicazione, diventa essa stessa legge vincolante, se insomma genera un altro paio di scarpe normative, nel dubbio finiremo per camminare a piedi nudi. Senza scarpe, senza regole per il nostro viaggio. michele.ainis@uniroma3.itda lastampa.it |
|
|
|
|
 Registrato
Registrato
|
|
|
|
|
Admin
Utente non iscritto
|
 |
« Risposta #42 inserito:: Novembre 04, 2009, 11:29:53 am » |
|
4/11/2009 Nessuna legge lo prevede MICHELE AINIS Doveva arrivare un giudice d’Oltralpe per liberarci da un equivoco che ci portiamo addosso da settant’anni e passa. In una decisione che s’articola lungo 70 punti (non proprio uno scarabocchio scritto in fretta e furia) ieri la Corte di Strasburgo ha messo nero su bianco un elenco di ovvietà. Primo: il crocifisso è un simbolo religioso, non politico o sportivo. Secondo: questo simbolo identifica una precisa religione, una soltanto. Terzo: dunque la sua esposizione obbligatoria nelle scuole fa violenza a chi coltiva una diversa fede, o altrimenti a chi non ne ha nessuna. Quarto: la supremazia di una confessione religiosa sulle altre offende a propria volta la libertà di religione, nonché il principio di laicità delle istituzioni pubbliche che ne rappresenta il più immediato corollario. Significa che fin qui ci siamo messi sotto i tacchi una libertà fondamentale, quella conservata per l’appunto nell’art. 9 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo? Non sarebbe, purtroppo, il primo caso. Ma si può subito osservare che nessuna legge della Repubblica italiana impone il crocifisso nelle scuole. Né, d’altronde, nei tribunali, negli ospedali, nei seggi elettorali, nei vari uffici pubblici. Quest’obbligo si conserva viceversa in regolamenti e circolari risalenti agli Anni Venti, quando l’Italia vestiva la camicia nera. Fu introdotto insomma dal Regime, ed è sopravvissuto al crollo del Regime. Non è, neppure questo, un caso solitario: basta pensare ai reati di vilipendio, agli ordini professionali, alle molte scorie normative del fascismo che impreziosiscono tutt’oggi il nostro ordinamento. Ma quantomeno in relazione al crocifisso, la scelta normativa del Regime deve considerarsi in sintonia con la Costituzione all’epoca vigente. E infatti lo Statuto albertino, fin dal suo primo articolo, dichiarava che «la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato». Da qui figli e figliastri, come sempre succede quando lo Stato indossa una tonaca in luogo degli abiti civili. Ma adesso no, non è più questa la nostra divisa collettiva. L’art. 8 della Carta stabilisce l’eguale libertà delle confessioni religiose, e stabilisce dunque la laicità del nostro Stato. Curioso che debba ricordarcelo un giudice straniero. Domanda: ma l’art. 7 non cita a sua volta il Concordato? Certo, e infatti la Chiesa ha diritto a un’intesa normativa con lo Stato italiano, a differenza di altre religioni (come quella musulmana) che ancora ne risultano sprovviste. Però senza privilegi, neanche in nome del seguito maggioritario del cattolicesimo. D’altronde il principio di maggioranza vale in politica, non negli affari religiosi. E d’altronde la stessa Chiesa venne fondata da Cristo alla presenza di non più di 12 discepoli. Se una religione è forte, se ha fede nella sua capacità di suscitare fede, non ha bisogno di speciali protezioni. michele.ainis@uniroma3.itda lastampa.it |
|
|
|
|
 Registrato
Registrato
|
|
|
|
|
Admin
Utente non iscritto
|
 |
« Risposta #43 inserito:: Dicembre 12, 2009, 03:39:14 pm » |
|
12/12/2009 Museruola ai diritti dei garanti MICHELE AINIS Nella crociata bandita dal presidente del Consiglio contro i due garanti della Costituzione - il Capo dello Stato e la Consulta - ogni giorno è giorno di battaglia. Ieri Berlusconi ha invitato seccamente il primo a interessarsi dell’uso politico della giustizia, invece di pensare ad altro. L’altro ieri ha accusato la seconda di congiurare con le toghe rosse contro i provvedimenti normativi del governo. Ma con quali munizioni spara il presidente Berlusconi? Non leggi, non decreti, non atti provvisti del gran sigillo dello Stato. No, si tratta semplicemente di parole. E sulle parole viaggiano umori e malumori, che a propria volta determinano il clima complessivo delle nostre istituzioni. Per misurarlo, più che un costituzionalista servirebbe un meteorologo. Anche la Costituzione, però, è intessuta di parole. Anche le sentenze della Corte. La loro colpa? Quella di consentire ai giudici di demolire ogni riforma, appellandosi a «un organo di garanzia trasformato in organo politico» - Berlusconi dixit - «che abroga le leggi fatte dal Parlamento». Non è così: la Corte non abroga le leggi, le annulla. Due parole, due significati, benché in entrambi i casi vi si rifletta una valutazione negativa sulla legge. Tuttavia l’abrogazione esprime un giudizio politico, che infatti spetta alle due Camere; l’annullamento un giudizio giuridico, in termini di validità costituzionale, e a pronunziarlo è per l’appunto la Consulta. Sennonché quest’ultima - secondo la dottrina Berlusconi - si comporta in realtà come un partito, nel senso che impone la sua agenda alla politica. Secondo errore. Ogni sentenza incide sul governo della polis, anche quella scritta da un giudice di pace. A maggior ragione quando la sentenza abbia una legge per oggetto, come succede alla Consulta. Non foss’altro perché le leggi rappresentano il veicolo della decisione politica, la sua forma specifica. Per evitare d’immischiarsene, i giudici costituzionali dovrebbero mettersi in pensione. E tuttavia - aggiunge Berlusconi - come si spiega che la Consulta accenda sempre il rosso del semaforo sulle scelte del governo? Terzo errore. Nell’ultimo deposito di pronunzie costituzionali (il 30 novembre) quelle d’annullamento sono state 4 su 14, e in quelle 4 alcune altre questioni venivano respinte. La volta precedente (il 16 novembre) 2 su 17: l’11%. Significa che la Corte usa il farmaco dell’incostituzionalità con il contagocce, e dunque assolve quasi sempre il Parlamento. Lo fa questa Corte di comunisti col colbacco, lo hanno fatto tutte le altre Corti che l’hanno preceduta. Perché l’annullamento d’una legge è un fatto traumatico per la vita delle istituzioni, e perché almeno in quel palazzo prendono sul serio la «leale collaborazione» invocata da Napolitano. Che cosa rimane, allora, delle parole pronunziate dal presidente Berlusconi? Per l’appunto un clima, un’atmosfera di sospetti e di veleni. E questo clima serve a preparare una riforma costituzionale che metta la museruola ai due garanti. Sul metodo, nulla da eccepire: è la via più democratica per regolare i conti fra politica e giustizia, giacché l’ultima parola l’avremo noi elettori, attraverso un referendum. Sul merito, c’è una lezione che faremmo bene a ricordare, quando verrà il momento. È incisa nella Déclaration che scrissero i rivoluzionari francesi del 1789: «Ogni società nella quale la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha Costituzione». michele.ainis@uniroma3.itda lastampa.it |
|
|
|
|
 Registrato
Registrato
|
|
|
|
|
Admin
Utente non iscritto
|
 |
« Risposta #44 inserito:: Dicembre 15, 2009, 03:59:34 pm » |
|
15/12/2009 Internet no alla censura basta un clic MICHELE AINIS Lo squilibrato che ha ferito Berlusconi raccoglie 50 mila fan tra i navigatori della Rete. Significa che la Rete è a sua volta squilibrata? Significa che ha urgente bisogno di una camicia di forza, o almeno d’una museruola? Calma e gesso, per favore. E per favore smettiamola d’invocare giri di vite e di manette sull’onda dell’ultimo episodio che la cronaca ci rovescia addosso. Oggi succede per l’apologia di reato ai danni del presidente del Consiglio. Ieri per la pedofilia, o per le stragi del sabato sera. Ma non è così che ci procureremo buone leggi. Specie se la legge intenda regolare il più grande spazio pubblico mai sperimentato dall’umanità. Specie se aggredisca la prima libertà costituzionale, quella di parola. Non che le parole siano altrettanti spifferi di vento. Proteggerle con un salvacondotto permanente equivarrebbe in conclusione a non prenderle sul serio, perché tanto contano i fatti, i gesti, le azioni materiali. Equivarrebbe perciò a deprimere la stessa libertà che si vuole tutelare. E d’altronde - come ha scritto il giudice Holmes nella sua più celebre sentenza, vecchia ormai di un secolo - la tutela più rigorosa della libertà d’espressione non proteggerebbe un uomo che gridasse senza motivo «al fuoco» in un teatro affollato, scatenando il panico. Insomma, dipende. Più precisamente, dipende dall’intreccio di tre fattori differenti, che a loro volta si riflettono poi sulle parole che fanno capolino in Rete. In primo luogo, gioca la posizione del parlante. Altro è se racconto le mie ubbie agli amici raccolti attorno al tavolo di un bar, altro è se le declamo a lezione, soffiandole all’orecchio di fanciulli in soggezione davanti alla mia cattedra. In quest’ultimo caso ho una responsabilità più alta, e dunque incontro un limite maggiore. Non per nulla nei manuali di diritto si distingue tra «manifestazione» ed «esternazione» del pensiero. La prima è una libertà, riconosciuta a ogni cittadino; la seconda è un potere, vale per i cittadini investiti di pubbliche funzioni, e ovviamente copre uno spazio ben più circoscritto. Ma non c’è potere in Internet. C’è solo libertà. In secondo luogo, dipende dal mezzo che uso per parlare. Il medesimo aggettivo si carica d'assonanze ora più forti ora più fioche se lo leggo su un giornale che ho scelto d’acquistare, oppure se mi rimbalza dentro casa quando accendo la tv. Ma è un’edicola la Rete? No, e non ha nemmeno l’autorità dei telegiornali. È piuttosto una piazza, sia pure virtuale. Un luogo in cui si chiacchiera, senza sapere bene con chi stiamo chiacchierando. Le chiacchiere, poi, hanno sempre un che d’aereo, di leggero. Anche quando le vedi scritte sul video del computer, sono sempre parole in libertà. Meglio: sono lo specchio dei nostri umori, dei nostri malumori. Sbaglieremmo a infrangere lo specchio, non foss’altro perché così non riusciremmo a modificare di un millimetro il nostro profilo collettivo. E in terzo luogo, certo: dipende da che cosa dico. Se metto in palio mille dollari per chi procurerà lo scalpo di Michele Ainis, probabilmente offendo la legge sulla tutela degli scalpi, e in ogni caso lui avrebbe qualcosa da obiettare. Ecco infatti la soglia tra il lecito e l’illecito: quando la parola si fa azione, quando l’idea diventa evento. In quest’ipotesi è giusto pretendere un castigo, però a due condizioni, messe nero su bianco da decenni nella giurisprudenza americana: che vi sia una specifica intenzione delittuosa; che sussista un pericolo immediato. È il caso di chi plaude alle gesta di Tartaglia? A occhio e croce no, benché ciascuno farà le sue valutazioni. Ma non facciamo ricadere su tutto il popolo dei navigatori le intemperanze di qualche marinaio. Anche perché sono molti di più quanti esecrano Tartaglia, rispetto ai suoi tifosi. Dopotutto l’antidoto agli abusi in Rete già viaggia sulla Rete, basta un clic. michele.ainis@uniroma3.it da lastampa.it |
|
|
|
|
 Registrato
Registrato
|
|
|
|
|