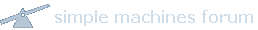|
Admin
Utente non iscritto
|
 |
« Risposta #105 inserito:: Novembre 04, 2010, 09:17:32 am » |
|
Il sud contro il nord L'altra secessione Possiamo pensare alla politica come a una torta a due strati: c’è uno strato superficiale e uno sottostante. Lo strato superficiale è quello della politica politicienne su cui si concentra l’attenzione dei media: crisi di governo? Elezioni? Governi tecnici? Nuove sorprese sul piano giudiziario? Nuovi gossip? Poi c’è lo strato sottostante che sta in profondità. Mentre lo strato superficiale è o può essere soggetto a repentini cambiamenti, nello strato profondo i cambiamenti, ammesso che avvengano, richiedono tempi lunghissimi. Tra i due livelli ci sono influenze asimmetriche, di differente intensità (è più forte l’influenza dello strato profondo su quello superficiale che il contrario). Appartiene allo strato profondo la divisione Nord/Sud. Ciò che accade in quello superficiale, di volta in volta, può disvelare aspetti diversi di quella storica divisione, e può anche, in certe fasi, esasperarla, ma non l’ha creata e non può eliminarla. L’esasperazione della frattura Nord/Sud che sperimentiamo da un ventennio ha la sua causa nella fine della Dc e del sistema di scambi mutualmente soddisfacenti (ampiamente finanziato con l’indebitamente pubblico) che la Dc garantiva fra i diversi territori. Quel sistema aveva assicurato per molti anni una certa tranquillità di superficie ma nella pancia del Paese anche allora si celavano umori cattivi. Qualcuno ricorderà «radio bestemmia », un esperimento di Radio Radicale degli anni Ottanta (non c’era ancora all’orizzonte nessuna Lega a minacciare secessioni). Per tre giorni il microfono fu lasciato, senza controllo, in mano agli ascoltatori: si cominciò con risse e insulti fra tifoserie calcistiche e si finì con una grande esplosione di odio viscerale fra terroni e polentoni. In questi anni siamo stati soprattutto colpiti dal fenomeno più appariscente: il vento del Nord, il leghismo, con il suo secessionismo culturale e, potenzialmente, politico. Non abbiamo prestato abbastanza attenzione al fenomeno opposto e simmetrico, ma più silenzioso, meno visibile: il secessionismo culturale del Sud. La voglia di bruciare il tricolore non appartiene solo ai più esagitati fra i leghisti: anche dal Sud vengono lanciati cerini accesi. Che altro è se non voglia repressa di bruciare il tricolore la rappresentazione del Risorgimento come uno stupro di gruppo ai danni del Mezzogiorno da parte di un Nord violento e rapace? La leggenda nera sull’Italia unita nasce subito dopo l’unificazione nutrendosi di fatti veri (l’occupazione piemontese, la spietata guerra al brigantaggio, il peggioramento delle condizioni delle campagne, la grande migrazione verso le Americhe) ma letti piattamente, senza spirito critico, senza inserirli in una visione più ampia, nella quale la partita del dare e dell’avere fra le regioni ricche e quelle povere svelerebbe il proprio carattere autentico: quello di un complesso interscambio che ha portato, nel lungo periodo, più vantaggi che svantaggi all’intera comunità nazionale. A causa dell’esasperazione della divisione Nord/Sud degli ultimi vent’anni, l’antica leggenda nera viene ora riproposta con forza dagli appartenenti alle classi colte meridionali. Si può leggere di tutto: puntigliose rivalutazioni del Regno delle Due Sicilie, invettive contro Cavour e i piemontesi, criminalizzazione del Nord di ieri e di oggi. Da tante lettere che arrivano quando si scrive di questi argomenti si ricava la sensazione che molti meridionali appartenenti alle classi colte siano sinceramente convinti di due cose. La prima è che, se non ci fosse stata la colonizzazione del Nord, il Sud sarebbe ora qualcosa di simile alla Svizzera o all’Olanda. La seconda è che le classi dirigenti del Sud non abbiano responsabilità dei mali in cui il Sud si dibatte. Nella versione meno spudorata, o meno irrealistica, si parla più prudentemente (come fa il presidente della Regione Sicilia, Raffaele Lombardo) di complicità, di patti perversi fra Roma e le classi dirigenti meridionali. Perché questa forma di secessionismo culturale danneggia il Sud (polemizzando con me, c’è caduto, sia pure da par suo, anche un finissimo osservatore come Ruggero Guarini su Il Foglio del 28 ottobre)? Perché giustifica e perpetua l’irresponsabilità delle classi dirigenti meridionali e garantisce in questo modo l’impossibilità di una svolta. Sembra che ci sia una sorta di «blocco sociale» composto da classi dirigenti che, spesso, hanno assai male amministrato e di classi colte che tengono loro bordone mal consigliando e mal giustificando. È vero che ci sono anche segnali che vanno in una diversa direzione. C’è il fatto che il Sud (come il Nord) non è un blocco territoriale omogeneo: esiste anche un Sud produttivo e ben governato. Inoltre, anche in politica non tutto è sempre scontato: ad esempio, Gianfranco Micciché, tenendo a battesimo la sua costituenda Forza del Sud, ne ha parlato come di un movimento politico che deve spingere il Mezzogiorno a ritrovare il suo orgoglio, mettere al bando ogni sterile lamentela, impegnarsi per creare sviluppo e benessere. Si tratterà di vedere se alle intenzioni corrisponderanno i fatti e se le resistenze di quella consistente parte del Sud che non ne vuol sapere potranno essere superate. Il secessionismo culturale del Sud, nonostante il suo successo e la sua diffusione, ha il fiato corto. A differenza di quello del Nord non può tradursi in secessionismo politico: non dispone dei soldi. Può però avere l’effetto di esasperare ulteriormente il secessionismo nordista. Infatti, anche il movimento leghista è a un bivio, spinto dai suoi stessi impulsi in direzioni diverse: la testa (la ragione) gli detta di cercare soluzioni federali; la pancia lo spinge verso la secessione: un esito che, se si realizzasse, abbasserebbe drasticamente il rango internazionale del Nord (per esempio, in Europa) con molte e pesanti ripercussioni negative. Berlusconi, costruendo l’unico vero partito nazionale in circolazione (forte al Nord come al Sud) ha precariamente, avventurosamente, e provvisoriamente, surrogato il ruolo storico che era stato della Dc, tenendo di fatto insieme il Paese. Quando il suo partito si disferà (probabilmente ciò accadrà quando egli uscirà di scena), Nord e Sud si troveranno l’uno di fronte all’altro senza mediazioni, l’uno contro l’altro. E per l’unità d’Italia sarà l’ora della verità. Però, forse, è imminente una crisi di governo, forse andremo presto a elezioni. Parlando di Nord e Sud ho divagato? Non mi pare. Perché, crisi o no, elezioni o no, è dallo strato profondo della torta che partono comunque gli impulsi più potenti. Da essi dipenderà, anche a breve, il futuro del Paese. Angelo Panebianco 04 novembre 2010© RIPRODUZIONE RISERVATA http://www.corriere.it/editoriali/10_novembre_04/panebianco-altra-secessione_5583edd4-e7dc-11df-a6d6-00144f02aabc.shtml |
|
|
|
|
 Registrato
Registrato
|
|
|
|
|
Admin
Utente non iscritto
|
 |
« Risposta #106 inserito:: Novembre 12, 2010, 12:07:30 am » |
|
IL SILENZIO SULLE PERSECUZIONI Cristiani invisibili Dopo l'attacco di gruppi riconducibili ad Al Qaeda contro una chiesa di Bagdad che provocò cinquanta morti e un centinaio di feriti il 31 ottobre scorso, una nuova ondata di attentati ha preso di mira, questa volta, le case abitate da cristiani: il bilancio provvisorio, probabilmente destinato a salire, è di almeno tre morti e decine di feriti. In Iraq è caccia aperta ai cristiani e, come dice monsignor Matoka, arcivescovo siro-cattolico di Bagdad, «il governo non fa nulla per fermare gli attentati». È facile, per gli occidentali, liquidare la questione come una delle tante tragiche conseguenze della guerra in Iraq. C'è del vero ma è anche una spiegazione insufficiente. Così come è insufficiente rilevare che ciò che sta accadendo è anche la conseguenza della forse prematura scelta americana di dichiarare chiusa la guerra in Iraq e di ritirare il grosso delle truppe. Un ritiro che ha lasciato l'Iraq in balia dei piani egemonici iraniani e sta vanificando il lavoro svolto, a suo tempo, dal generale David Petraeus: la guerriglia sunnita è ora in forte ripresa così come l'attivismo di Al Qaeda. I cristiani, inermi e quindi facili bersagli, sono vittime in uno scontro di potere fra gruppi islamici. Ciò che così non si spiega, però, è perché i cristiani siano continuamente oggetto di attentati in una fascia che va dall'Indonesia all'India, dal Pakistan al Vicino Oriente e che si spinge fino ai territori islamici dell'Africa subsahariana. Le cifre sulla persecuzione dei cristiani nel mondo sono impressionanti. Ogni singolo caso ha certamente anche motivazioni «locali», è anche un portato di condizioni locali. Ciò è vero per definizione. Ma cosa lega la persecuzione dei cristiani nel mondo extraoccidentale, quale è il denominatore comune? Normalmente, chi nega l'esistenza di qualsiasi cosa possa anche solo ricordare vagamente l'espressione «scontro di civiltà» non ha risposte da dare. Il denominatore comune, infatti, c'è: consiste nel fatto che le comunità cristiane, anche se composte da pachistani, iraniani, nigeriani, o anche se, come nel caso delle comunità del Medio Oriente, lì già presenti molti secoli prima che arrivasse l'Islam, vengono associate dai loro nemici al mondo occidentale, ne sono considerate quinte colonne. Uccidere cristiani, anche là dove essi hanno solo la religione in comune con gli occidentali, ha un grande valore simbolico: elimina una presenza «impura», la spazza via dai territori che agli occhi di chi uccide, e dei tanti che applaudono alle uccisioni, appartengono di diritto ai praticanti di un'altra religione e, contemporaneamente, sferra un altro colpo agli odiati occidentali. Gli occidentali, però, fanno finta di niente, fingono di non vedere e non capire. La persecuzione dei cristiani non è un tema che sia mai davvero entrato nelle agende dei governi occidentali di Stati Uniti e Europa, sembra non riguardarli. Con tutto ciò che succede nel mondo, paiono pensare governi e opinioni pubbliche, perché dovremmo preoccuparci anche delle disgrazie dei cristiani non occidentali? Invece, dovremmo preoccuparcene. Il nostro sostanziale disinteresse serve a un bel po' di fanatici in giro per il mondo anche per prenderci le misure, per giudicarci. Ciò che vedono può indurli a pensare che siamo deboli e decadenti e che non c'è pertanto alcun motivo di fermare la mattanza. Angelo Panebianco 11 novembre 2010© RIPRODUZIONE RISERVATA http://www.corriere.it/editoriali/10_novembre_11/cristiani-invisibili-angelo-panebianco-editoriale_8ec9b2ca-ed5b-11df-bb83-00144f02aabc.shtml |
|
|
|
|
 Registrato
Registrato
|
|
|
|
|
Admin
Utente non iscritto
|
 |
« Risposta #107 inserito:: Novembre 16, 2010, 05:34:59 pm » |
|
Il Partito delle Delusioni La vittoria di Giuliano Pisapia alle primarie milanesi del centrosinistra contro il candidato del Partito democratico Stefano Boeri rappresenta, come ha scritto sul Corriere di ieri Michele Salvati, una «secca sconfitta politica» per il gruppo dirigente di quel partito. Una sconfitta che si somma a tante altre batoste, come, a suo tempo, la vittoria di Nichi Vendola in Puglia contro il candidato ufficiale del Pd, la perdita di regioni tradizionalmente governate dalla sinistra, il successo, anche se per ora solo mediatico, della rivolta capeggiata dal sindaco di Firenze Matteo Renzi, e altro ancora. Se la politica italiana è, come è, alla deriva, se la rottura del Pdl e il possibile declino di Silvio Berlusconi preannunciano una crisi di sistema destinata ad avere ripercussioni ovunque, è difficile pensare che possa cavarsela un partito di opposizione così mal messo come il Partito democratico. Talmente mal messo da non aver saputo nemmeno approfittare, in questi anni, della crisi economica per rimontare nei sondaggi (che è ciò che normalmente accade in democrazia: i consensi per l'opposizione crescono quando il governo deve fronteggiare una grave crisi). Così come è fallita l'aggregazione a destra denominata Popolo della libertà sta fallendo l'aggregazione a sinistra denominata Partito democratico. Quando nacque, il Pd suscitò molte speranze fra coloro che auspicavano un rinnovamento della cultura politica della sinistra. Ma le speranze andarono deluse. A poco a poco vennero fuori le magagne: il nuovo contenitore risultò privo di contenuti, più un mezzo per assicurare la sopravvivenza di spezzoni di vecchia classe dirigente che un partito (nonostante, va detto, la serietà degli sforzi iniziali dell'allora segretario Walter Veltroni) dotato di identità e capacità progettuale. Forse il Pd cominciò a morire quando, nell'inverno 2007-2008, fallirono le trattative tra Veltroni e Berlusconi per una riforma, a vantaggio dei grandi partiti, del sistema elettorale. Se quelle trattative fossero andate in porto, il Pd sarebbe forse riuscito a mettere in sicurezza, oltre al bipolarismo italiano, anche se stesso. Probabilmente, avrebbe ugualmente perso le elezioni del 2008 ma, almeno, avrebbe monopolizzato l'opposizione e sarebbe stato in gara per giocarsi, con qualche chance di successo, la prova elettorale successiva. Non andò così. L'incapacità di elaborare e imporre una sua visione delle cose politiche ne fece un partito né carne né pesce, in balia delle pressioni esterne: prima succube dei giustizialisti, poi alla rincorsa dei centristi di Casini, e oggi anche di Fini, domani probabilmente risucchiato (ma, sicuramente, dopo avere perso per strada molti pezzi) dal radicalismo di Vendola e Di Pietro. Non deve rallegrare il declino del Partito democratico. Per chi, come chi scrive, è scettico sulle possibilità del cosiddetto «terzo polo» (spesso, quando si va alla verifica, i terzi poli risultano avere più leader che elettori), quel declino, insieme alla crisi del centrodestra, preannuncia lo sfarinamento del sistema politico vigente anziché la sua imminente ricomposizione su nuove basi. Le crisi di sistema sono lunghe, complesse e imprevedibili. Quando alla fine si affermeranno nuovi equilibri, difficilmente ne sarà protagonista il Partito democratico con la sua fisionomia di oggi. Angelo Panebianco 16 novembre 2010© RIPRODUZIONE RISERVATA http://www.corriere.it/editoriali/10_novembre_16/panebianco-partito-delle-delusioni_5e948abc-f148-11df-8c4b-00144f02aabc.shtml |
|
|
|
|
 Registrato
Registrato
|
|
|
|
|
Admin
Utente non iscritto
|
 |
« Risposta #108 inserito:: Novembre 29, 2010, 11:51:18 am » |
|
RAZIONALITÀ POLITICA ED ECONOMICA L'editoriale Diciamo la verità sulla crisi Se si leggono in controluce le tante analisi che gli economisti dedicano alla bufera che, dalla crisi greca a quella irlandese (ma Portogallo e Spagna sono già nel mirino), ha investito l'Europa monetaria, non è difficile scoprire quale sia oggi il vero nemico dell'euro, quello che ne minaccia la sopravvivenza: questo nemico è rappresentato dalla perdurante vitalità della democrazia. Intendendo per tale l'unica democrazia che c'è, quella che, nonostante l'Europa, non si estende, continua a non estendersi, al di fuori dei confini nazionali. Sono le democrazie europee, necessariamente condizionate dagli orientamenti dei loro elettorati, a minacciare oggi la moneta unica. Quando si dice che fu la rigidità della cancelliera Angela Merkel, motivata dalla resistenza dell'elettorato tedesco a pagare per il malgoverno altrui, a fare precipitare la crisi greca e a trasformarla nel detonatore di una più vasta crisi dell'euro, si sta appunto dicendo che la democrazia entrò allora in rotta di collisione con le esigenze dell'Europa monetaria. Ed è ancora ai meccanismi democratici che si fa riferimento quando ci si interroga sull'eventualità che in Irlanda venga a mancare una maggioranza politica in grado di sostenere le misure di risanamento con effetti a catena sulla zona euro. O quando si attende col fiato sospeso una possibile sentenza della Corte costituzionale tedesca che dichiarando illegali i salvataggi dei Paesi in difficoltà tolga ogni residua difesa alla moneta unica. Quando si dice che l'Europa è la nostra «casa comune» si dice una cosa vera ma incompleta. Bisognerebbe infatti precisare che questa casa comune è in realtà un condominio con ventisette appartamenti. I condomini, pur essendo obbligati a convivere, considerano davvero «casa» solo il loro appartamento mentre il condominio ha valore ai loro occhi unicamente per i servizi che riesce a garantire a ciascun condomino. Come in tutti i condomini, hanno più onori e oneri i proprietari di appartamento che dispongono di più millesimi. E, come in tanti condomini, si litiga, si cerca di scaricare il più possibile sugli altri i costi dei servizi comuni. Come spesso accade, inoltre, i condomini più sciatti, meno virtuosi (quelli che danneggiano il giardino o dimenticano aperti i rubinetti dell'acqua provocando danni negli appartamenti vicini) cercano di scaricare, in tutto o in parte, i costi della loro sciatteria sui condomini virtuosi. L'immagine del condominio ci aiuta a mettere a fuoco un fatto che, parlando d'Europa, non bisognerebbe mai dimenticare, ossia la circostanza per cui i francesi, i tedeschi, e tutti gli altri (persino noi italiani), a oltre mezzo secolo dall'inizio del processo di integrazione europea, continuano a considerare la loro appartenenza nazionale molto più importante della loro comune appartenenza europea. Il «noi» Stato - nazionale (Francia, Germania, Spagna, eccetera) resta assai più sentito del «noi» Europa. E anche dove, come in Italia, le lacerazioni interne sono profonde (e lo stesso Stato unitario viene sempre più spesso messo in discussione) ciò non comporta affatto la sostituzione dell'identità nazionale con una identità europea. Per questo, le democrazie nazionali restano forti e vitali e il loro orizzonte non è al momento superabile. Va precisato, per coloro che tendono a confondere giudizi di fatto e giudizi di valore, che qui si sta constatando un fatto senza fare apprezzamenti. Dal momento che è una scelta saggia guardare ai fatti per come sono, anche quando non ci piacciono, piuttosto che girare la testa dall'altra parte. Possiamo spiegare la suddetta circostanza in vari modi. Possiamo vedervi il frutto di una eredità storica che continua a indirizzare le lealtà dei cittadini verso simboli nazionali. Oppure, possiamo spiegarla in termini di calcoli e convenienze: si preferiscono centri decisionali nazionali perché danno ai cittadini l'illusione di essere da loro più controllabili, e quindi più attenti ai loro interessi, rispetto a un lontano centro decisionale europeo. Comunque sia, resta che, stante la vitalità della democrazia nazionale, i leader devono continuare a rispondere ai loro elettori e che meccanismi democratici di centralizzazione delle decisioni e di legittimazione del potere a livello europeo non possono facilmente sostituirsi a quelli nazionali. È anche la ragione per la quale la Germania, frustrando l'aspettativa di tanti, non riesce ad essere il leader dell'Europa: un leader è tale se sa farsi carico delle esigenze degli altri, ma i governi tedeschi, come tutti i governi democratici, sono obbligati a mettere al primo posto le esigenze dei loro elettori. Quando nacque l'euro tutti pensarono che esso non avrebbe retto nel lungo periodo senza un salto di qualità sul piano dell'integrazione politica. L'euforia di quei giorni spinse però molti a scommettere che sarebbe stata proprio la moneta unica, in virtù dei benefici che era in grado di dispensare, a fare prima o poi il miracolo, a obbligare gli europei a crearle un contraltare, o un contenitore, politico. Fu un calcolo sbagliato. Se le cose stanno così, per salvare l'euro, dovremo inventarci cose diverse da quelle che di solito vengono proposte. È inutile continuare a inseguire il miraggio degli Stati Uniti d'Europa, di una democrazia continentale che oggi (per il futuro si vedrà) gli europei non vogliono e non chiedono. Meglio, senza ipocrisie, fare appello alle convenienze: conviene a tutti, anche agli elettori tedeschi, che l'euro non affondi. E sperare che, passata in un modo o nell'altro la nottata, si ricostituisca la compatibilità, oggi perduta, fra la razionalità politica (democratica) e la razionalità economica. Angelo Panebianco 28 novembre 2010© RIPRODUZIONE RISERVATA http://www.corriere.it/editoriali/10_novembre_28/panebianco_75bbd4e4-fac5-11df-abbf-00144f02aabc.shtml |
|
|
|
|
 Registrato
Registrato
|
|
|
|
|
Admin
Utente non iscritto
|
 |
« Risposta #109 inserito:: Dicembre 05, 2010, 11:59:25 am » |
|
SCENARI PER IL 14 DICEMBRE Una proposta a Berlusconi Sull'Italia incombono in questo momento due crisi, una già in atto, politica, e una alle porte, istituzionale. La crisi politica, e lo spettro della crisi istituzionale, a loro volta, rischiano di innescare, a brevissimo termine, una terza crisi, di natura finanziaria. La crisi politica è legata al venir meno della maggioranza parlamentare senza che esista una credibile alternativa. La crisi istituzionale nasce dal fatto che la leadership di Silvio Berlusconi intorno alla quale, e contro la quale, si è fin qui organizzato l'intero sistema degli equilibri politici, non ha cambiato in quindici anni l'inadeguata architettura costituzionale della Repubblica: un assetto, ricordiamo, che si è tentato di riformare inutilmente per un trentennio, fin dai tempi in cui Bettino Craxi lanciò il progetto, poi fallito, della Grande Riforma. La leadership di Berlusconi, con la formidabile concentrazione di potere personale sempre contrastata, però, da fortissimi contropoteri, quello giudiziario in primo luogo che l'ha caratterizzata, ha fino ad oggi nascosto agli occhi dei più, sia fra i sostenitori che fra i suoi nemici, il problema istituzionale sottostante. Riassumibile in questi termini: non solo non esistono più i grandi partiti di massa che facevano da collante del sistema politico ma non esiste nemmeno alcun antidoto istituzionale che possa frenare, una volta uscito di scena Berlusconi, una frammentazione e una diffusione del potere incontrollate; un antidoto che possa impedire la formazione di governi di destra o di sinistra diversi, per coesione e capacità d'azione, dall'ultimo governo Prodi. In altri Paesi, dove le istituzioni favoriscono la formazione di governi stabili a prescindere dalle persone, l'uscita di scena di un leader non crea sconvolgimenti. E non è vero che la fine di un ciclo che ha visto al comando un leader forte sia sempre sanzionata da una sconfitta elettorale. Tanto Charles de Gaulle in Francia che Margaret Thatcher in Gran Bretagna lasciarono il potere senza sconfitta elettorale de Gaulle perse un referendum, non le elezioni quando venne meno il consenso di cui godevano, soprattutto presso le classi dirigenti. In Italia, per l'assenza di istituzioni in grado di garantire il passaggio delle consegne da un leader e da un governo forti a un altro governo altrettanto forte, le cose stanno diversamente. È questa condizione che fa della crisi politica in atto il detonatore probabile di una crisi istituzionale. E poiché i mercati finanziari ci vedono e ci sentono benissimo, questa doppia crisi ci mette nelle condizioni di essere tra le prossime vittime del terremoto che ha investito l'eurozona. Con una differenza rispetto agli altri Paesi già terremotati Grecia, Irlanda o sul punto di esserlo, una differenza che va a merito dell'azione svolta in questi anni dal governo in carica. Se finiremo nella morsa della crisi finanziaria non sarà perché il governo in carica ha mal governato l'economia. Sarà perché la crisi politico-istituzionale avrà aperto un varco che renderà possibile l'aggressione a un Paese oberato da un grande debito pubblico, da una fragilità economico-finanziaria che viene da lontano. Insomma, piove sul bagnato, la crisi politica non poteva presentarsi in una situazione internazionale peggiore. Berlusconi è chiuso nel bunker in attesa del fatidico 14 dicembre. Non ha un partito che possa imporgli di vedere ciò che non vuole vedere: ossia che, qualunque cosa accada il 14 dicembre, che egli non ottenga la fiducia o che la ottenga, sarà comunque in grossissimi guai. E il Paese con lui. Anche perché, dal punto di vista degli interessi del Paese, la data che più conta non è il 14 ma il 16 dicembre, quando si riunirà il Consiglio europeo per tentare di frenare lo smottamento in corso nell'Europa monetaria, per arginare il contagio. Se arriveremo all'appuntamento con un governo dimissionario o con un governo azzoppato, in sella solo per un paio di voti fortunosamente acchiappati, ci troveremo con la gola scoperta, pronta per essere azzannata, non potendo prendere impegni credibili che spengano la sete di sangue dei mercati. Il dilemma di Berlusconi, a meno che egli non abbia il coraggio di sparigliare le carte, è semplice: se verrà battuto otterrà forse le elezioni ma con forti probabilità di non riuscire a vincerle, per lo meno al Senato, stante la legge elettorale in vigore. In caso di elezioni, è più facile scommettere sull'ingovernabilità che sulla formazione di una maggioranza coerente. Se invece il 14 dicembre Berlusconi otterrà la fiducia, si tratterà di una vittoria illusoria. Non potrà guidare un governo stabile ed efficiente se lo scarto a suo favore risulterà di pochi voti. Con il 51 per cento non si governa, diceva Enrico Berlinguer. È ancora così (in Parlamento almeno) ed è una delle nostre maggiori patologie. Anche in caso di fiducia, Berlusconi non risolverebbe dunque il problema del governo. E allora che fare? È comprensibilissimo che Berlusconi voglia salvare una esperienza di governo che ha avuto, oltre ad aspetti negativi, anche diversi aspetti positivi. E che voglia anche difendere, in un Paese abituato ad adulare i vincitori e a calpestare i vinti, una esperienza politica personale che dura dal 1994. Ma se vuole tutto questo deve per forza uscire dal bunker. Deve avere il coraggio di offrire ai «terzopolisti», in nome dell'emergenza nazionale, un Berlusconi bis incardinato su poche e chiare proposte: oltre a mantenere l'impegno sul federalismo, deve assicurare interventi sull'economia (concordati sia con Tremonti che con Fini) che rassicurino i mercati e aprano vere prospettive di sviluppo. Deve offrire, inoltre, una disponibilità alla riforma elettorale: con l'unico vincolo che, a differenza di quelle fin qui ventilate, sia una riforma che salvaguardi il bipolarismo (cosa che Fini ha più volte detto di volere). E deve accantonare il tema della giustizia: non perché di una riforma della giustizia non ci sia bisogno (chi scrive pensa che sarebbe necessaria, eccome) ma perché è un fatto che Fini non la vuole e altri conflitti su quell'argomento, mentre il Paese rischia di incappare in una crisi finanziaria, risulterebbero incomprensibili agli italiani. Se poi la proposta verrà rifiutata, allora Berlusconi avrà almeno la possibilità di lasciare il terzo polo con il cerino acceso in mano, ad assumersi la responsabilità di una crisi al buio in un frangente così difficile. Quella qui immaginata ci sembra l'unica possibile scelta saggia per Berlusconi, l'unica che potrebbe forse fare uscire il Paese dal cul de sac in cui si trova. Bisognerebbe però che Berlusconi trovasse in sé quelle risorse di saggezza e di coraggio che i leader raramente trovano nella fase declinante del loro ciclo politico. Angelo Panebianco 05 dicembre 2010© RIPRODUZIONE RISERVATA http://www.corriere.it/editoriali/10_dicembre_05/una-proposta-a-Berlusconi-angelo-panebianco_51571bdc-0046-11e0-861f-00144f02aabc.shtml |
|
|
|
|
 Registrato
Registrato
|
|
|
|
|
Admin
Utente non iscritto
|
 |
« Risposta #110 inserito:: Dicembre 20, 2010, 02:31:36 pm » |
|
I LEADER E LE REGOLE DEL VOTO Le elezioni che verranno Lo sbocco politico dell'attuale situazione sembra inevitabile: elezioni a primavera, con il rischio che ci consegnino un Parlamento ingovernabile, senza una maggioranza stabile. Ma se gli attori che contano riuscissero a mettere da parte i tatticismi e a ragionare in termini strategici, ecco che potrebbe aprirsi una fase interessante, utile per il Paese. Dopo il «ritiro» per k.o. tecnico sul voto di fiducia di Gianfranco Fini, sono solo tre i lottatori rimasti in gara: Berlusconi, Bossi e Casini. Le loro scelte decideranno il futuro. Bossi vuole le elezioni? Sembra di sì, lo ha ripetuto ieri. Sa che avrebbe un forte successo elettorale ma, essendo un politico lungimirante, sa anche che correrebbe dei rischi. Se i consensi per il suo alleato Berlusconi franassero al Sud e si formasse una nuova maggioranza imperniata sui centristi e sulla sinistra, Bossi si troverebbe escluso dal governo, forse per un periodo lungo. La sua promessa di federalismo diventerebbe via via meno credibile agli occhi degli elettori leghisti. Se così è, la partita che più conta è quella fra Berlusconi e Casini. Casini ha un grosso problema: deve decidere cosa fare da grande, quando Berlusconi uscirà di scena. Essendo poco plausibile che voglia diventare il nuovo Prodi del centrosinistra, deve scegliere: vuole essere in permanenza il leader di una piccola formazione centrista che contratta di volta in volta con la destra e con la sinistra o vuole entrare in una gara per la leadership di un centrodestra alternativo alla sinistra? Vecchi riflessi democristiani lo spingono verso la prima opzione, la sua storia personale dovrebbe rendergli più attraente la seconda. Ma il presupposto di una gara per la leadership del centrodestra è che il centrodestra continui a esistere, che non si disgreghi. Anche Berlusconi ha un grosso problema. Non vuole solo vincere le prossime elezioni e al Senato, con questa legge elettorale, difficilmente potrà vincerle. Deve anche mettere in sicurezza il Popolo della Libertà, assicurarsi che la sua eredità politica non si disperda al vento quando l'età gli imporrà di ritirarsi. La soluzione, se c'è, passa per un cambiamento della legge elettorale sul quale possano incontrarsi, con diverse motivazioni, Berlusconi e Casini. Spetta a Berlusconi la prima mossa. Lui dovrebbe aprire le trattative. Ponendo però una condizione: che il bipolarismo venga preservato solo così potrà sopravvivere il centrodestra. Ciò significa chiedere a Casini, non di rinunciare al suo progetto neo-centrista, ma di ricalibrarlo, adattandolo a una condizione di perdurante bipolarismo. Casini potrebbe anche trarre ispirazione dalle sagge parole pronunciate recentemente su questi argomenti dal cardinale Camillo Ruini. Le proposte fino ad oggi formulate dagli avversari della legge elettorale vigente andavano tutte nel senso della archiviazione dell'esperienza bipolare/maggioritaria dell'ultimo quindicennio. Quella archiviazione è l'obiettivo dei proponenti del cosiddetto «sistema tedesco». Ma è anche lo scopo di proposte apparentemente più modeste. Ad esempio, chiedere di conservare la legge attuale ma con un premio di maggioranza che si ottiene solo superando una certa percentuale di voti il 40 o il 45 per cento significa voler far rivivere al Paese l'esperienza del 1953 quando non scattò quel premio di maggioranza, voluto da Alcide De Gasperi, che la propaganda antidemocristiana dell'epoca definiva «legge truffa». Significa voler dare vita a un sistema proporzionale da Prima Repubblica, mandare in cavalleria il bipolarismo, scompaginare centrodestra e centrosinistra. Significa puntare a un grande raggruppamento parlamentare «di centro» inamovibile, arbitro e protagonista - quale che sia, di volta in volta, il voto espresso dagli italiani - di qualunque possibile combinazione di governo. Non è un progetto lucido. Non può infatti offrire garanzie di stabilità al Paese. Essendo ormai svaniti i partiti di massa, radicati nella società, che facevano da collante alla Prima Repubblica, il progetto neocentrista ci consegnerebbe un Parlamento allo sbando, un ritorno alle pratiche trasformiste del parlamentarismo ottocentesco, una maionese impazzita. Casini è troppo accorto per non rendersene conto. Per questo, potrebbe riconsiderare le sue idee in materia elettorale se Berlusconi facesse una buona proposta. Berlusconi, dando retta ai fautori da sempre di questa soluzione come Marco Pannella e Mario Segni, dovrebbe farsi promotore del ritorno ai collegi uninominali e di una riforma compiutamente maggioritaria. Non dovrebbe farsi bloccare dalla vecchia idea secondo cui i collegi uninominali sarebbero poco adatti al centrodestra dal momento che esso dispone di un personale politico meno esperto, meno spendibile nei collegi uninominali, di quello di cui dispone la sinistra. Sia perché, rispetto agli anni Novanta, il personale della destra è diventato più esperto sia perché, su questo stesso piano, la sinistra è assai meno forte di un tempo. Con i collegi uninominali, destra e sinistra se la giocherebbero alla pari. In astratto, le scelte possibili sono tre. La prima è il maggioritario a un turno (il sistema britannico). Ma quel sistema piace solo a chi scrive e a pochi altri. Non è una opzione praticabile. Restano allora due possibilità: un maggioritario a doppio turno di tipo francese (con una soglia di esclusione alta fra primo e secondo turno) oppure quella variante del sistema elettorale australiano di cui chi scrive ha già dato conto ai lettori del Corriere il 12 ottobre scorso. È, quest'ultima, una proposta suggerita da un gruppo di lavoro coordinato da Pietro Ichino (Pd) e a cui Stefano Ceccanti (anche lui del Pd) ha dato recentemente forma in un progetto di legge presentato al Senato: un maggioritario a turno unico ma con la facoltà per l'elettore di esprimere due voti anziché uno soltanto (una prima e una seconda scelta). Evitando i tecnicismi e detto in modo un po' approssimativo: in ciascun collegio vince il seggio il candidato che ottiene la maggioranza assoluta sommando prime e seconde scelte. Con l'uno o l'altro sistema verrebbe preservato il bipolarismo ma le seconde e terze forze avrebbero buone chance di affermazione. Berlusconi disporrebbe di uno strumento più adatto della legge elettorale attuale per affrontare le prossime elezioni e metterebbe in salvo la sua eredità politica. Casini, a sua volta, potrebbe aspirare, per questa via, a svolgere in futuro un ruolo simile a quello che ebbe in Francia Giscard d'Estaing anziché ritrovarsi nella condizione dell'involontario genitore di un neotrasformismo parlamentare ormai fuori tempo massimo. Angelo Panebianco 19 dicembre 2010© RIPRODUZIONE RISERVATA http://www.corriere.it/editoriali/10_dicembre_19/panebianco_le-elezioni-che-verranno_e448412e-0b49-11e0-bf9a-00144f02aabc.shtml |
|
|
|
|
 Registrato
Registrato
|
|
|
|
|
Admin
Utente non iscritto
|
 |
« Risposta #111 inserito:: Dicembre 29, 2010, 10:43:11 am » |
|
L'EDITORIALE La nostalgia dei conservatori di sinistra C'è qualcosa che accomuna l'opposizione della Fiom all'accordo Fiat-sindacati su Mirafiori e quella del Partito democratico alla riforma Gelmini dell'università, appena varata dalla maggioranza di governo. Sono le due più recenti manifestazioni di quella strenua difesa dello statu quo in qualunque ambito della vita sociale, politica, istituzionale, che è ormai da tempo la più evidente caratteristica della sinistra italiana, nella sua espressione sindacale come in quella politico-parlamentare. Si tratti di scuola, di rapporti di lavoro, di magistratura, di revisioni costituzionali o quant'altro, non c'è un settore importante della vita associata in cui il conservatorismo della sinistra non si manifesti con forza. Forse ciò aiuta a spiegare una circostanza che sarebbe altrimenti incomprensibile: il fatto che l'opposizione di sinistra non si sia minimamente avvantaggiata in questi anni, stando ai sondaggi, delle gravi difficoltà di un governo che ha dovuto fronteggiare le conseguenze della crisi mondiale e che è stato inoltre investito da scandali e furibonde divisioni. Tanto è vero che tutti continuano a prevedere, in caso di elezioni, una vittoria (quanto meno alla Camera) del centrodestra. La domanda che la sinistra italiana dovrebbe porsi è la seguente: perché nemmeno la forte disillusione di tanti italiani nei confronti di Berlusconi, il fatto che ormai più nessuno creda nella «rivoluzione liberale» sempre promessa e mai attuata spostano a sinistra l'asse politico del Paese? Può essere che la risposta giusta sia la seguente: dovendo scegliere fra ciò che ritiene un male (Berlusconi) e ciò che ritiene un male ancora maggiore (la sinistra), il grosso degli italiani continua a optare per la minimizzazione del danno, per il male minore. Una delle ragioni, forse, è che, tolta una cospicua ma minoritaria area di conservatori a oltranza, la maggioranza relativa degli italiani pensa che stare fermi condannerebbe il Paese alla decadenza economica e sociale e che risposte magari insufficienti, o anche sbagliate, ai problemi collettivi, siano comunque preferibili alle non risposte. Ci sono due modi per fare opposizione a un governo. Il primo consiste nel contrapporre ai progetti governativi di modifica più o meno profonda dell'esistente, proposte diverse, che ovviamente si giudicano migliori, di modifica altrettanto o anche più profonda. Il secondo consiste nel difendere l'esistente. Quest'ultima è stata la scelta della sinistra in quasi tutti i campi di interesse collettivo. Ne è derivata una paurosa mancanza di idee nuove sul che fare, una mancanza di idee che ha fatto subito appassire la rosa appena sbocciata del Partito democratico. Non è facile ricostruire le cause del conservatorismo della sinistra. Forse, una delle più importanti, è l'evidente nostalgia per la cosiddetta Prima Repubblica, che poi altro non è se non nostalgia per i tempi in cui la sinistra era rappresentata da un grande partito il Pci, rispettato e temuto da tutti, capace, pur dalla opposizione, di influenzare potentemente la vita pubblica e i costumi collettivi. Non avendo mai fatto davvero i conti con la storia comunista, la sinistra italiana, o ciò che ne resta, non ha saputo nemmeno fare i conti con tutto ciò che non andava nella Prima Repubblica. Ha finito per idealizzarla. Solo così si spiega il fatto che la sua opposizione alla destra sia sempre stata improntata al seguente ritornello: sono arrivati i barbari, i quali stanno distruggendo tutto ciò che di buono avevamo. Ma davvero era così buono ciò che avevamo? No, non lo era. Quasi tutti i problemi che ci attanagliano oggi (ne cito tre: debito pubblico, cattiva qualità dell'istruzione, cattivo funzionamento della giustizia) sono il frutto di pessime scelte della troppo mitizzata classe politica della Prima Repubblica, almeno dagli anni Settanta in poi. Il punto è che quella mal riposta nostalgia ha finito per alimentare una ideologia conservatrice, che si traduce nella pura e semplice difesa dalle minacce portate dai barbari di ciò che la Prima Repubblica ci ha lasciato in eredità. C'è poi, certamente, a spiegazione del conservatorismo, una ragione più generale. Fronteggiare i nuovi problemi, dall'invecchiamento della popolazione alla immigrazione, alla accresciuta competizione internazionale, significa dare risposte creative che rimettano in discussione molte soluzioni del XX secolo che si ritenevano a torto definitivamente acquisite. Non essendo in grado di trovare risposte creative, la sinistra si è ridotta a giocare solo sulla difensiva. C'è chi pensa che il conservatorismo della sinistra venga da lontano, sia una eredità di quella incapacità di fare i conti con la modernità che caratterizzava il vecchio Partito comunista: fu proprio in polemica col Pci, oltre che con la Dc, che i socialisti craxiani si appellarono allora a una idea di modernità che avrebbe dovuto far circolare in Italia aria nuova. Ma è vero che ci sono stati anche momenti (diverse importanti decisioni del primo governo Prodi ne sono un esempio) in cui la sinistra ha saputo, sia pure con fatica, uscire dal recinto della conservazione sociale. E, comunque, non ha mai potuto perseguire la vocazione conservatrice, sua o del suo elettorato, senza pagare il prezzo di aspri conflitti interni. Ciò forse spiega anche la sua nota schizofrenia: finché si tratta di gestire, assieme alla maggioranza, nel chiuso delle commissioni parlamentari, certi provvedimenti, la sinistra può anche esibire fervore riformista. È costretta però a metterlo da parte (il caso della riforma Gelmini è esemplare) non appena deve fare i conti con le sollecitazioni della parte più chiusa e conservatrice del suo elettorato. Forse il discorso di Walter Veltroni al Lingotto, con il quale si inaugurò la segreteria del neonato Partito democratico, è stato l'ultimo tentativo (poi fallito come a suo tempo fallì il tentativo craxiano) di disegnare i contorni di una sinistra non conservatrice. Dopo di che, il nulla. In altri Paesi, sinistre messe alle corde sono state capaci di reagire e di rinnovarsi, di inventarsi idee nuove e proposte. La sinistra italiana ne sembra incapace. Continua a denunciare i barbari per evitare di parlare a se stessa e al Paese di progetti per il futuro. Angelo Panebianco 29 dicembre 2010© RIPRODUZIONE RISERVATA http://www.corriere.it/editoriali/10_dicembre_29/la-nostalgia-dei-conservatori-di-sinistra-angelo-panebianco_e5574c82-1318-11e0-8894-00144f02aabc.shtml |
|
|
|
|
 Registrato
Registrato
|
|
|
|
|
Admin
Utente non iscritto
|
 |
« Risposta #112 inserito:: Gennaio 06, 2011, 05:27:21 pm » |
|
Il commento Luoghi comuni tra Nord e Sud Umberto Bossi ha indicato date precise: fra il 17 e il 23 gennaio deve passare il «federalismo», ossia il decreto attuativo più importante, sul fisco municipale. Altrimenti, non resterà che il voto. La scissione dei finiani non è stata in grado di abbattere il governo ma lo ha reso debolissimo nelle Commissioni parlamentari della Camera. Non è facile che il provvedimento passi. Soprattutto, non è facile che passi senza stravolgimenti e senza dilatazione delle spese. Dalle notizie che circolano, sembra inoltre che non ci sia al momento la disponibilità del ministro Giulio Tremonti ad accettare le condizioni (quoziente familiare, cedolare secca sugli affitti) poste dall'Udc di Pier Ferdinando Casini per votare a favore. I giochi sono aperti e tutto da qui alla fine di gennaio può accadere. Per dare un giudizio fondato su che cosa sarà davvero (se sarà) il federalismo in Italia bisognerà aspettare di vedere quale provvedimento, con quali caratteristiche, verrà alla fine varato. Gli esperti sono al momento divisi, danno giudizi discordanti. C'è chi parla di tradimento delle intenzioni federaliste originarie, chi pensa che tutto si risolverà in una partita di giro, un passaggio di mano fra centro e periferia dell'esazione dei tributi, congegnato in modo da non favorire la responsabilizzazione fiscale degli enti locali, e chi invece sostiene che, per l'essenziale, ciò che si sta per varare sia autentico federalismo fiscale. Se guardiamo alle condizioni politiche generali dobbiamo osservare come esse non siano affatto favorevoli alla complessa trasformazione denominata «federalismo fiscale». Il rischio più forte è che ne esca ulteriormente esasperata la divisione fra Nord e Sud. Si considerino i fatti: o il federalismo fiscale sarà una cosa seria, e allora comporterà tagli drastici alle capacità di spesa di molti comuni del Sud (oltre che di qualche comune del Nord), o questo non avverrà e sarà allora una farsa, una partita di giro appunto. Ma se tagli drastici alle capacità di spesa degli enti locali del Sud ci saranno, come sarà possibile conservare il consenso politico necessario nel lungo arco di tempo richiesto per portare il federalismo a regime? Se sarà solo una partita di giro, le regioni produttive del Nord si sentiranno prese in giro e si accentuerà il loro distacco politico-psicologico dal Sud. Se sarà una cosa seria, provocherà probabilmente la rivolta politica di ampia parte del Sud. Il federalismo richiederebbe una collaborazione senza remore fra le varie aree del Paese, una disponibilità a rimettersi in gioco dove è maggiore il ristagno economico e il fardello di politiche sbagliate unita alla assenza di atteggiamenti inutilmente punitivi da parte delle regioni più produttive e ricche. Collaborazione e disponibilità che non ci sono state. I segnali, anzi, sono di segno opposto. Sono di questi giorni le notizie sulle massicce assunzioni di precari da parte della giunta Lombardo in Sicilia. Nel rigoroso rispetto della tradizione. Ancora qualche anno fa si poteva immaginare il coinvolgimento del Sud in un percorso virtuoso di risanamento, la sua disponibilità a uno scambio fra meno risorse oggi e più sviluppo domani. Adesso che sono sorte varie Leghe Sud, quella ipotesi è meno credibile. Comunque vada l'iter parlamentare, si può scommettere che le prossime elezioni si giocheranno già tanti scaldano i muscoli a destra e a sinistra sul pericoloso crinale che contrappone Nord e Sud. Angelo Panebianco 06 gennaio 2011© RIPRODUZIONE RISERVATA http://www.corriere.it/editoriali/11_gennaio_06/luoghi-comuni-tra-nord-e-sud--angelo-panebianco_b30f9e12-195a-11e0-b4e1-00144f02aabc.shtml |
|
|
|
|
 Registrato
Registrato
|
|
|
|
|
Admin
Utente non iscritto
|
 |
« Risposta #113 inserito:: Gennaio 27, 2011, 05:17:36 pm » |
|
LA FORZA DI CHI NON COMPETE I Nemici della Crescita Due giorni fa il presidente Giorgio Napolitano ha esortato la politica ad assumere come obiettivo prioritario l'impegno a sostenere la crescita economica. Ma la politica è al momento troppo distratta da altre cose per dare a quell'appello l'importanza che merita. Inoltre, in una società abituata da troppo tempo a livelli di crescita più bassi dei propri dirimpettai e concorrenti si fatica a comprendere che assenza di sviluppo o sviluppo stentato configurano una vera e propria emergenza nazionale, finiscono alla lunga per avere conseguenze disastrose per qualsiasi società. Non importa quanto quella società sia ricca. Senza crescita, una società consuma più ricchezza di quanta ne produca e finisce su un piano inclinato al termine del quale ci può essere solo un impoverimento complessivo con gravi effetti sociali e gravi contraccolpi politici. Per rilanciare lo sviluppo devono essere soddisfatte due esigenze: la prima riguarda il mondo delle imprese e il comportamento degli attori che operano in quel mondo, imprenditori e sindacati. La seconda riguarda le pratiche e i comportamenti di tutti gli altri attori sociali, politici e istituzionali. La prima esigenza è che i comportamenti dei soggetti dell'impresa siano coerenti con le condizioni in cui si svolge la concorrenza di mercato. L'azione dell'amministratore delegato Fiat Sergio Marchionne, i referendum a Pomigliano e a Mirafiori, e la spaccatura fra la Fiom e gli altri sindacati hanno innescato una reazione a catena che sta investendo le relazioni industriali nel loro complesso, i soggetti che le animano, nonché, in prospettiva, i rapporti fra quei soggetti e la politica. Le nuove condizioni della competizione nel mercato globale - la cosiddetta, e malamente detta, globalizzazione - fanno saltare le vecchie pratiche «neo-corporative» (le varie forme di concertazione centralizzata a livello nazionale) e inevitabilmente cambiano anche la natura dei soggetti organizzati in campo, dalla Confindustria ai sindacati. Questi ultimi si dividono, forse definitivamente, fra quelli che accettano la sfida della competizione globale (e che puntano ad avere più salario in cambio di più produttività) e quelli che non la accettano e per questo rilanciano l'antica contrapposizione frontale fra capitale e lavoro. Dal punto di vista dell'interesse collettivo la ristrutturazione in atto sembra andare nella direzione giusta: attrezzando le imprese per la competizione globale essa spinge sul pedale della crescita. Però, che il mondo delle imprese si dia da fare per competere sui mercati globali è solo una condizione necessaria per rimettere in moto lo sviluppo. Non è affatto una condizione sufficiente. Occorre anche che gli altri attori societari, quelli non direttamente esposti alla competizione, adeguino i loro comportamenti. Ciò è molto più difficile perché questi attori, a differenza delle imprese, hanno un rapporto mediato, e non diretto, con il mercato e le sue dure regole competitive. Soffrono anch'essi della mancanza di crescita ma non operano in prima linea: lavorano nelle retrovie, non hanno una visione diretta e immediata di ciò che accade al fronte. Protestano quando si accorgono che non ci sono più soldi per investimenti nei servizi o si oppongono ai tagli ma, in genere, non mettono in relazione la mancanza di risorse con il mancato o debole sviluppo. Le ragioni per cui un Paese smette di crescere possono essere tante ma una delle migliori spiegazioni fa leva sul ruolo dei vested interests, degli interessi costituiti che danno vita a forti «coalizioni distributive», tese, cioè, a distribuire la ricchezza esistente anziché ad allargare la torta della ricchezza. Secondo questa interpretazione un Paese smette di crescere o ha una crescita troppo bassa quando le coalizioni distributive presenti sono più forti delle coalizioni produttive, di coloro che hanno interesse allo sviluppo. Per Mancur Olson, l'economista che propose questa interpretazione, così si spiega il fatto che negli anni Cinquanta il Giappone, l'Italia e la Germania abbiano sperimentato un boom economico mentre, nello stesso periodo, la Gran Bretagna arrancava penosamente. In quei tre Paesi la guerra non si era limitata a distruggere le infrastrutture materiali. Ne aveva anche distrutto le infrastrutture sociali, spazzando via le preesistenti coalizioni distributive. In Gran Bretagna ciò non era accaduto. Da qui la differenza. Colpire rendite e mercati protetti è difficilissimo perché significa indebolire coalizioni distributive che nel nostro Paese sono diventate col tempo assai potenti. La loro forza era la principale causa della debole crescita economica anche prima che scoppiasse la crisi mondiale. Finita la crisi, se non si agirà per ridimensionarle, la condizione di bassa crescita persisterà. Se l'obiettivo prioritario deve essere lo sviluppo economico, allora ogni intervento di riforma va finalizzato allo scopo. Prendiamo il caso del federalismo. Se ben congegnato, in teoria, può responsabilizzare i territori nell'uso del denaro pubblico, ridurre lo spazio per il consumo parassitario di risorse. Se fosse mal congegnato darebbe ragione a chi (Dario Di Vico, sul Corriere di ieri; Mario Deaglio sulla Stampa del 24 gennaio) teme effetti esattamente contrari: innalzamento della pressione fiscale, nuove opportunità di sfruttamento della ricchezza prodotta da parte di ceti parassitari locali: un rafforzamento, anziché un indebolimento, delle già forti coalizioni distributive. Sarà in grado la classe politica di fare una riforma federalista credibile da questo punto di vista? Se non serve allo scopo, allora è davvero meglio lasciar perdere. Angelo Panebianco 27 gennaio 2011© RIPRODUZIONE RISERVATA http://www.corriere.it/editoriali/11_gennaio_27/panebianco-nemici-della-casta_1e853924-29da-11e0-88f8-00144f02aabc.shtml |
|
|
|
|
 Registrato
Registrato
|
|
|
|
|
Admin
Utente non iscritto
|
 |
« Risposta #114 inserito:: Febbraio 03, 2011, 06:39:28 pm » |
|
L'Occidente si illude di contare
Barack Obama sarà ricordato come un nuovo Jimmy Carter, il presidente che «perse» l’Iran, che subì la rivoluzione khomeinista del 1979? Forse, ma l’ironia sta nel fatto che se questo sarà il suo destino, non sarà lui a forgiarlo, non dipenderà da lui. Dipenderà da come evolverà la situazione in Egitto e negli altri Paesi mediorientali in ebollizione. Nonostante tanti commenti che in Occidente sostengono il contrario, è davvero poco ciò che l’America, per non parlare dell’Europa, può fare in questo frangente. Il destino dell’Egitto è in larghissima misura alla mercé delle scelte che prenderanno, in risposta ai moti popolari, gli attori egiziani che contano. Più che «auspicare » e «suggerire» (e tenere incrociate le dita) gli occidentali non possono fare. Per aver chiara quale sia la reale capacità di incidenza dell’America basti pensare al Pakistan: sia sotto Bush che sotto Obama l’America lo ha ricoperto di dollari senza però mai ottenere che esercito e servizi segreti pachistani smettessero di appoggiare i talebani.
È un aspetto della sopravalutazione delle capacità di controllo degli eventi da parte degli occidentali anche la discussione sulla mancata previsione di cosa stava accadendo. Che «prima o poi» le dittature, anche quelle che sembrano più solide, cadano, è inevitabile. Ma nessuno può pronosticare quando prima e quando poi. Molto spesso le dittature hanno una vita lunghissima. Non raramente sopravvivono anche alle crisi di successione.
L’unica cosa che, in termini molto generici, si poteva prevedere, e che difatti era stata ampiamente prevista, è che la crisi economica mondiale avrebbe alla lunga destabilizzato, qua e là, diversi regimi dittatoriali. La ragione è semplice: le dittature si garantiscono la stabilità «pagando in contanti» l’acquiescenza, distribuendo a cascata risorse a settori strategici della popolazione (è anche la ragione per la quale in quei regimi lo Stato è massicciamente presente nella economia). La crisi mondiale, riducendo il flusso di risorse, aveva ottime probabilità di gonfiare in diversi luoghi malcontento e opposizione facendo emergere per di più il peso della corruzione.Ma nessuno (nemmeno gli specialisti, gli studiosi dei singoli Paesi) era in grado di dire dove e quando sarebbero esplose proteste così forti da far cadere il regime. La slavina, partita dalla piccola Tunisia, ha investito l’Egitto, ma anche altri Paesi, come Algeria, Giordania, Yemen, sono coinvolti. Poiché l’Egitto è il più importante Stato dell’area, è sull’intero Vicino e Medio Oriente che la sua evoluzione interna inciderà. Il mondo occidentale vive questi eventi in preda a una profonda incertezza. Il Medio Oriente è da sempre il suo nervo scoperto, il suo tallone d’Achille: perché lì c’è Israele, perché lì c’è il petrolio, perché lì ci sono alcuni fra i suoi più inflessibili nemici. Se l’auspicio degli iraniani si realizzasse, se le forze dell’islamismo radicale prevalessero nei principali Stati dell’area (che accadrebbe il giorno in cui quelle forze riuscissero a vincere in Arabia Saudita?) sarebbe per tutti noi un disastro di proporzioni inimmaginabili.
Se si può fare poco per condizionare gli eventi, che almeno quel poco non consista di plateali errori. Obama ne ha già fatti quando, in polemica con la politica del suo predecessore, ha demoralizzato gli oppositori democratici del regime di Mubarak e di altre dittature mediorientali, togliendo ai gruppi interessati alla democrazia appoggio morale e finanziario. È evidente che una democratizzazione dell’Egitto e di altri Paesi dell’area è auspicabile. Non solo perché le persone vivono molto meglio nelle democrazie che nelle dittature. Anche perché le democrazie stabili (se e quando riescono a diventare stabili), a meno che non debbano lottare per la sopravvivenza, non esportano, in genere, troppa aggressività. Ma la democratizzazione è un processo difficilissimo. Può finire nel caos. Oppure, attraverso la democratizzazione, possono arrivare al potere forze illiberali (Hamas vinse regolarmente le elezioni a Gaza). In un contesto esplosivo come il Medio Oriente l’avvento di democrazie illiberali non significa pace ma guerra e catastrofi. L’incertezza occidentale ha dunque buone giustificazioni.
Tra gli errori che bisognerebbe evitare c’è anche quello di cadere nelle trappole propagandistiche che vengono tese da chi ha interesse a confondere ancor di più il già confuso mondo occidentale. È già cominciata sui mass media una operazione pubblicitaria tesa a «vendere» i Fratelli musulmani come un interlocutore tutto sommato accettabile per noi. In fondo, si dice, a differenza di Al Qaeda, non mettono (più) bombe. Ma il fatto che non mettano più bombe, che abbiano da tempo rinunciato alla violenza, non ne fa affatto un interlocutore. Ideologicamente non sono diversi da Al Qaeda e una loro vittoria finale in Egitto (possibile — esercito permettendo — essendo la Fratellanza l’unica forza politica ramificata e organizzata della società egiziana) configurerebbe precisamente un esito illiberale in grado di spostare in senso antioccidentale l’asse dell’intero Medio Oriente.
Se alla fine, sciaguratamente, prenderanno il potere o avranno comunque una forte influenza su di esso, bisognerà per forza cercare di venirci a patti. Ma, almeno, evitiamo di insultare la nostra intelligenza accettando di considerarli una «forza democratica » o giù di lì.
Gli esiti della trasformazione in corso incideranno sugli equilibri mondiali. A cominciare dai rapporti fra Stati Uniti ed Europa. Se gli esiti saranno positivi, se, ad esempio, il post Mubarak si risolverà in una transizione controllata verso un assetto stabile e meno opprimente del regime oggi in crisi, tutto bene. Ma se dovessero vincere in Egitto e altrove forze islamiche radicali, è facile scommettere che fra America ed Europa crescerebbero incomprensioni e divisioni. Nonostante l’oscillante Obama, l’America dovrebbe per forza scegliere una linea di contrasto. Per fare quadrato in difesa di Israele e per difendere i propri interessi strategici. L’Europa, che ama poco Israele, e che è debole e spaventata, faticherebbe assai a seguirla.
Angelo Panebianco
03 febbraio 2011© RIPRODUZIONE RISERVATA
da - corriere.it/editoriali/11_febbraio_03
|
|
|
|
|
 Registrato
Registrato
|
|
|
|
|
Admin
Utente non iscritto
|
 |
« Risposta #115 inserito:: Febbraio 15, 2011, 10:51:19 am » |
|
L'ONDA DELLA RIVOLTA
La loro libertà, le nostre paure
Ha osservato giustamente Sergio Romano (Corriere, 13 febbraio) quanto sia paradossale il fatto che gli occidentali, gioendo per la cacciata di Mubarak, si siano trovati ad applaudire un colpo di Stato militare. Ma non è il solo paradosso. C'è anche una particolare circostanza, al tempo stesso ironica e tragica (e anche, in qualche misura, «scandalosa»), che spiega l'atteggiamento ambivalente degli occidentali verso le rivoluzioni mediorientali, e che può essere così riassunta: come possiamo toglierci dalla testa il «cattivo pensiero» secondo cui, nel complicato contesto mediorientale, dittature corrotte e repressive siano state comunque una garanzia di pace, sia pure precaria, e che la (eventuale) democratizzazione di quei regimi, egiziano in testa, possa sfociare nella guerra? Da un lato, come si può non solidarizzare con le persone, per esempio con quei tanti ragazzi, scese coraggiosamente in piazza per chiedere libertà? Abbiamo fatto benissimo a solidarizzare con loro. Se non lo avessimo fatto, avremmo mostrato di non credere nei valori di libertà in cui diciamo di credere. E, inoltre, come indicano anche le notizie degli scontri in corso in Iran, il contagio democratico potrebbe (ma il condizionale è d'obbligo) riaprire i giochi perfino nel più pericoloso Stato teocratico. Dall'altro lato, come è possibile incanalare i processi in corso in modo che i cambiamenti di regime non siano il detonatore di nuove guerre?
Tra le cose che sappiamo sulle democrazie c'è il fatto che, una volta che si siano stabilizzate, difficilmente si faranno la guerra fra loro. Non è che siano sempre più pacifiche dei regimi autoritari. Sappiamo solo che raramente le democrazie stabili si aggrediscono. Da qui l'idea, visionaria e utopica, secondo cui in un mondo composto esclusivamente di democrazie stabili, la guerra scomparirebbe. Si badi che questa idea non è rimasta relegata nel chiuso delle discussioni accademiche. Ha ispirato anche l'azione di diversi presidenti americani, da Woodrow Wilson a Ronald Reagan, da Bill Clinton a George Bush jr. Se la democrazia liberale, o qualcosa che vi si avvicini, prevarrà nel mondo islamico, pensavano, ad esempio, i neoconservatori raccolti intorno a Bush, la regione verrà pacificata, non ci saranno più attentati come quello dell'11 settembre, e persino la pace fra Israele, palestinesi e mondo arabo diventerà possibile.
Le cose sono però più complicate. Ci sono due precisazioni da fare. La prima è che se le democrazie stabili tendono ad instaurare fra loro rapporti pacifici, la regola non vale per i regimi in transizione verso la democrazia. Anzi, esistono prove del fatto che i regimi in via di democratizzazione possano essere particolarmente aggressivi anche verso i vicini democratici. Fin quando la democrazia non si stabilizzerà, è alto il rischio che le neo-élite uscite dalle prime libere elezioni incanalino verso un nemico esterno le tensioni che sempre accompagnano i cambiamenti di regime. Croazia e Serbia erano Paesi in via di democratizzazione all'epoca delle loro guerre.
La seconda precisazione è che i processi di democratizzazione non sfociano necessariamente in democrazie liberali. Spesso generano democrazie illiberali, regimi ibridi che mettono insieme istituti liberali (elezioni più o meno libere) e istituti illiberali (regole emergenziali finalizzate alla repressione degli oppositori). Una democrazia illiberale può essere estremamente aggressiva verso l'esterno, più aggressiva di certi regimi puramente autoritari.
Se applichiamo al contesto egiziano queste considerazioni, possiamo constatarne la rilevanza. I militari si sono affrettati a rassicurare il mondo sul mantenimento del trattato di pace con Israele. Ma come possono garantire che questa condizione permarrà anche dopo libere elezioni, dopo l'installazione di un governo democratico in un Paese ove, come in tutte le piazze arabe, l'ostilità per Israele è radicata da decenni nel popolo? Tra l'altro, i trattati di pace, pur formalmente in vigore, possono essere abrogati di fatto: ad esempio, un governo democratico, che dovrà comunque fare i conti con una forte presenza parlamentare dei Fratelli musulmani, continuerà, come la dittatura di Mubarak, a collaborare con Israele nel contrasto alle azioni belliche di Hamas a Gaza? È lecito dubitarne.
Si consideri un altro aspetto. La dittatura egiziana ha goduto per decenni dell'appoggio americano ed europeo. Nonostante Obama e gli altri occidentali si siano alla fine sganciati da Mubarak, il ricordo di quell'appoggio non può essere facilmente cancellato dalle menti degli egiziani. I leader che andranno a cercarne il voto in libere elezioni dovranno tenerne conto. È possibile, se non probabile, che la democratizzazione si accompagni, almeno all'inizio, a una forte affermazione di correnti antioccidentali e antiisraeliane. Con conseguenze geo-politiche facili da immaginare.
Si deve dunque sperare nella lungimiranza dei militari egiziani? In realtà, bisogna sperare nella gradualità dei processi in corso. Ad esempio, abbiamo ormai scoperto (anche grazie alle vicende afghane e irachene) che le elezioni libere devono essere il coronamento del processo di democratizzazione, il punto di arrivo, non di partenza. Prima, bisogna consolidare le istituzioni in grado di limitare i poteri del governo (corti costituzionali e altri contrappesi) nonché togliere gli infiniti vincoli, legali e burocratici, che gravano sulle libertà personali degli individui. Solo dopo il completamento di questo laborioso percorso, si potrà ragionevolmente sperare che libere elezioni non sfocino in democrazie illiberali, minacciose per i cittadini e per la pace.
Hanno ragione coloro che sostengono che la democrazia possa benissimo conciliarsi con la religione musulmana (come provano diversi regimi democratici esistenti nel mondo islamico) e che, anche in quel mondo, la democrazia, se ben consolidata, sia in grado di tenere a bada i fanatici. Ma il percorso che porta alla stabilizzazione delle democrazie, e al godimento dei loro buoni frutti, è lungo, accidentato e costellato di pericoli. La consapevolezza di ciò spiega l'ambivalenza occidentale.
Angelo Panebianco
15 febbraio 2011© RIPRODUZIONE RISERVATA
da - corriere.it/editoriali
|
|
|
|
|
 Registrato
Registrato
|
|
|
|
|
Admin
Utente non iscritto
|
 |
« Risposta #116 inserito:: Febbraio 21, 2011, 10:46:45 am » |
|
LA DEBOLE IDENTITA' DELLA SINISTRA
Il commento
Gli alleati immaginari
Nonostante i dinieghi del governo, il mondo politico continua a scommettere sulle elezioni anticipate. In tal caso, quali schieramenti si confronteranno? Sappiamo già quale sarà l'identità del centrodestra: lo guiderà di nuovo Berlusconi in alleanza con Bossi. È più confuso, al momento, il quadro dello schieramento opposto. Una volta scartata l'ipotesi, inverosimile e perdente, della «santa alleanza» di tutti gli antiberlusconiani, restano poche opzioni. Uno schema che circola, anche se smentito da alcuni dei diretti interessati, punta a mettere insieme «terzo polo» e centrosinistra. Nel caso in cui il centrodestra non riuscisse a riconquistare la maggioranza, lo schema prevede Pier Ferdinando Casini premier, alleato al Partito democratico, senza Di Pietro e con il sostegno esterno dei neocomunisti di Nichi Vendola. Proponendo Rosy Bindi come candidato premier e quindi, implicitamente, rinunciando a dar battaglia per le primarie, Vendola sembra avere offerto (tacitamente) la sua disponibilità.
Il diavolo fa le pentole eccetera e gli «schemi di gioco», costruiti a tavolino, risultano in genere diversi dal gioco effettivo. Ma, per un momento, prendiamo per buono il suddetto schema. Per funzionare ha bisogno, fra l'altro, che Vendola non ottenga un exploit elettorale. Se questo fosse il caso sarebbe difficile tenerlo fuori dalla porta.
Qualche settimana fa, il vicesegretario del Pd Enrico Letta ha dichiarato che, a suo giudizio, il «fenomeno Vendola» si sgonfierà (Corriere, 16 gennaio). Ma è più probabile che Vendola sia destinato a un forte successo nel suo schieramento (nonostante la sua prova non certo brillante come amministratore della Puglia). Concorrono tre ragioni. La prima ha a che fare con la sua personalità. La seconda con le caratteristiche delle culture politiche della sinistra. La terza, infine, con le «circostanze», le condizioni in cui versa il Partito democratico.
Possiamo sorridere delle ardite affabulazioni di Vendola ma non possiamo negare che si tratti di un personaggio non banale, dotato di un suo spessore e che ciò ne spieghi le notevoli capacità mediatiche. Vendola parteciperà alla campagna elettorale contando su due carte. Mentre i Democratici parleranno soprattutto di Berlusconi (di come farlo fuori), Vendola parlerà soprattutto di politica. Inoltre, avrà il vantaggio dell'autonomia. Gli altri sono eterodiretti, la loro agenda (le cose da dire e da non dire) è di fatto ispirata prevalentemente da centri di potere esterni alla politica partitica (procure, giornali di riferimento). Vendola, invece, può decidere in autonomia la propria agenda. Capacità mediatiche, autonomia e volontà di parlare di politica potrebbero farlo spiccare come una macchia bianca su sfondo nero entro lo schieramento di sinistra. Tanto più in una campagna elettorale che, è certo, emarginerà quasi ogni tema che non riguardi la condotta privata del premier e sarà trasformata, da destra e da sinistra, in un referendum su «Berlusconi o le procure».
Poi ci sono i contenuti del messaggio di Vendola. Ho ascoltato con attenzione alcuni suoi discorsi e sono arrivato alla conclusione che la combinazione «orecchino più Marx», per dire un particolare mix di elementi emozionali e razionali, sia una formula di grande efficacia.
Da un lato, la poesia, l'affabulazione post-moderna, i discorsi sull'amore, che possono fare presa sui più giovani e, dall'altro, un anticapitalismo aggressivo ma aggiornato ai tempi, mondato (quasi del tutto) di quegli elementi «vetero» che erano ancora presenti nei ragionamenti del pur bravo Fausto Bertinotti. Parlando di «politica» piuttosto che di «etica» (per lo meno, nel senso triviale che questa parola ha assunto qui da noi), Vendola è in grado di lanciare messaggi ottimistici, di speranza, per il futuro. In questo è simile a Berlusconi. Salvo, naturalmente, il fatto che i loro messaggi ottimistici hanno contenuti opposti. In una cultura politica nella quale non è affatto scomparso il ricordo del comunismo, perché un aggiornato messaggio neo-comunista lanciato da uno che sa usare i media non dovrebbe avere successo? Quando Vendola dice, ad esempio, che la sinistra deve strappare alla destra la parola «libertà» e poi dà a quella parola il significato che le dava Marx, perché questo non dovrebbe piacere a certi elettori di sinistra più delle cupe parole d'ordine del giacobinismo giudiziario? Perché, posti di fronte alla scelta fra il Capitale e il Codice Penale, non dovrebbero scegliere il Capitale? Naturalmente, un successo di Vendola sarebbe escluso se il Partito democratico fosse in buona salute, se ci fosse in campo una credibile piattaforma di sinistra liberal-riformista. Il che non è: come indica anche l'emarginazione di fatto del leader riformista di maggior spessore che il Partito democratico abbia espresso al Nord, Sergio Chiamparino. Il Partito democratico è un progetto abortito e nemmeno i grossi guai di Berlusconi (o qualche punto percentuale in più del solito suggerito dai sondaggi) bastano a cambiare le cose. È abortito quando ha dichiarato il fallimento della vocazione maggioritaria, quando ha sostituito i discorsi sulle alleanze ai discorsi sui contenuti, quando si è messo a inseguire ogni sorta di massimalismo su per i tetti di Roma, quando non è stato capace di creare un abisso che lo separasse dai giustizialisti, quando, insomma, ha riconosciuto di non avere una proposta forte e autonoma, sostenuta da gente sicura di sé e delle proprie idee, da presentare al Paese. È fallito per le ragioni che il sindaco di Firenze Matteo Renzi richiama ormai ogni giorno. Naturalmente, in politica, nulla è definitivo. Ma occorrerebbe una nuova generazione di leader per ridare slancio al Partito democratico. La crisi di credibilità di quel partito, speculare, per motivi diversi, a quella di Berlusconi, dà a Vendola la possibilità di affondare i denti nelle sue carni. Di quella crisi di credibilità è anche parte la «eresia» Fiom. Quella eresia non ci sarebbe stata se il Partito democratico fosse stato capace di portare su una seria piattaforma riformista il grosso di quella che un tempo era la sua gente, almeno nelle fabbriche. Anche un'alleanza di fatto con la Fiom, che in qualche misura è nelle cose, è un asset che Vendola potrebbe sfruttare abilmente. Chi ha creduto che l'anticapitalismo fosse ormai finito, morto e sepolto, definitivamente sostituito da altre e più nuove «narrazioni», dovrà probabilmente ricredersi.
Angelo Panebianco
20 febbraio 2011© RIPRODUZIONE RISERVATA
da - corriere.it/editoriali
|
|
|
|
|
 Registrato
Registrato
|
|
|
|
|
Admin
Utente non iscritto
|
 |
« Risposta #117 inserito:: Febbraio 27, 2011, 05:44:23 pm » |
|
Il vento arabo della libertà
Il giusto e l'utile
In politica si dà spesso uno spiacevole divario fra ciò che «è giusto» e ciò che «è utile», fra ciò che pensiamo sarebbe giusto fare alla luce dei principi che professiamo e ciò che sappiamo essere utile per i nostri interessi. In politica internazionale, poi, quel divario è la regola. Ciò contribuisce a spiegare l’elevato tasso di ipocrisia che, con buona pace di WikiLeaks, circonda i rapporti interstatali. Si finge di fare ciò che è giusto ma si opera per realizzare solo l’utile. Soltanto in rare, eccezionali, circostanze, il giusto e l’utile coincidono. Adesso, per l’Italia nei suoi rapporti con la Libia, e per l’Occidente tutto nei suoi rapporti con il Medio Oriente, è arrivato uno di quei momenti: fare ciò che è giusto per sostenere le ribellioni contro i tiranni coincide con l’utile, con il nostro interesse.
Nelle fasi di effervescenza rivoluzionaria va di moda criticare la Realpolitik, le commistioni e le complicità con i tiranni. Ma in circostanze normali, non rivoluzionarie, la Realpolitik è una necessità. Saremo tutti contenti se e quando i cinesi si libereranno del giogo autoritario ma, fino ad allora, continueremo a trattare con la dittatura. Non possiamo autoflagellarci per avere trafficato per decenni con i dittatori mediorientali, da Ben Alì a Mubarak, a Gheddafi. Lo imponevano gli interessi delle democrazie occidentali: nessun governante democratico può conservare il potere se non tutela l’interesse del proprio Paese così come esso viene definito dai gruppi interni, politici, sociali ed economici, che contano. E l’interesse richiedeva di coltivare quelle relazioni. Adesso però il gioco è cambiato e anche i nostri interessi in rapporto al Medio Oriente sono in via di ridefinizione. Il giusto e l’utile tendono ora a coincidere: contribuire, da parte nostra, a favorire in quei Paesi l’affermazione di regimi politici più accettabili per i loro cittadini è coerente sia con i nostri valori che con i nostri interessi. A che cosa siamo interessati? Siamo interessati al fatto che le transizioni in Medio Oriente non acquistino, col tempo, un segno antioccidentale.
Come opportunamente ricordava Pierluigi Battista sul Corriere di sabato, anche in Iran la rivoluzione contro il regime oppressivo dello Scià cominciò in nome della libertà ma sappiamo come andò a finire. Ci sono vitali interessi occidentali, di sicurezza ed economici, in gioco. Aiutare in modo non blando o episodico gli insorti può contribuire a prefigurare una situazione nella quale riusciremmo forse a esercitare una qualche influenza sulle condizioni post rivoluzionarie. Le sanzioni già decise dagli Stati Uniti contro Gheddafi, quelle che l’Onu sta adottando, e quelle che probabilmente varerà l’Unione Europea nei prossimi giorni, sono solo un primo passo. C’è un problema italiano in rapporto alla Libia e c’è un problema europeo in rapporto al Medio Oriente nel suo insieme. La vicenda libica ha posto il nostro Paese in prima linea. Ha detto il vero Pier Ferdinando Casini quando, primo fra tutti, ha denunciato il fatto che ciò che accade in Libia è per noi una emergenza nazionale che andrebbe affrontata con il massimo di coesione della classe dirigente.
Siamo i più esposti per gli intensissimi rapporti che abbiamo sempre coltivato con il regime libico, per gli approvvigionamenti energetici, per il volume dei nostri interessi in Libia, per le questioni di sicurezza coinvolte (la possibile ripresa di massicci sbarchi dall’Africa entro breve tempo). E siamo i più esposti anche perché, sfruttando la cattiva fama che ci hanno procurato in Libia le nostre storiche relazioni con Gheddafi, vari competitori occidentali potrebbero tra poco farsi avanti per subentrare all’Eni e al centinaio di imprese italiane che hanno fino a oggi operato in quel Paese. In queste condizioni, e per quanto difficile ciò possa essere, identificare per tempo i possibili interlocutori della «nuova Libia» e aiutarli in tutti i modi, anche finanziariamente, sia ora, contro i colpi di coda del regime morente, sia dopo, nel periodo della ricostruzione, è per l’Italia ancora più vitale che per gli altri Paesi occidentali. La sospensione del trattato Italia-Libia potrebbe non bastare. Se non avremo un ruolo da protagonisti in questa fase, non potremo sperare di averne uno a rivoluzione conclusa.
C’è poi l’Europa. I suoi interessi in Medio Oriente sono troppo importanti perché essa possa permettersi il lusso di non adottare, sia pure in accordo con l’alleato americano, una posizione al tempo stesso energica e lungimirante. I primi segnali sono pessimi. Scegliere, come le democrazie nordiche europee hanno fatto in questi giorni, lo «scaricabarile », rifiutare anche in via ipotetica l’idea di una gestione europea del possibile afflusso di profughi dal Nord Africa, la dice lunga sulla condizione in cui versa l’Unione. Lo tsunami politico mediorientale può essere quella «sfida esterna» ai più vitali interessi della sicurezza dell’Europa in grado di far fare un salto di qualità all’integrazione europea. Oppure, può essere lo scoglio che la farà definitivamente naufragare. La relazione è nei due sensi: la sfida mediorientale potrebbe indurre più coesione in Europa e più coesione le sarebbe necessaria per influenzare, magari ponendo mano a un piano straordinario di aiuti, il futuro del Medio Oriente: al fine di scongiurare derive fondamentaliste in Paesi privi di un passato democratico, e di impedire che la regione venga sconvolta, fra qualche tempo, da nuove guerre.
Concludo osservando che non bisognerebbe farsi prendere troppo la mano della cronaca perdendo di vista i tempi più lunghi della storia. Molti osservatori oggi dicono che le attuali rivoluzioni mediorientali condotte in nome della libertà segnano una sconfitta delle tesi sui conflitti di civiltà. A parte il fatto che non sappiamo ancora come andranno a finire quelle rivoluzioni, si consideri il caso dell’Arabia Saudita. Immaginiamo che la rivoluzione arrivi anche lì. Qualcuno può seriamente sostenere che a Riad si installerebbe un «governo democratico»? A vincere, proprio là dove il mondo più si rifornisce di energia, sarebbe, più facilmente, un fondamentalismo fanatico: un conflitto di civiltà al quadrato. La prudenza è una virtù indispensabile per commentare gli eventi di questi giorni.
Angelo Panebianco
27 febbraio 2011© RIPRODUZIONE RISERVATA
da - corriere.it/editoriali
|
|
|
|
|
 Registrato
Registrato
|
|
|
|
|
Admin
Utente non iscritto
|
 |
« Risposta #118 inserito:: Marzo 07, 2011, 11:36:50 pm » |
|
L'ITALIA E IL FUTURO DELLA LIBIA
Tre scenari per una crisi
Non bisogna mai mettere con le spalle al muro un dittatore che non ha ancora abbandonato il potere
Per quanto essa sia elusiva, vaga e refrattaria a essere imprigionata in definizioni precise, dall'idea di «interesse nazionale» non si può tuttora prescindere. Nonostante i fiumi di inchiostro versati sui cambiamenti delle relazioni interstatali indotti dalla cosiddetta globalizzazione o, nel caso dei Paesi del Vecchio continente, dall'integrazione europea, l'interesse nazionale resta la principale bussola per coloro che devono decidere le politiche estere come per coloro che ne valutano gli effetti. Cruciali questioni di interesse nazionale, come tutti sanno, sono in gioco per l'Italia nella vicenda libica. A seconda degli esiti di quella crisi il nostro interesse nazionale verrà salvaguardato oppure gravemente danneggiato.
Allo stato degli atti, sembrano essere tre i possibili esiti della crisi libica. Nel primo scenario, Gheddafi viene sconfitto, abbandona il potere e gli subentra una nuova classe dirigente che, nonostante grandi difficoltà, si rivela capace di tenere insieme il Paese e di ristabilire normali relazioni con gli altri Stati. Nel secondo scenario, la guerra civile si protrae a lungo e la Libia sprofonda negli inferi, finisce nel girone riservato agli «Stati falliti», in compagnia di Paesi come la Somalia o l'Afghanistan. Nel terzo scenario, infine, Gheddafi riprende il controllo dell'intero territorio, Cirenaica compresa, al prezzo di un terribile bagno di sangue.
Il primo scenario, ovviamente, è il migliore per la Libia ma anche per noi italiani. Si tratterà di stabilire relazioni con una nuova classe dirigente che, presumibilmente, avrà anch'essa interesse a un buon rapporto con l'Italia, che avrà bisogno dei legami economici con noi, tanto più nella fase della ricostruzione post dittatura. Avevamo, è vero, eccellenti rapporti con Gheddafi, il che ci renderà sospetti ai loro occhi, ma è comunque un fatto che, fra gli occidentali, non siamo stati i soli a coccolarlo. Il realismo imporrà ai nuovi dirigenti libici di non rinunciare a una cooperazione vantaggiosa per entrambi i Paesi.
Gli altri due scenari, invece, ci danneggerebbero grandemente. Se la Libia diventasse uno Stato fallito, si trasformerebbe in una piattaforma adibita al trasferimento al di qua del Mediterraneo di fiumi di disperati, di caos, di criminalità e terrorismo, ossia dei frutti avvelenati che crescono sempre negli Stati falliti. E noi saremmo in prima linea, i primi a subirne le conseguenze. In uno scenario «somalo» diventerebbe prima o poi inevitabile un intervento militare della comunità internazionale volto a frenare il caos. Nonostante le insidie e l'alto rischio di fallimento a cui un intervento militare andrebbe incontro.
Ma anche il terzo scenario, quello che prevede un Gheddafi di nuovo vittorioso in Libia, sarebbe pessimo per noi.
In politica internazionale l'ipocrisia è la regola. Fino a ieri tutti, non solo noi italiani, fingevano di non sapere che Gheddafi fosse un turpe dittatore che aveva sempre fatto strame di diritti umani. Lo fingevano i governi, i banchieri, il Consiglio dei diritti umani dell'Onu, persino la prestigiosa Lse (la London School of Economics and Political Science di Londra) destinataria di generosi finanziamenti libici, e tantissimi altri. Adesso però l'incanto si è rotto, adesso Gheddafi è un paria, un ricercato dell'Interpol, un possibile imputato del tribunale penale internazionale. D'ora in poi, fare affari con lui diventerà molto difficile. Se Gheddafi riconquisterà la Libia, per l'Italia saranno dolori, pagheremo un costo economico salatissimo. Per non parlare della difficoltà di ristabilire rapporti di cooperazione su materie sensibili come il controllo dell'emigrazione dall'Africa.
La questione dei rapporti economici Italia-Libia ha due facce. C'è, in primo luogo, il destino del centinaio di imprese che operavano fino a pochi giorni fa in Libia e il futuro ruolo dell'Eni. Adesso che anche noi abbiamo scaricato Gheddafi, un vendicativo dittatore di nuovo in sella potrebbe decidere di spazzarci via a vantaggio di meno scrupolosi concorrenti. La Cina, soprattutto, un Paese che non ha problemi a trattare con i peggiori dittatori, sarebbe certo lieta di subentrare alle nostre e alle altre imprese occidentali. E c'è poi la questione dei fondi sovrani, dei cospicui investimenti dello Stato libico in Italia (la presenza in Unicredit, Finmeccanica, Eni, il ruolo della Banca libica con sede a Roma, eccetera). Per ora, in omaggio alle direttive Onu, abbiamo congelato, come altri Paesi, i beni della famiglia Gheddafi e ci siamo dichiarati pronti, per bocca del ministro degli Esteri Franco Frattini, a congelare anche i fondi sovrani se ciò verrà deciso dall'Onu o dall'Unione Europea. Ma è un tema delicatissimo. Da un lato, sarà impossibile per noi non ottemperare alle eventuali richieste in tal senso degli organismi internazionali. Dall'altro lato, sarà di particolare danno farlo dal momento che i libici sono uno dei principali investitori sulla nostra piazza e, per giunta, un congelamento dei loro capitali sarebbe un pessimo segnale per altri investitori. In ogni caso sarebbe per noi una perdita secca e pesante.
Posto dunque che non solo ai libici ma anche a noi conviene che Gheddafi se ne vada, si può constatare quanto siano state improvvide le dichiarazioni del Consiglio di sicurezza dell'Onu del 26 febbraio secondo cui Gheddafi va processato di fronte al Tribunale penale internazionale, l'apertura di un procedimento a suo carico da parte del Tribunale dell'Aja, l'allerta dell'Interpol per impedire che egli e il suo entourage possano espatriare. Non bisogna mai mettere un dittatore che non ha ancora abbandonato il potere con le spalle al muro. Serviva un salvacondotto, non un processo. Magari Gheddafi è davvero pronto, come ha detto, a morire con le armi in pugno. Ma un salvacondotto, come alternativa al bagno di sangue, doveva comunque essergli offerto. E dovrà essergli offerto. Conviene anche agli entusiasti della cosiddetta «giustizia internazionale». Per dimostrare che fra i suoi effetti perversi non ci sia anche quello di prolungare le sofferenze dei popoli.
Angelo Panebianco
07 marzo 2011© RIPRODUZIONE RISERVATA
da - corriere.it/editoriali
|
|
|
|
|
 Registrato
Registrato
|
|
|
|
|
Admin
Utente non iscritto
|
 |
« Risposta #119 inserito:: Marzo 16, 2011, 12:16:25 pm » |
|
LA SCELTA NUCLEARE
La paura e la ragione
Non sappiamo ancora se i giapponesi riusciranno a impedire la fusione del reattore di Fukushima salvando il loro Paese da un disastro che sarebbe incomparabilmente maggiore di quello provocato dal terremoto e dallo tsunami. Tutti però abbiamo almeno potuto constatare un fatto: il contrasto fra l'ammirevole compostezza del popolo giapponese così duramente colpito e le assai meno composte reazioni occidentali. «Il paradosso del progresso materiale e tecnologico - ha scritto il Wall Street Journal in uno dei migliori commenti che si siano letti sulla vicenda - è che noi sembriamo diventare tanto più avversi al rischio quanto più il progresso ci rende maggiormente sicuri». Per un verso, è proprio grazie agli sviluppi tecnico-scientifici che abbiamo raggiunto eccezionali livelli di benessere e anche (proprio così) di sicurezza: fingiamo per lo più di non saperlo ma la vita quotidiana nelle società pre-moderne era infinitamente più insicura, brutale e breve, di quanto non sia oggi nelle società industriali. Per un altro verso, raggiunti tali livelli di benessere e di sicurezza sembriamo voler rifiutare anche i rischi che pure sono intrinseci allo sviluppo tecnico-scientifico.
È giusto interrogarsi sull'atomo e sui suoi pericoli, pretendere che si faccia tesoro delle esperienze dolorose e che si correggano gli eventuali errori, che i controlli siano esigenti, che la ricerca e le applicazioni della tecnologia della sicurezza siano sempre meglio sviluppate. Ma è anche necessario non smarrire il filo della razionalità. Senza rischi e assunzione di rischi non ci sarebbe mai stato alcun progresso tecnico-scientifico: quel progresso grazie al quale, nelle moderne società industriali, ad esempio, è crollata la mortalità infantile e gli uomini vivono assai più a lungo di un tempo. Non c'è dinamismo sociale possibile che non porti con sé pericoli.
Perché non è possibile rinunciare all'atomo? Perché, anche se non potremo liberarci ancora per lungo tempo dalla dipendenza dal petrolio, è vitale diversificare le fonti di energia e quella atomica resta, dopo petrolio e gas, la più importante.
Si noti che, nonostante l'aggravamento che ha fatto registrare nelle ultime ore la situazione nella centrale di Fukushima e l'allarme delle opinioni pubbliche, i governi dei Paesi occidentali che dispongono di centrali si sono impegnati, con vari accenti, ad innalzare i livelli di sicurezza, non certo a sbarazzarsi della energia nucleare. L'atomo comporta rischi? Certamente, ma si può agire, e si agisce in tutto il mondo per ridurli. D'altra parte, la controprova è data proprio dal Giappone: la schiacciante maggioranza delle centrali giapponesi ha resistito benissimo sotto l'impatto di un terremoto di violenza devastante.
Ci si potrebbe addirittura spingere a sostenere che la dipendenza dal petrolio (a parte i pesantissimi costi economici che impone a chi non lo possiede) comporti pericoli maggiori delle centrali, ossia dell'uso pacifico dell'energia nucleare. Dipendere, per i rifornimenti energetici, da aree ad altissima instabilità politica è infatti causa di rischi immensi. Immaginiamo che una nuova guerra scoppi prima o poi in Medio Oriente e che, come tanti paventano, vi vengano impiegate armi nucleari. Il petrolio mediorientale diventerebbe improvvisamente indisponibile. Che accadrebbe allora a tutti noi? Discutere i pro e i contro dell'atomo va benissimo. Ciò che non va è l'irrazionalità di chi, pretendendo l'impossibile, ossia eliminare il rischio, rinuncia semplicemente a vivere.
Angelo Panebianco
16 marzo 2011© RIPRODUZIONE RISERVATA
da - corriere.it/editoriali
|
|
|
|
|
 Registrato
Registrato
|
|
|
|
|