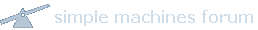|
Admin
Utente non iscritto
|
 |
« inserito:: Maggio 22, 2008, 11:49:22 pm » |
|
Diamo all’anarchia quel che le spetta
Marco Innocente Furina
Anarchia. L’etimologia della parola non lascia dubbi: «contro l’autorità», «senza governo». Non questo o quel governo, non una autorità determinata, ma l’autorità e il principio gerarchico in quanto tali. Gli anarchici sono nemici giurati del potere dell’uomo sull’uomo, di ogni sopraffazione, di ogni costrizione, non importa sotto quale bandiera si eserciti. Eccoli allora, a recitare il ruolo romantico degli sconfitti in ogni rivoluzione, anche quelle vittoriose.
Accanto ai rivoltosi il primo giorno ma subito da questi divisi non appena è chiaro che l’obiettivo non è abbattere lo tirannia ma ricostituirla sotto un altro nome, come nella tragedia della guerra civile spagnola. O opporsi alla libertà borghese di cui contestano il contenuto di classe. Ma soprattutto eccoli schierati contro quello che ai loro occhi è la radice d’ogni male, contro il Leviatano, contro quel concentrato di forza e potere che è lo Stato moderno. «Il pensiero anarchico in tutte le sue manifestazioni, dall’individualismo estremo di Max Stirner al comunismo anarchico di Kropotkin, attraverso le fasi intermedie del mutualismo proudhoniano e del collettivismo di Bakunin, presenta una costante, che è quella di opporsi al potere in ogni sua forma e innanzitutto a quella che è la forma più tipica e invadente di potere nella società moderna, cioè lo stato nazionale unitario», scrive uno studioso del tema come Carlo Roherssen. Non solo e non tanto perché lo Stato è marxianamente la sovrastruttura oppressiva che garantisce la divisioni in classi della società, ma perché è il più grande concentrato di potere (e di capacità oppressive) che la storia abbia conosciuto. Dopo la rivoluzione francese, quello Stato che si voleva e si proclamava «liberale», dalla prigioni alla leva militare obbligatoria (entrambe «invenzioni» di quegli anni), fu il più grande apparato di coercizione che la storia abbia conosciuto. Il pensiero anarchico si sviluppa fra 700 e 800 proprio come reazione a questo fenomeno di disciplinamento della società. Fu Pierre Joseph-Proudhon il primo ad definirsi coscientemente anarchico, anche se già alla fine del 700 l’inglese William Godwin, erede della tradizione anticonformista britannica e dei philophes francesi, nel suo Enquiring Concerning Political Justice espresse posizioni anarchiche contro governo, istituzioni e leggi.
La tradizione anarchica si espressa attraverso quattro filoni principali: l’anarco-comunismo, che si distingue dal socialismo di Stato perché contrario a qualunque forma di autorità centrale; l’anarco-sindacalismo, che si concentra sulla conquista operaia dell’industria e dell’amministrazione; l’anarco-individualismo, che pone l’accento sull’autonomia individuale e il mutualismo; infine, il pacifismo anarchico fondato sulla critica al militarismo e all’uso della forza su cui poggia in definitiva l’esistenza dello Stato. Dalle parole ai fatti il passo fu breve. Se bisognava spezzare l’autorità dello Stato, si doveva colpire chi quell’autorità concretamente incarnava: Eccoli allora quei ribelli secondo lo stereotipo che li vuole dotati di «barba, mantello e bomba sferica con tanto di miccia accesa», pronti a lanciarsi contro le carrozze e vetture di regnanti e potenti dell’Europa fin de siecle. A spargere il terrore nelle cancellerie del continente furono soprattutto italiani. Sante Caserio, che nel 1894, uccise il presidente della Repubblica Francese; Michele Angiolillo, tre anni più tardi uccise il presidente del consiglio spagnolo; Pietro Acciarito, nello stesso anno tentò di uccidere il re Umberto I di Savoia; E infine Gaetano Bresci, che il 29 luglio 1900 a Monza, riuscì nell’impresa: attuò il regicidio.
Ma perché occuparsi del pensiero anarchico? Qual è la sua attualità oggi che le costituzioni garantiscono un ampio catalogo di diritti individuali e sociali; che proprio lo Stato sembra il miglior garante delle libertà dei singoli grazie alle sue prestazioni sociali e come baluardo nei confronti dell’anarchia (appunto…) dei mercati e della globalizzazione? Oggi che più che mai si sente il bisogno di un’autorità forte che sappia regolare processi economici e sociali che sembrano sfuggire a qualsiasi controllo razionale?
Colin Ward nel suo Anarchia. Un approccio essenziale (Eleuthera, pp. 125, euro 12) spiega che dell’anarchismo va recuperata la lezione fondamentale: la non accettazione delle verità (o dei dogmi) e dell’imposizioni dell’autorità costituita - sia essa lo Stato, il datore di lavoro, le gerarchie amministrative, la scuola o la Chiesa - per ampliare il più possibile la sfera di libertà del singolo. Perché se è vero che il pensiero anarchico ha sempre oscillato tra forme estreme di liberalismo e di comunismo, entrambe utopistiche, e pertanto irrealizzabili e irrealizzate, e altrettanto vero che «gli anarchici hanno contribuito a dar vita a tutta una serie di piccole liberazioni che hanno dato sollievo alla miseria umana». E hanno anticipato spesso di parecchi decenni comportamenti e idee oggi correnti. Fu Kropotkin a coniare l’espressione «e prigioni sono le università del crimine», denunciando le carceri come istituzioni criminogene. E anche nell’campo dell’educazione e del lavoro le concezioni anarchiche hanno contribuito potentemente all’emancipazione dell’individuo. E a proposito del lavoro è interessante notare come l’autore consideri i piccoli imprenditori non come eroi tacheriani ma come ribelli creativi che lottano «contro l’ossessione di scegliere tra essere un dipendente o un datore di lavoro». Ma è nel campo dei diritti individuali che il pensiero anarchico mostra la sua maggiore attualità. È fra gli anarchici che molto prima che la questione divenisse un tema d’attualità politica erano invalse le «libere unioni» non sancite dalla Chiesa o dallo Stato. E sulla questione della liberazione della donna Emma Goldman, un’anarchica russa vissuta a cavallo tra 800 e 900, scriveva a proposito del diritto voto parole che farebbe piacere sentire con questa chiarezza oggi quando si affrontano i temi dell’aborto o delle quote rosa. L’emancipazione femminile - sosteneva - deve venire dalla donna «prima di tutto proponendosi come personalità, non come merce sessuale. Poi rifiutando il diritto di chiunque altro sul proprio corpo; rifiutando di fare figli , se non li vuole; rifiutando di essere serva di Dio, o dello Stato, della società o del marito, della famiglia eccetera; rendendo la propria vita più semplice, ma più profonda e più ricca. Liberandosi dal timore della pubblica opinione e della pubblica riprovazione. Solo questo, non il voto, libererà le donne…»
L’anarchia è libertà. Ma una libertà più radicale, estrema, meno compromissoria di quella classica della tradizione liberale. L’individualismo liberale crede di difendere l’individuo con la scissione del pubblico dal privato; l’individualimo anarchico rigetta questa impostazione perché in tal modo non è l’individuo che si salva, ma una’idea astratta di individuo. «Io affermo che non l’uomo astratto, ma il singolo è la misura di tutte le cose», proclama Max Stirner.
L’anarchismo è un pensiero complesso, articolato, a volte contraddittorio ben diverso dal semplice vuoto di potere o dalla confusione e mancanza di ogni regola a cui ci si riferisce parlando di anarchia. Un equivoco che viene da lontano, e che risale alla fine dell’800 quando una minoranza di anarchici credette di spezzare l’autorità dello Stato con l’assassinio politico.
Pubblicato il: 22.05.08
Modificato il: 22.05.08 alle ore 12.01
© l'Unità.
|