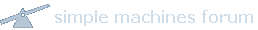Intervista
Esercito e società italiana
Intervista al generale Mario Buscemi
Il ruolo dell’Esercito nella società italiana, ieri ed oggi
di Stefano Bernini 12/02/2009
Biografia
Generale di Corpo d’Armata e Consigliere della Corte dei Conti
Ha comandato reparti granatieri, carristi e paracadutisti. Quale Generale è stato: Comandante della Brigata Granatieri di Sardegna;
responsabile della logistica (investimento e funzionamento) dell'Esercito e interforze (IV Reparto SME e SMD);
Comandante del Contingente militare italiano nel Kurdistan Iracheno nel 1991 (Operazione AIRONE );
Comandante della Regione Militare della Sicilia (Operazione VESPRI SICILIANI);
Ispettore delle Scuole dell'Esercito;
Sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito ( coordinatore delle operazioni di pace in SOMALIA, MOZAMBICO E ALBANIA);
Consigliere Militare presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dal 2002 è Presidente dell'Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna.
Cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia e Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, è decorato con due Croci d'Argento al merito dell'Esercito ed ha ricevuto numerose altre onorificenze.
Lo spirito di attaccamento e di identificazione della società civile con le proprie Forze Armate è direttamente proporzionale, talvolta, ai successi militari che queste hanno conseguito. Gen. Buscemi, Lei condivide questo principio? Se si, come ritiene che si sia realizzato e sviluppato nel contesto storico, sociale e politico italiano?
----
I Paesi che sono usciti sconfitti dalla Seconda Guerra Mondiale – cioè la Germania, l’Italia e il Giappone, in particolare – sono quelli in cui i militari si trovano ancora in una condizione di relativa scarsa considerazione rispetto ai Paesi, come la Gran Bretagna, dove certamente hanno conseguito grossi successi. Direi che tra questi proprio la Gran Bretagna è quella che ha ottenuto i migliori risultati, perché non ha avuto né il Vietnam né la guerra di Algeria, che in qualche maniera hanno intaccato la credibilità rispettivamente degli Stati Uniti e della Francia.
La polemica sull’impiego e, talvolta, sulla natura stessa della Forze Armate in Italia – che continua ad essere di scottante attualità - ha radici antiche e profonde, riconducibili a più di una matrice: da un lato abbiamo, infatti, già all’indomani dell’unità d’Italia, la diffidenza, sfociata talvolta in vera e propria ostilità, da parte delle genti meridionali nei confronti delle istituzioni dello Stato, e in particolare delle sue Forze Armate e di Polizia, a seguito del processo di “piemontesizzazione” del Sud-Italia, di cui l’esercito sabaudo è stato strumento e protagonista, scrivendo pagine non sempre luminose della nostra storia unitaria – mi riferisco in particolare ad alcuni episodi della lotta al brigantaggio; l’impiego dell’Esercito nella repressione delle prime rivendicazioni sociali tra fine ‘800 e primi del ‘900; l’impiego delle Forze Armate in campagne di guerra discutibili, al fianco di ancor più discutibili alleati (compresa la gestione di improvvisi cambiamenti di fronte, “conflitto durante”); l’inadeguatezza, a volte presunta, a volte reale, soprattutto nei decenni passati, dell’armamento, equipaggiamento e addestramento delle nostre Forze Armate rispetto a quelle dei più importanti Paesi della NATO. Dall’altro lato, il “non-interventismo”, convertitosi in netta ostilità contro i reduci, da parte dei socialisti e degli anarchici in occasione della Prima Guerra Mondiale, e, dopo la Seconda Guerra Mondiale, la diffidenza con cui le forze di sinistra hanno guardato alle nostre Forze Armate, considerate in una posizione di sudditanza nei confronti degli Stati Uniti, quando non affette addirittura da “pulsioni” golpiste. In un caso e nell’altro, c’è da osservare che spesso le nostre Forze Armate hanno pagato con l’impopolarità il prezzo di errori la cui responsabilità doveva ricadere sui vertici politici, della cui volontà le Forze Armate sono uno strumento. Alla luce dei nuovi scenari geopolitici, ritiene che questo “strappo” con un’ampia fascia della società civile verrà “ricucito” automaticamente dalla storia, o si renderanno necessari degli interventi aggiuntivi?
La storia delle Forze Armate, e dell’Esercito in particolare, certamente non è stata sempre improntata ad una totale integrazione con il sentire del popolo. Noi non dobbiamo dimenticare che, per esempio, già la coscrizione obbligatoria, che fu proposta con l’Unità d’Italia, fu qualcosa che scosse profondamente l’interesse e il modo di vedere di molte popolazioni del Sud. Indubbiamente la lotta al brigantaggio – quello che fu definito “brigantaggio” - fu in effetti, sotto alcuni punti di vista, un’operazione di guerra contro coloro che in qualche maniera erano sostenuti, o sostenevano, il precedente regime. Noi abbiamo avuto anche la repressione di certe sommosse, con interventi di carattere sociale, come i famosi cannoni di Bava Beccaris, che sono un fatto noto a tutti, in cui le Forze Armate sono state impiegate come strumento di repressione, perché quello era il mezzo che si aveva a disposizione.
C’è di più. In buona parte anche il primo conflitto mondiale fu sofferto come un’imposizione da chi non aveva la percezione di quello che fosse il problema della trasformazione della struttura europea. È chiaro che il primo conflitto mondiale, che finì con un evento vittorioso, riuscì a creare per lo meno una certa area di consenso nei confronti delle Forze Armate, che però si scontrò con i problemi di carattere economico che discendevano dal conflitto stesso, provocando la nota situazione del dopo-guerra. Resta il fatto, per esempio, che le Forze Armate non erano affatto favorevoli all’avvento del fascismo; lo accettarono perché il re decise in tal senso, ma erano certamente pronte a intervenire contro la “marcia su Roma”.
Le guerre coloniali, grazie alla propaganda fascista, hanno certamente portato un grosso appoggio alle Forze Armate: queste, negli anni ’30, sono state tenute in alta considerazione in Italia. Anche l’entrata in guerra, nonostante quello che si dice oggi, nel quadro in cui la propaganda aveva presentato l’intervento italiano nella Seconda Guerra Mondiale, inizialmente fu accolta come una necessità, con prospettive anche di trasformazioni in senso positivo della nostra situazione.
Il vuoto che si creò dopo, cioè la serie di insuccessi pesanti che noi subimmo su tutti i teatri – e non per colpa delle Forze Armate, ma per aver impostato il conflitto contro forze decisamente superiori, soprattutto più avanzate dal punto di vista tecnologico - chiaramente provocarono un senso di disaffezione che fu tanto più forte quanto più alto era stato nel passato l’entusiasmo di certe manifestazioni: al di là delle manifestazioni formali, delle cerimonie, del passo romano, delle sfilate, di tutto quello che contribuiva a dare un significato, un valore alle Forze Armate, l’impatto di questi insuccessi determinò una grossa delusione e dette luogo a un atteggiamento di sostanziale distacco da parte della popolazione verso le Forze Armate.
C’è di più; che i disastri delle due guerre mondiali sono stati così devastanti, sia in termini di vite umane che in termini economici, che tutti i paesi europei – e l’Italia in particolare – hanno, verso le operazioni militari, un atteggiamento che è sostanzialmente diverso – lo vediamo anche in Afghanistan – rispetto a quello degli Stati Uniti e della Gran Bretagna che, avendo avuto successo nella Seconda Guerra Mondiale e avendone tratto un notevole prestigio, ancora trascinano questa posizione di privilegio e di stima che altrove non è così riconosciuta.
Indubbiamente, quindi, l’esito negativo della guerra è stato estremamente pesante, anche perché, su di esso, si è inserita l’esaltazione della guerra partigiana. La guerra partigiana non è stata una guerra; è stata una serie di operazioni che si sono concluse positivamente, e questo è un punto importante da ricordare: noi siamo soliti dire che i partigiani hanno liberato l’Italia dall’oppressione dello straniero. Non è così; i tedeschi se ne sono andati perché gli americani stavano vincendo. Il fatto che nei due-tre giorni di intervallo tra l’uscita dei tedeschi dalle città e l’arrivo degli americani i partigiani abbiano preso il potere non dimostra che quella dei partigiani sia stata l’operazione che ha portato alla soluzione del problema dell’occupazione tedesca. Però indubbiamente i partigiani sono usciti vittoriosi, in forza della loro struttura certamente molto più politica che militare: anche se organizzati in bande militari, l’approccio dei partigiani è stato essenzialmente politico. Si pensi per esempio a un aspetto interessante: i militari che, fedeli al re, andarono in montagna e si inserirono nelle strutture partigiane, sono stati sostanzialmente boicottati; ma non per incapacità: perché la prevalenza di uno schema ideologico, certamente ben definito delle forze partigiane, faceva sì che i militari, che appartenevano a un altro quadro ideale, non fossero ben visti.
Tutto questo si è trascinato anche nel dopo-guerra: la contrapposizione “militare in servizio come elemento d’ordine” – “partigiano come espressione del popolo”, ha dato luogo a questa diversificazione. Addirittura si è visto nel partigiano l’eroe e nel militare l’oppressore, e questo non è stato riferito solo alle forze germaniche che ci occupavano, ma è stato esteso in genere anche a tutto il contesto militare; nel voler, anche giustamente, criticare certe nostre operazioni fatte alla luce di una politica certamente non rispondente ai canoni a cui ci riferiamo oggi, si è cercato di vedere nei militari una responsabilità che invece era del sistema, nel suo insieme. Però questo ha lasciato un segno nel paese: il paese ha visto nei militari i responsabili di una guerra di cui loro erano stati, in sostanza, le principali vittime.
A questo punto, cosa è successo nel dopo-guerra? C’è stato un altro passaggio di grosso rilievo: lo schieramento dell’Italia nella NATO che si opponeva al Patto di Varsavia. E allora, tutti coloro - che erano, lo sappiamo, circa la metà del paese - che per fede e per convinzione politica erano molto più vicini all’Unione Sovietica che al sistema capitalistico, è chiaro che vedessero nelle Forze Armate uno strumento che si opponeva a quelli che erano i loro ideali; perché la difesa della NATO serviva per dare sostegno e proteggere un sistema contro il quale loro si battevano. Ne è conseguito una schieramento della sinistra contro i militari più che dei militari in senso conservatore – è chiaro che i militari, per loro natura, sono normalmente più portati ad avere una posizione moderata e di vicinanza alle istituzioni che non di sovversione. Però attenzione, non è sempre così. Si pensi ai moti del primo ‘800, del ’21 e del ’31, in cui i militari, eredi dell’esperienza napoleonica, erano proprio quelli che guidavano l’insurrezione contro la restaurazione che si era creata successivamente alla perdita del potere di Napoleone. Quindi, in definitiva, i militari si sono schierati in posizione, diciamo così, conservatrice, reazionaria – usiamo le parole che vogliamo – perché dall’altra parte venivano considerati come coloro che si opponevano al raggiungimento di determinati obiettivi, che erano stati quelli di una grossa aliquota della guerra partigiana e che poi avevano contribuito a determinare la guerra fredda.
C’è stata tutta una campagna sul golpismo. Obiettivamente, che qualcuno negli Stati Uniti, nel caso di presa del potere da parte delle sinistre in Italia - di una sinistra filo-russa, o filo-sovietica – abbia pensato alla possibilità di scongiurare questa eventualità anche facendo ricorso all’opzione militare, è certamente possibile. È assolutamente da escludere che questa ipotesi abbia intaccato la struttura delle Forze Armate: queste, per loro natura, sono rimaste sempre estranee a simili scenari; salvo i casi di singole persone e non in quanto componenti delle Forze Armate. E questo direi, non tanto per una convinzione di profonda fede nella democrazia, quanto per la generica assenza di interessi ideologici: i militari, in Italia, non sono mai stati contro l’autorità. Mentre in alcuni paesi – pensiamo alla Spagna, pensiamo al Cile, pensiamo alla Francia di De Gaulle – i militari, in alcuni momenti, forti della loro autorità, del prestigio che ritenevano di avere, si sono presentati come un potere che si contrappone ad un altro, in Italia questo non è mai avvenuto, perché l’Esercito non ha mai avuto una consistenza, soprattutto nel dopo-guerra, tale da potersi opporre come elemento di confronto. Se noi pensiamo al milione di manifestanti che partecipavano a uno sciopero o a una manifestazione di metalmeccanici, e contrapponiamo dall’altra parte il tentativo di golpe di cui si parla [il tentato colpo di stato messo in atto da Junio Valerio Borghese, nel 1970, n.d.r.], di “sette guardie forestali”, è chiaro che c’è una sproporzione che chiaramente definisce queste ipotesi golpiste (ammesso che ci fossero state) qualcosa da operetta e non un pericolo effettivo. Ancorché, nella loro dimensione ridotta, potevano rispondere ad alcune istanze di estrema reazione propria degli Stati Uniti; pensiamo agli eccessi che hanno avuto gli Stati Uniti ai tempi del maccartismo, per cui gli Stati Uniti hanno attraversato dei momenti in cui si pensava di eliminare con la forza qualsiasi opposizione che fosse in qualche modo collegata all’ideologia comunista. Quindi non è improbabile che qualche idea sia passata per la mente di qualcuno; ma da questo a parlare di un coinvolgimento delle Forze Armate c’è un abisso. Resta il fatto che la propaganda pressante effettuata in quel periodo ha fatto sì che la popolazione, o almeno certe aree della popolazione si convincessero che i militari tramassero; e questo era il frutto di questa pressione, di questa volontà, che non era tanto finalizzata a prevenire un golpe, quanto piuttosto a mettere in cattiva luce le Forze Armate, le quali Forze Armate rispondevano ad una ipotesi strutturale che non corrispondeva agli interessi della controparte. Cito, a proposito di quale psicosi si fosse creata in quel periodo, un episodio che ha un certo interesse. In uno di quegli anni, non ricordo quale, come sempre c’era la parata del 2 giugno, che prevede una precedente prova notturna, che viene fatta intorno al 27-28 maggio; e questa prova notturna prevedeva che sfilassero anche i mezzi – adesso si fa tutto a piedi, a quell’epoca, per minori preoccupazioni di cedimenti strutturali, soprattutto del Colosseo, sfilavano anche i mezzi [mezzi cingolati, carri armati, n.d.r.] – e quindi ci fu nella notte un grosso sfilamento di mezzi corazzati in via Cristoforo Colombo che andavano a schierarsi per fare questa prova. In via Cristoforo Colombo c’è un complesso di edifici appartenente a una cooperativa che mette a disposizione le abitazioni ai deputati, e quindi una zona dove abitano moltissimi politici, i quali, vedendo questi carri sfilare di notte, furono colti da terrore, pensando che fosse giunto il famoso momento fatale, quando invece si trattava solo della prova della sfilata, che non aveva assolutamente alcun rilievo. Ripeto, una vera psicosi. Mi ricordo che in una normale esercitazione di armata, alcuni soldati del mio battaglione, sicuramente appartenenti a una certa linea politica, si precipitarono a telefonare a casa dicendo: «Attenti, attenti, qui stiamo partendo per fare qualcosa….», che si risolveva in una normale situazione di allarme. Però la psicosi ci fu. Quindi, indipendentemente dal fatto che l’Esercito fosse o no orientato verso il golpe, rimane il fatto che il paese fu influenzato da questi sospetti, e questo è stato un altro motivo, diciamo così, di discredito, dopo le vicende della guerra.
Poi ci sono altri fattori. L’arma nucleare è stata un altro elemento; una cosa che si diceva sempre: «c’è la bomba atomica, cosa stiamo lì a tenere i soldati nelle caserme se poi la guerra si risolve in un secondo?». Quindi ci sono state delle grosse difficoltà in questo senso, e, a tal proposito, è da ricordare anche una cosa determinante, che è il servizio di leva.
Il servizio di leva non era più adeguato ai tempi; tant’è vero che anche in Italia, a fronte di un esercito di leva che doveva difendere la frontiera - che, nonostante tutto, non era così minacciata come si pensasse, perché che l’Unione Sovietica avesse interesse a invadere l’Italia è tutta da dimostrare, a distanza di tempo - in realtà, fu costruita una struttura parallela a quella dell’Esercito [Stay behind, comunemente conosciuta come “Gladio”, n.d.r.], formata soprattutto dalle forze di Polizia, volontari, che potesse assicurare quella sicurezza interna, che era quella di cui, in realtà, ci si preoccupava. Dopo Yalta, l’Unione Sovietica non ha mai teso a conquistare militarmente quella parte che stava al di là della cortina di ferro; però ha sempre cercato di creare in queste aree dei movimenti, delle azioni che tendessero, non dico a rovesciare, ma quanto meno a mettere in difficoltà i regimi, i sistemi di governo che erano chiaramente favorevoli agli Stati Uniti.
Contro queste azioni – che andavano dagli scioperi generali alle manifestazioni di piazza ecc. – chiaramente le Forze Armate italiane non davano pieno affidamento, perché fatte di soldati, la cui metà era della stessa opinione politica di quelli che manifestavano; mentre le forze dell’ordine erano fatte di volontari, erano selezionate. Attenzione, questo è un aspetto che ha anche un ritorno guardando indietro nel passato; parliamo di fine ‘800 – primi del ‘900, fino alla Seconda Guerra Mondiale. Sostenendo il principio che per rinvigorire i rapporti della popolazione, i soldati, i giovani facessero il servizio di leva in aree lontane dalla propria sede di residenza, allo scopo di unificare, di far sentire il Paese unito, di mescolare le varie regioni, in realtà, il motivo politico che sottintendeva questo era che, dovendosi verificare l’ipotesi che l’Esercito intervenisse in piazza per reprimere delle insurrezioni, i soldati non fossero della stessa origine di quelli che stavano sul campo, degli operai o dei contadini che manifestavano, perché erano appartenenti a regioni diverse, e quindi non si sentissero solidali con loro. Tant’è vero che, era altresì previsto che, all’atto della mobilitazione, quando si fosse andati in guerra, come è avvenuto, invece il reclutamento avvenisse per regione, perché in guerra la solidarietà tra i soldati, il supporto delle famiglie, erano importanti.
Quindi sono tutti aspetti che danno l’idea che in realtà l’ipotesi di impiegare l’Esercito per la repressione ci sia sempre stata – d’altra parte, è una funzione delle Forze Armate, quando la polizia non ce la fa più – però, di fatto, non è stata applicata.
Veniamo avanti. L’impopolarità. Sarà possibile ricucire questo strappo? Questo è un argomento che io ho trattato molte volte. Venuta meno questa contrapposizione est-ovest – anche se ora Putin si sta risvegliando – non ha alcun senso identificare le Forze Armate con una parte o con l’altra; questo io l’ho detto in tante occasioni, oramai sono anni, dall’89 in poi. Mai come oggi le Forze Armate – l’Esercito, la Marina e l’Aeronautica – sono di tutti gli italiani e non solo di quella parte che la pensa in un certo modo. Perché si protrae allora questo senso non dico di ostilità, ma quanto meno di indifferenza o di scarsa attenzione verso le Forze Armate? Perché il modo di pensare della gente non si trasforma nel giro di poche ore: quelli che sono cresciuti, sono stati educati secondo un certo modo di vedere le cose, difficilmente all’improvviso si svegliano e cambiano idea; l’atteggiamento viscerale verso le Forze Armate rimane, si trascina nel tempo, e richiederà un certo lasso di tempo perché si trasformi. Si aggiunga la fortissima pressione fatta contro il servizio di leva, quando questo effettivamente non era più sentito; questo bisogno di difendere il confine, per cui i giovani dovevano correre alle armi, non si avvertiva più, era finito il tempo. Quindi, attaccare il servizio di leva faceva parte di un certo gioco politico perchè serviva a mettere in cattiva luce le Forze Armate, a suscitare all’interno delle Forze Armate tensioni, preoccupazioni, crisi. Oltre tutto si è verificato questo fatto: che mentre il servizio di leva continuava ad essere una questione di volontà politica, perché il passaggio al professionismo poteva preoccupare, dal momento che i professionisti potrebbero essere più o meno politicamente inquadrati, e costano certamente di più, in realtà, nell’opinione pubblica, nell’uomo della strada era il cattivo Generale quello che voleva strappare i figli alle mamme e portarseli in caserma; e quindi l’ostilità si è in certo senso intensificata. Su questo si è innescato il concetto del “nonnismo”; il nonnismo è un fenomeno comune a qualsiasi comunità: dal collegio al seminario ecc.; si tratta di vederlo in maniera più o meno marcata, ma è un fenomeno che si verifica, è strutturale, fisiologico: va controllato, va pilotato, va represso, ma di per sé l’anziano tende sempre a esercitare un’autorità trasversale, indiretta, parallela sul giovane che arriva in una determinata sede. Il nonnismo è stato oggetto di una esasperata campagna mediatica perché rientrava nel gioco di mettere in cattiva luce la struttura. Lo stesso discorso per la droga: a un certo punto nelle mamme c’era la convinzione che i giovani imparassero a drogarsi nell’Esercito, andando a fare i militari. Ora, si noti bene: lo stesso fenomeno, ovvero l’uso più o meno consentito, più o meno sottinteso di qualche spinello o di qualche manifestazione di nonnismo – io ora non vivo più la vicenda - certamente si verificherà ancora oggi, perché, ripeto, sono fenomeni che fanno parte dei nostri tempi; non se ne parla più, perché, dato che non dà più fastidio, non risponde più a un certo obiettivo, e l’argomento è scomparso dalla scena – probabilmente si sarà attenuato, ma in sostanza la situazione è rimasta sempre quella. Quindi anche in questo caso, come sempre, bisogna vedere se dietro queste situazioni ci sia un gioco di interessi che lavorano sulla propaganda, che lavorano sulla stampa, e toccano quei settori dove la gente è più sensibile, come era quello delle mamme che si preoccupavano dei figli. Io sono dovuto intervenire di persona: c’è stato un momento di grande tensione in cui, al giuramento delle reclute, si vedevano questi genitori terrorizzati, pensando che i figli andassero veramente ad essere sottoposti a delle torture vere e proprie. Abbiamo dovuto dire: «state tranquilli, qui siamo delle persone normali, non siamo degli aguzzini», perché l’immagine dell’ufficiale come aguzzino era abbastanza ricorrente e rispondeva ad un certo gioco, chiaramente sempre per gli interessi politici di cui parliamo.
Sarà ricucito lo strappo? Sarà ricucito se le cose cambiano, ma ci vorrà tempo; ci deve essere un salto generazionale. Salto generazionale che tra l’altro però scivola in un altro settore: il totale disinteresse. I giovani oggi non sono contro le Forze Armate; non gli interessa assolutamente niente, perchè queste appartengono a un mondo che non è più il loro, hanno altre cose per la testa – resta il fatto invece che oggi i militari rappresentano una notevole area occupazionale perché in fondo noi teniamo sempre impegnate circa 200.000 unità, tra le tre Forze Armate, più le forze di polizia si arriva a 4-500.000, quindi in qualche maniera, soprattutto al sud, c’è un atteggiamento di desiderio di entrare, non per grandi ideali, ma per una questione di collocazione e di vita.
A memoria d’uomo, non si ricordano società che abbiano avuto “complessi di colpa” a seguito di campagne vittoriose delle proprie Forze Armate; questi complessi, semmai, emergono a seguito di sconfitte (penso, ad esempio, ai sensi di colpa degli americani a seguito dei bombardamenti con il napalm durante la guerra in Vietnam – che hanno perso – ma che non hanno avuto a seguito delle bombe atomiche sganciate sul Giappone nella Seconda Guerra Mondiale – che hanno vinto). A Suo giudizio, quanto ha contribuito la nostra storia militare, a volte non proprio brillante, soprattutto nel passato, ad alimentare questa disaffezione (più che pacifismo o ostilità) da parte della società italiana nei confronti delle sue Forze Armate?
Complessi di colpa...direi che in guerra si esercita la violenza. La guerra è un atto di violenza. In guerra determinati comportamenti violenti del singolo, che normalmente vengono repressi perché l’ambiente non li consente, si scatenano facilmente, quindi è chiaro che qualsiasi guerra, che di per sé è deprecabile perché è uno strumento che si usa per uccidere, comporta anche delle violenze. Si tratta di valutare fino a che punto questi eventi negativi debbano essere esasperati. Parliamo del caso tipico dei gas in Etiopia, che è stato oggetto di grandi polemiche. Montanelli - che ha vissuto la vicenda come cronista, quindi non soltanto come “tenentino”, comandante di plotone, che viveva a livello di clima, di mentalità, di modo di pensare, di habitus mentale dei soldati - non sapeva che era stato usato il gas in Etiopia. Poi gli studi hanno dimostrato che qualcosa è stato fatto, ma certamente in misura molto moderata. È una cosa comunque deprecabile, ma non è il caso di cancellare, di deprecare completamente, esasperare questo concetto, come adesso sta avvenendo per esempio per l’uranio impoverito. L’uranio è un altro aspetto chiaramente negativo, perché gli americani hanno usato questo munizionamento che può provocare seri danni, anche se dimostrato in maniera non del tutto totale; ma insomma, hanno usato questi mezzi. Però la dimensione di questo inconveniente è data dalla scarsa linea di comando, perché chiaramente gli americani non si sono preoccupati di farci sapere quale fosse il pericolo, e noi, certamente, al contrario di come si son volute presentare le cose, non ci saremmo mai sognati che gli ufficiali mandassero i soldati a morire, a rischiare così solo per il piacere di vedere i propri uomini stare male. Chiaramente c’è stato qualcosa che non ha funzionato a qualche livello nel trasmettere questi dati, quindi è un fatto che certamente costituisce un inconveniente, e bisogna rintracciare le responsabilità; ma da qui a presentarlo come un’ulteriore manifestazione secondo la quale i quadri dell’Esercito sono degli aguzzini che portano i propri soldati a morire senza motivo, ce ne corre!
Veniamo ora alla - per la verità, alquanto eterogenea – galassia pacifista. A Suo avviso, che margine di dialogo sussiste con chi, da un lato, propugna la pace “senza se e senza ma”, e dall’altro sfila cantando Bella ciao (inno della guerra di liberazione partigiana che, in quanto “guerra”, sia pure di liberazione, aveva ben poco a che vedere con la pace) e sventolando l’immagine del comandante “Che” Guevara (uomo di straordinaria onestà intellettuale e coerenza, ma che certo non può essere definito un pacifista)?
I pacifisti vedono chiaramente nelle Forze Armate i loro principali avversari. Continuano a dire anche adesso che le operazioni di pace che si fanno in varie aree del mondo andrebbero fatte senza i militari. Ora, io per quel poco che ho vissuto in Kurdistan, in Somalia, in Mozambico, dico che senza militari, laddove si spara, non si può andare, perché i militari sono quelli che in qualche modo garantiscono la sicurezza. Che poi l’intervento militare sia risolutivo o no, è un discorso a parte - è una questione politica - ma non è certamente il discorso che intacca la qualità dell’azione dei militari. Che poi i militari, nelle loro attività, qualche volta possano compiere, come si è visto in Iraq da parte degli Stati Uniti, azioni violente che non sono giustificate, è fuori di dubbio – noi italiani, in questo senso, chiaramente ci sentiamo molto a posto perché il comportamento dei nostri uomini è decisamente il più umanitario tra tutti quelli che partecipano a queste operazioni, tanto che ci accusano addirittura di essere poco combattivi; ma fa parte della nostra natura, dei nostri principi.
Bella ciao, per quello che so, è una derivazione di una canzone russa del secondo conflitto mondiale, non è nostra, è un traslato di qualcosa che riguarda l’Unione Sovietica – adesso non vorrei sbagliare, ma non è improbabile che sia così – per cui anche Bella ciao ha una connotazione politica e ideologica ben chiara che va presa per quella che è.
Che Guevara sappiamo che era un combattente. Adesso qualcuno, per metterlo in cattiva luce, dice che era addirittura un sanguinario; era un combattente, e come tale era costretto a compiere atti di violenza. Non era certamente un santo né un portatore di pace con la benedizione dei principî.
La caduta del muro di Berlino e i nuovi scenari politici, sia interni che internazionali, avrebbero dovuto indurre ampie fasce dell’opinione pubblica italiana (mi riferisco in particolare alla sinistra) a rivedere le proprie posizioni nei confronti delle Forze Armate e del loro impiego. Questo si è verificato in parte (penso soprattutto alla sinistra istituzionale, come in occasione del nostro intervento in Kossovo, fortemente voluto dall’allora Presidente del Consiglio, Massimo D’Alema, che tanto successo ha riscosso oltre-oceano). Sussistono, tuttavia, consistenti sacche di “integralismo pacifista” che vanno da alcune frange dell’estrema sinistra a gruppi anarcoidi e ad alcuni movimenti di matrice cristiana, fino ad arrivare ad ampi strati della popolazione che, prescindendo da qualunque ideologia politica, sostengono una sorta di “qualunquismo pacifista”. Ritiene che si tratti di frange di “irriducibili”, o pensa che anche con loro sia possibile sedere al “tavolo delle trattative”?
Noi abbiamo sempre questa grossa difficoltà in Italia, ovvero la discrepanza tra l’enunciazione dei principi e il quadro della politica internazionale che non ci consente di andare al di fuori di certi schemi; si è visto quando D’Alema è intervenuto in Kossovo, si è visto adesso di recente quando, con il governo di centro-sinistra, sostanzialmente si è sempre confermata la nostra presenza all’estero. E si noti bene, che il ritiro dall’Iraq, che era stato presentato come una grande conquista del centro-sinistra, era già stato deciso da prima, tanto è vero che già erano stati tolti gli stanziamenti dei fondi; a livello NATO si sapeva che saremmo andati via, quindi si è trattato di una naturale conseguenza. Si diceva entro dicembre; che poi sia stato fatto con un anticipo di qualche settimana rispetto a quello che avrebbe fatto l’altro governo, non cambia la sostanza delle cose.
È difficile uscire da certi schemi internazionali, come d’altra parte non bisogna lasciarsi trascinare dagli entusiasmi di taluni che, a fronte dell’accusa che ci viene fatta di essere poco combattivi, si sentono in dovere di scodinzolare davanti all’alleato americano o inglese per dire che dovremmo batterci di più. Ma batterci…bisogna vedere qual è lo scopo.
Tornando al punto. Io sono convinto che uno Stato, una struttura militare, debba anche mettere in gioco le vite dei propri uomini, dei propri dipendenti, del proprio popolo, per il raggiungimento di uno scopo; ma, prima di tutto, va valutato lo scopo a cui si tende, e poi vedere se questo scopo meriti il sacrificio da mettere nel conto. Ora, è fuori dubbio che il problema della scarsa affidabilità di certi Paesi è un problema di popolo, non è un problema di un gruppo di fanatici, ma di popolo, perché ci sono delle contrapposizioni, un modo di sentire, una tradizione strutturale. È difficile pensare di piegare l’Afghanistan con le armi. Bisogna trovare altre strade; e quindi, insistere in questa direzione serve soltanto a rendere più cruda la vicenda, e ci porta poi al fatto che vengono compiuti anche questi attentati ai nostri soldati, perché si fa di ogni erba un fascio, ed è interesse dei talebani far vedere che sono tutti malvagi e tutti fuori posto.
Gli anni ’90 e la crisi nella ex Jugoslavia hanno visto nascere una nuova generazione di pacifisti che, nonostante spesso si auto-definiscano “ghandiani”, in nome del sostegno umanitario hanno invocato l’intervento massiccio e violento dei contingenti internazionali - soprattutto contro i serbi – (è quello che il Generale Jean ha definito “interventismo pacifista”, a fronte di un atteggiamento molto più prudente da parte degli stessi militari). Ritiene che questa categoria di pacifisti possa costituire un interlocutore attendibile per ripianare le tensioni tra società civile e mondo militare?
Sul pacifismo io non direi molto, perché il pacifismo, nella maggior parte dei casi, è un non-senso, cioè, è un apprezzabile ideale che gli uomini si vogliano tutti bene, ma è chiaro che, come la polizia a un certo punto deve intervenire con le manette, perché altrimenti i criminali in prigione spontaneamente non ci vanno, così talvolta si rende necessario l’intervento dei militari negli scenari internazionali. Il pacifismo non si ispira a Ghandi; era Ghandi, semmai, ad avere davanti a sé un popolo come gli inglesi, che avevano capito che non era più il caso di continuare. Quindi Ghandi è un concetto. Noi abbiamo un predecessore di Ghandi, di ben maggior rilievo, che diceva “porgi l’altra guancia” – era Nostro Signore – però è chiaro che nella storia del mondo, porgendo l’altra guancia non si giunge a risultati. Il pacifismo spesso è di maniera, spesso fa comodo perché sembra che ci sia qualcuno che vuole la pace, e altri che invece vogliono la guerra, cioè altri che amano uccidere il prossimo, e questo chiaramente è un falso. Il pacifismo spesso nasconde interessi ideologici specifici, perché poi, come sappiamo, è sempre a senso unico, cioè si schiera contro certe operazioni militari fatte da qualcuno mentre ignora operazioni militari fatte da altri in altri paesi e in altre direzioni, e quindi va preso per quello che è: come una utopia, rispettabile per chi ci crede, stando attenti a tutti coloro che se ne avvalgono per fini che invece sono tutt’altro che pacifisti, ma corrispondono solo all’acquisizione del potere.
In Italia (e non solo) le Forze Armate vengono tradizionalmente associate alla destra. Ritiene plausibile che, paradossalmente, proprio la sinistra, con alcuni suoi atteggiamenti “unilateralmente” anti-militaristici, abbia esacerbato un’attitudine latente nel mondo militare, alienandosi le potenziali simpatie di una parte di esso, e gettandone un’altra parte tra le braccia dell’estrema destra (che invece, per tradizione, ha sempre cavalcato la tigre del militarismo)?
Ci fu un grosso sondaggio fatto negli anni ’70, credo, sull’orientamento dei militari di professione, e venne fuori che mediamente stavano tra i democristiani e i social-democratici. Insomma, non erano affatto di estrema destra; naturalmente la sinistra era abbastanza ridotta. Resta il fatto che, sostanzialmente, le maggior parte ha un orientamento che non è favorevole alle sinistre. A questo proposito volevo citare, a parte questo sondaggio, quello che è avvenuto con i paracadutisti. I paracadutisti sono stati definiti, anche lì sempre in maniera strumentale, come l’espressione tipica di un partito. Io ci sono stato per anni, e posso assicurare che quando c’ero io da tenente, quindi a contatto con la base, non c’era assolutamente una situazione di questo tipo. Il mio autista era comunista iscritto al partito, addirittura. Ma a parte questo, c’è stato un fenomeno inverso: una volta che, allo scopo di denigrare le Forze Armate, si è detto che queste appartenevano a un’area di estrema destra, alcuni settori dell’estrema destra hanno indotto i loro appartenenti a passare nella file dei paracadutisti per poter dire che avevano come loro appendice una parte dell’Esercito; cioè, c’è stato il tentativo di inglobare, di incastrare l’Esercito nei propri ideali. In realtà, questi personaggi che avevano questi colori, e che erano presenti perché erano di leva, sono sempre stati tutti sotto controllo, e in sostanza non sono mai riusciti ad influire minimamente su quello che è stato il comportamento delle Forze Armate.
L’impegno dei contingenti militari italiani nelle missioni internazionali di pace continua ad essere, nonostante i tagli alla Difesa, intenso e continuativo. La partecipazione dei nostri contingenti a queste missioni, oltre che un beneficio per le popolazioni coinvolte nelle crisi, costituisce un ottimo strumento per garantire l’affidabilità dell’Italia di fronte alla comunità internazionale; il fatto che governi di diverso orientamento politico abbiano autorizzato l’invio dei nostri militari all’estero sta a dimostrare che - senza entrare nel merito delle singole missioni – astenersi dal partecipare a queste operazioni comporterebbe una perdita di credibilità del nostro Paese, mentre invece la presenza dei nostri contingenti dimostra la continuità e la coerenza della politica estera dell’Italia – al di là delle forze politiche che la governano; in una parola, come dicevo poc’anzi, la sua “affidabilità” internazionale. L’avvio e lo svolgimento di queste missioni sono sempre accompagnate dalle solite polemiche sul fronte interno, mentre invece, sul fronte esterno, i nostri contingenti continuano a ottenere i riconoscimenti della comunità internazionale. Nonostante le consuete polemiche interne, è lecito, a Suo giudizio, auspicare che in un prossimo futuro la nostra partecipazione a queste missioni internazionali possa costituire un catalizzatore di consensi intorno alle nostre Forze Armate anche da parte dell’opinione pubblica italiana?
È chiaro che le operazioni di pace non sempre sono condivise a livello politico, ma per fortuna dobbiamo dire che sul comportamento dei nostri soldati non c’è nessuna obiezione.
Tra gli anni ’80 e gli anni ’90, sulla scia della “crociata” contro il “nonnismo”, si è avviato un programma di riavvicinamento tra società civile e Forze Armate, che prevedeva l’apertura delle caserme alle mamme delle reclute; si pretendeva di combattere il militarismo – presunto – con il “mammismo” – effettivo. La fine della leva obbligatoria e l’avvento del professionismo, con l’arruolamento volontario, hanno cambiato notevolmente il panorama delle nostre Forze Armate. Alla luce di questo nuovo scenario – che già di per sé ha comportato un cambiamento nella percezione delle Forze Armate da parte del mondo civile – quali interventi politici, tecnici e, oserei dire, culturali, ritiene che possano risultare più idonei, a breve, medio e lungo termine, per ricostruire un rapporto di reciproca identificazione e rinsaldare quel sodalizio tra società civile e Forze Armate di cui il Paese, dopo decenni di lacerazioni, ha urgente bisogno?
A questo punto posso dire che l’abbandono della leva obbligatoria e l’avvento del professionismo ci inducono a guardare avanti con un certo ottimismo: è chiaro che le Forze Armate non danno più fastidio alla popolazione, come era prima, anzi sono, come ho detto, uno sbocco di carattere lavorativo che può consentire di sopravvivere a un grosso numero di persone.
Vorrei dire un’altra cosa. Che l’esperienza della leva, anche se presentata in maniera così spregiativa, è stata vista in senso negativo più dalle classi dirigenti, dagli intellettuali, che si vedevano costretti in un sistema non identificabile con il loro modo di vivere, che dalle classi popolari. Le classi popolari hanno accettato il servizio militare sapendo che dentro le caserme in fondo vigevano delle regole abbastanza sane, e in periodi che, a partire dal ’68, hanno visto distribuita la crisi dei valori a tutti i livelli, è chiaro che un sistema che aveva dei valori, aveva delle regole – fossero queste valide o meno, ma comunque c’erano dei principi – è stato per molti giovani motivo di sicurezza, motivo di assestamento: il fatto di dover fare qualcosa in un certo modo, il fatto di doversi confrontare con gli altri, scoprire che certe regole del vivere comune impongono delle auto-limitazioni, aveva una funzione educativa che indubbiamente c’era e non si voleva riconoscere, perchè c’era tutta una tendenza politica che vi si opponeva.
Tutto questo adesso è superato con il servizio militare volontario; ma già stanno emergendo altri problemi perché, per motivi di carattere tecnico, strutturale, noi non abbiamo la possibilità di trattenere in servizio tutti quelli che entrano, dal momento che, se noi, chiamandoli adesso, trattenessimo tutti in servizio, tra venti o trenta anni avremmo un esercito di vecchi; quindi dobbiamo inserirne un’aliquota gradualmente ogni anno, fermo restando che altri fanno un anno e poi sono selezionati per entrare nelle forze dell’ordine oppure per fare altre attività. Si è parlato di precariato. Non è precariato, è una cosa che già si sa: già si sa che, entrando, la probabilità di restare è ridotta, perché tecnicamente non è possibile trattenere tutti. È comunque un fattore di tensione, perché è chiaro che chi entra dentro poi, stranamente, ci vuol stare; poi chi c’è dentro, di solito, quando va via, si lamenta. Quindi anche questo è un aspetto che va guardato con un occhio abbastanza distaccato.
In sintesi, il nostro paese, che è uscito dalla guerra, da una guerra persa, non ha un grande orgoglio militare. Su questo scarso orgoglio, sulla depressione che ne è conseguita a livello degli stati d’animo, si è inserita una volontà politica che è nata prima nel segno dell’Unione Sovietica, e si è sviluppata poi in certe frange di estrema sinistra che cercano sempre, in qualche maniera, di intaccare tutte le istituzioni, tutta l’autorità, avvalendosi anche di questo drammatico retroterra psicologico che c’è nell’italiano, che vede nell’autorità sempre un nemico, perché siamo stati per secoli oppressi, e come tali, chiunque eserciti l’autorità va guardato con occhio negativo; e quindi, in questo contesto, fa abbastanza gioco istigare al rifiuto delle disciplina e della serietà di intenti del senso del dovere. Questa spinta, quest’indirizzo, venuto meno il contrasto tra i due blocchi, venuto meno il servizio di leva, inevitabilmente tenderà a ridursi, quindi le Forze Armate tenderanno ad avere una maggiore accettazione da parte della popolazione. E stranamente, faremo più fatica soprattutto ad avere l’accettazione da parte della classe dirigente, che guarda alle Forze Armate come a qualche cosa di alieno, qualche cosa di non interessante, di scarsa utilità; a meno che le Forze Armate non portino quattrini, perché, con l’acquisizione dei materiali, contribuiscono in qualche maniera a facilitare lo sviluppo dell’industria. E questo è un punto molto delicato che si sta dibattendo ancora. Il bilancio della difesa, rispetto al prodotto interno lordo, in Italia, lo sappiamo tutti, è uno dei più bassi di tutta la NATO. Questo bilancio, già così carente, viene speso in una direzione che non è quella giusta: anziché dare il sostegno ai militari che rischiano la vita all’estero, il bilancio viene speso soprattutto per acquisire materiali….
Speriamo che questi concetti si possano diffondere, attraverso uno sguardo che sia il più possibile oggettivo e distaccato, che non sia né fazioso, da anti-militarismo di maniera, né una difesa per principio di valori che oramai, in buona parte, sono superati.
Bisogna guardare serenamente alle Forze Armate come a una componente importante che merita la giusta attenzione, perché i soldi non si spendono, soprattutto oggi come oggi, per comprare missili stratosferici, ma si spendono per tenere in ordine le caserme, che stanno cascando, crollando, perché non ci sono i soldi per la manutenzione.
da
www.sintesidialettica.it