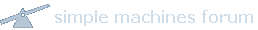18 maggio 2024 Versione web
Benvenuti alla newsletter che è il nostro appuntamento settimanale, ogni sabato mattina. Vi prometto una lettura molto personale di alcuni eventi globali che selezionerò come "la chiave" per dare un senso alla settimana. Con una particolare attenzione alle mie due sedi di lavoro, l'attuale e la precedente: New York e Pechino. "The place to be, and the place to look at..."
Non esitate a scrivermi: commenti o domande, contestazioni e proposte.
https://api-esp.piano.io/public/in/313/j60vefcf-questa-e-l-eu_APP_300x250.pngIl protezionismo non è una novità. Ma per la Cina apre una nuova epoca
30 anni di crescita cinese trainata dagli Usa: e ora?
La raffica di nuovi dazi che Joe Biden ha imposto su certe importazioni dalla Cina (o l’aumento di dazi che erano già stati varati da Donald Trump) rappresenta davvero “la fine di un mondo”, l’ingresso in una nuova era segnata dal protezionismo? Se sì, quali saranno le conseguenze? Come reagirà la Cina? E quanto di questa manovra protezionista è legato alla scadenza elettorale del 5 novembre? Sono temi importanti di cui dovremo occuparci per forza nei prossimi mesi.
Anticipo una conclusione (provvisoria): non sarà facile per la Cina riconvertire il suo modello di sviluppo che per trent’anni ha fatto affidamento sulle esportazioni come traino e sull’America come mercato di sbocco principale; tanto più che Xi Jinping è prigioniero di un’ideologia “anti-consumista” che gli preclude di sostenere la domanda interna. Il Grande Sud globale può offrigli delle alternative solo parziali, e alcune di queste forse si stanno già chiudendo.
Tasse doganali fino al 100%, ecco la lista
Comincio col ricordare i dati. Cioè i dazi. Sono tasse prelevate alla dogana, con l’effetto di aumentare i prezzi delle importazioni quindi renderle meno competitive rispetto allo stesso prodotto nazionale. Biden li ha alzati al 100% sulle auto elettriche che equivale a raddoppiarne il prezzo finale per l’acquirente americano; al 50% per cellule solari, semiconduttori, siringhe e aghi sanitari; al 25% su batterie al litio, acciaio, alluminio, e minerali strategici. Su alcuni di questi prodotti esistevano già dazi varati dall’Amministrazione Trump. In certi casi Biden è arrivato a quadruplicarli.
Le reazioni, soprattutto degli esperti e dei media, in America sono state segnate dal solito riflesso di appartenenza politico-ideologica. Fra gli economisti, alcuni che avevano condannato il protezionismo di Trump si affrettano ad applaudire quello di Biden. Idem per i media vicini al partito democratico, speranzosi che la sterzata protezionista serva ad arginare le perdite di voti in Stati industriali come il Michigan. Ci sono per fortuna delle eccezioni. Un omaggio va reso alla coerenza dell’Economist, per esempio: fedele al suo Dna liberista, il settimanale britannico condannava i dazi di Trump e oggi applica lo stesso giudizio negativo ai super-dazi di Biden.
"Le barriere ci impoveriscono". Ma non hanno impedito i miracoli economici
I liberisti sinceri e tenaci, quelli che non cambiano giudizio a seconda di chi sta applicando i dazi, ripropongono una dottrina classica: il protezionismo fa male a tutti, danneggia anche chi lo applica, riduce i vantaggi del commercio internazionale, impoverisce i consumatori e quindi alla lunga anche i lavoratori. E’ l’abc delle teorie economiche insegnate sui manuali universitari. Ma è teoria pura, con scarsi agganci alla realtà.
Noi non stiamo assistendo alla fine di un’epoca, perché non siamo mai vissuti in un mondo dalle frontiere veramente aperte. Per limitarsi al periodo successivo alla seconda guerra mondiale, basta ricordare che la Comunità economica europea (detta anche “mercato comune”, era l’antenata dell’Unione europea) fu un esperimento di apertura delle frontiere molto graduale, controllato, e riservato ai membri del club. Verso l’esterno l’Europa è stata a lungo un mercato chiuso e difeso da alte barriere, con punte massime di protezionismo nel settore agricolo. Eppure gli anni della Cee furono quelli dei miracoli economici: tedesco e italiano fra gli altri. Il protezionismo europeo non impedì la crescita dell’occupazione e la diffusione del benessere.
Parlando di miracoli economici, che dire di quelli asiatici? Sempre a partire dal dopoguerra, ci furono dei boom spettacolari prima in Giappone, poi nei cosiddetti “dragoni” o “tigri” come Hong Kong, Singapore, Corea del Sud, Taiwan. Infine il contagio positivo dello sviluppo economico e del progresso sociale si estese alla Cina, all’India. Tutte queste nazioni, tutte senza eccezioni, adottarono e in parte praticano tuttora robuste dosi di protezionismo.
Esportare in Cina non è mai stato facile, salvo nei settori dove il governo cinese aveva bisogno dei prodotti stranieri per qualche strutturale impossibilità di raggiungere l’autosufficienza; oppure non era ancora capace di produrli a casa propria: queste due definizioni hanno incluso la soia e la carne di maiale del Midwest americano, il lusso di Armani Vuitton Hermès Gucci Prada, e tante tecnologie strategiche che i cinesi compravano da noi per copiarle e poi sostituirle con produzioni nazionali appena possibile.
Protezionismo Usa con Reagan, liberismo con Bush-Clinton
Poiché i miracoli economici asiatici sono stati quasi sempre trainati dalle esportazioni (con la parziale eccezione dell’India), e visto che quei paesi praticavano il protezionismo, a chi riuscivano a vendere? Prevalentemente all’America, in subordine anche all’Europa, infine ai paesi emergenti i quali però non hanno ancora raggiunto lo stesso potere d’acquisto dell’Occidente.
Gli Stati Uniti di norma sono stati il mercato più aperto dalla seconda guerra mondiale in poi. Tuttavia hanno praticato anche loro il protezionismo a fasi alterne – il caso più eclatante furono le restrizioni sulle automobili ed elettrodomestici giapponesi imposte dal repubblicano Ronald Reagan negli anni Ottanta – però nel complesso sono stati un mercato meno difeso di altri. Salvo pagarne dei prezzi. I primi prezzi a diventare visibili e politicamente scottanti furono quelli sociali, che hanno determinato le scelte di voto della classe operaia danneggiata dalla globalizzazione. Più di recente sono diventati visibili e preoccupanti i prezzi strategici, in termini di sicurezza nazionale: pandemia, guerra in Ucraina, crescente ostilità geopolitica della Cina, hanno fatto capire quanto sia pericoloso dipendere in modo eccessivo da fornitori come Pechino. Per le siringhe come per i semiconduttori, o le batterie.
Quando gli Usa volevano la divisione dei compiti con la Cina
Faccio un breve salto indietro per spendere almeno qualche parola in favore del liberismo. Voglio ricordare il dibattito americano degli anni Novanta, quando i due George Bush padre e figlio (repubblicani) e Bill Clinton (democratico) stavano accogliendo la Cina nella Wto (World Trade Organization, l’organizzazione mondiale del commercio). Già allora c’erano obiezioni sia di tipo sociale sia di tipo ambientalista, che esplosero in modo virulento con le celebri proteste di Seattle nel 1999 in occasione di un summit Wto. I sindacati obiettavano, a chi esaltava lo “sconto cinese” che avrebbe regalato al consumatore americano merci abbondanti a poco prezzo: che me ne faccio dello sconto se intanto ho perso il salario perché la mia fabbrica ha chiuso, mi ha licenziato, e al mio posto hanno assunto in Cina operai cinesi? L’obiezione ecologista riguardava la concorrenza al ribasso sulle normative a tutela dell’ambiente.
Cosa rispondevano allora a queste obiezioni i Bush, Clinton, gli economisti liberisti e l’establishment capitalistico? Il progetto positivo della globalizzazione prevedeva che gli americani si spostassero su attività e mestieri sempre più qualificati, lasciando ben volentieri ai cinesi le mansioni operaie. In parte quella transizione ha funzionato e la Silicon Valley californiana ne è l’incarnazione virtuosa: i giovani informatici lì guadagnano super-stipendi progettando gli iPhone o i semiconduttori; mentre lasciano agli operai cinesi il compito di assemblare quei prodotti nella “fabbrica del pianeta”.
Però non tutta l’America si è trasformata in una Silicon Valley, ci sono settori economici e categorie sociali e zone geografiche che dalla globalizzazione hanno ricavato più danni che benefici. Inoltre la stessa Silicon Valley nel 2024 vede il mondo in una luce diversa rispetto a come lo vedeva nel 2004. Oggi anche Big Tech si rende conto che le tensioni strategiche con la Cina hanno reso aleatoria e pericolosa una divisione del lavoro in cui tutto ciò che è fisico e materiale deve traversare il Pacifico per arrivare in America.
Pericolo: una sostenibilità "made in China"
In quanto all’ambientalismo, molta strada è stata fatta rispetto alle giornate di Seattle nel 1999, quando a protestare contro il Wto c’erano anche i Verdi. Oggi l’ambientalismo è la dottrina ufficiale di Biden. Una delle ragioni per cui tartassa di dazi le auto elettriche cinesi, è che non può permettersi di consegnare a Pechino il monopolio di tutte le tecnologie indispensabili alla sostenibilità. All’interno degli Stati Uniti, l’adozione dell’auto elettrica sta incontrando forti venti avversi. La quota di mercato delle elettriche ristagna. Per seguire le direttive Biden la Ford nel primo trimestre di quest’anno ha perso 100.000 dollari su ogni vettura elettrica fabbricata. Tutto si regge su un fiume di sovvenzioni pubbliche, che peraltro potrebbero venire meno se Trump vince le elezioni. Su questo precario equilibrio potrebbe abbattersi come un uragano l’invasione delle cinesi. Non accadrà, perché di fatto le auto elettriche cinesi già oggi (prima ancora che entrino in vigore i nuovi dazi) hanno una quota di mercato infima negli Usa. Il problema è più serio per le batterie. Qui subentra la politica industriale di Biden, che sempre a colpi di aiuti di Stato riesce a riportare gradualmente sul territorio Usa una parte della produzione di batterie. Anche qui però Biden pratica la prevenzione: vuole evitare che il suo esperimento di reindustrializzazione assistita venga ucciso sul nascere da un’invasione di “made in China”.
Le contromisure di Xi Jinping e dei suoi industriali
Come reagirà Pechino a queste barriere? La risposta cinese sarà articolata. Da un lato, le case automobilistiche cinesi cercheranno semplicemente di riorientare le loro esportazioni verso mercati meno protetti di quello americano.
Tanto più che i prodotti cinesi oltre ad essere meno cari (grazie alle sovvenzioni del loro governo) sono anche di buona qualità. Per esempio: l’innovazione “made in China” sull’elettronica di bordo ha fatto progressi spettacolari. Al punto che marche tedesche giapponesi sudcoreane si sono dovute rassegnare a fare accordi con colossi cinesi come Baidu e Tencent per installare sui propri modelli venduti in Cina schermi tv, Gps, software di pilotaggio automatico. Di fronte al duplice vantaggio – prezzi bassi e qualità alta – l’Europa è il primo mercato che la Cina può conquistare per compensare l’inaccessibilità di quello americano. Proprio per questo Bruxelles sta per correre ai ripari e presto adotterà probabilmente i suoi dazi. Dovranno essere alti quanto quelli americani, per funzionare.
Il Grande Sud è ricettivo... con dei limiti
Un altro sbocco per le esportazioni cinesi (non solo di auto) è l’Asia, più il Grande Sud globale. La penetrazione cinese in tutti i mercati extra-occidentali è già forte. Però anche lì stanno cominciando le resistenze. In certi casi il protezionismo si tinge di diffidenza geopolitica verso la Cina: è il caso di India e Giappone. In altri casi, come il Brasile, i paesi emergenti vedono le proprie industrie nazionali minacciate dalla concorrenza cinese e devono rispondere alle stesse pressioni a cui risponde Biden in casa propria.
Un’opzione per l’industria cinese è quella di aggirare i protezionismi altrui andando a produrre altrove. In parte lo stanno già facendo da anni con il Sud-est asiatico: una parte del "made in China" oggi ci arriva con l'etichetta "made in Vietnam", perché una fase della produzione è stata delocalizzata in un paese con salari più bassi di quelli cinesi, ed esente dai dazi americani.
Il Messico è un altro candidato ideale, perché fa parte del mercato unico nordamericano e quindi non è colpito dai dazi. O addirittura i cinesi potrebbero costruire fabbriche sul territorio degli Stati Uniti e assumere manodopera locale. Questo rappresenterebbe una “soluzione alla giapponese”: negli anni Ottanta e Novanta, in seguito al protezionismo di Reagan, i colossi nipponici dell’automobile e dell’elettronica cominciarono a investire negli Stati Uniti trasferendovi una parte della loro capacità produttiva e creando occupazione. Giappone e Corea del Sud fecero lo stesso anche in Messico dopo la sua adesione al Nafta (la prima versione del mercato unico nordamericano): donde la proliferazione di “maquiladoras”, come vengono chiamate le fabbriche di multinazionali a Sud del Rio Grande-Rio Bravo, soprattutto nella zona di Tijuana.
L'espediente messicano già denunciato da Trump
La Cina però non è il Giappone né la Corea del Sud. Viene percepita come un antagonista geostrategico dagli Stati Uniti, e Xi Jinping non ha fatto nulla per rassicurarli (vedi alla voce: Putin in Ucraina; ma anche Hong Kong, Taiwan, Filippine). Perciò non è detto che gli Stati Uniti accettino di accogliere investimenti cinesi sul proprio territorio come lo fecero con i giapponesi. In quanto al Messico: Trump ha già detto che se verrà eletto lui colpirà con un dazio del 200% le auto cinesi ovunque siano fabbricate, Messico incluso.
In definitiva Xi Jinping non può dare per scontato che il resto del mondo continuerà ad essere accogliente verso le sue esportazioni, come lo è stato negli ultimi trent’anni. Certo, in alcuni settori i cinesi sono stati talmente bravi (e spregiudicati) da conquistarsi posizioni dominanti, per cui non è facile fare a meno dei loro prodotti. Però si vede nel caso degli Usa che una reindustrializzazione domestica è possibile, ancorché lenta e costosa.
La "trappola di Xi": chi disprezza il consumismo è obbligato a esportare
Il problema della Cina, è che la sua dipendenza dall’export è addirittura cresciuta negli ultimi anni. La percentuale che le esportazioni rappresentano sul suo Pil supera addirittura i massimi storici che vennero raggiunti dal Giappone o dalla Germania all’apice del loro successo commerciale. E proprio i casi di Giappone e Germania stanno a dimostrare quanto sia difficile riconvertirsi, quando si è costruito un modello economico dove la crescita viene trainata dalle esportazioni. Per cambiare sistema bisognerebbe stimolare in modo poderoso i consumi interni. Perché la Cina non lo fa, o non ci riesce? I suoi consumi ristagnano. Non per caso. E’ quel che vuole Xi.
Questo presidente per certi aspetti è un nostalgico del maoismo e della sua etica dell’austerità. Pensa che il consumismo sia tipico di civiltà decadenti, come l’America. In perfetta coerenza, lui è anche un severo critico dell’assistenzialismo. Può sembrare strano, un comunista contrario al Welfare? In realtà c'è la stessa logica austera di cui sopra. Un Welfare generoso, di tipo europeo, può indurre certe fasce della popolazione a starsene a casa e aspettare un assegno statale, anziché “masticare amarezza” e accettare quel che offre il mercato del lavoro. “Masticare amarezza” è uno dei consigli che Xi impartisce alla sua gioventù, agli “sdraiati” che stanno a casa dei genitori perché non trovano un posto all’altezza delle loro aspettative, e della loro laurea. Perfino nel periodo più terribile della pandemia, Xi si rifiutò di fare quel che fecero Trump e Biden e tanti governi europei: mandare assegni alle famiglie. Inoltre, di fronte al crac del suo settore immobiliare, anziché montare delle costose operazioni di salvataggi pubblici sul modello dell’America 2008, il primo messaggio di Xi è stato questo: la casa è un bene sociale, guai a chi la compra per speculare, peggio per lui se perde i suoi risparmi.
Se Xi tiene duro sulla sua linea, se in casa propria resta un convinto fautore dell’anti-consumismo, se evita di costruire un Welfare o di distribuire sussidi ai cittadini perché li spendano, la sfida che ha di fronte è piuttosto impervia. Vuole rendersi sempre meno dipendente dall’Occidente; eppure senza i nostri mercati l’economia cinese è destinata a perdere dinamismo.
Xi e Putin alleati anche nello spazio: "guerre stellari" contro l'America?
Russia e Cina rafforzano la loro alleanza in tutti i settori. Al boom dell’interscambio, alla crescente dipendenza economica e tecnologica di Putin da Xi Jinping, ora bisogna aggiungere una nuova dimensione: lo spazio. Qui però il rapporto è più paritetico, assai meno sbilanciato in favore della Repubblica Popolare. La Russia rimane una superpotenza spaziale, nel 1957 fu la prima a mettere in orbita un satellite vincendo la prima tappa della gara con l’America. Tuttora l’Occidente preferisce mantenere in vita una “coabitazione” con gli astronauti russi nella stazione orbitale internazionale (anche se nessuno dà molta pubblicità a questa strana oasi di convivenza…)
Ma è soprattutto fra Russia e Cina che la cooperazione spaziale avanza. Che possa avere un potenziale militare, lo lascia sospettare una fuga di notizie pilotata di recente dalla Casa Bianca. Un satellite che Mosca mise in orbita nel febbraio 2022 – lo stesso mese in cui Putin lanciava l’invasione dell’Ucraina – sarebbe progettato per sperimentare una nuova arma nucleare, destinata a colpire e indebolire la rete satellitare americana. Il satellite russo si chiama Cosmos-2553, fu lanciato il 5 febbraio 2022, da allora continua a navigare attorno alla terra seguendo quella che gli americani definiscono una “orbita inusuale”. Le prime notizie su questo satellite furono fornite dalla Casa Bianca a un ristretto gruppo di parlamentari, uno dei quali ha richiesto che vengano “de-classificate”, cioè rese di dominio pubblico. Un’ipotesi è che il Cosmos-2553 sia un prototipo usato per sperimentare un attacco senza precedenti: un’arma nucleare che distrugga centinaia di satelliti americani, sia statali che privati.
Attualmente l’America gode di un vantaggio netto nella copertura satellitare, soprattutto a bassa orbita: ha 6.700 satelliti che operano in questa parte dello spazio, contro i 780 della Cina e i 150 della Russia. I satelliti Usa sono per la maggior parte privati e offrono servizi di tipo commerciale. Alcune di queste reti private però possono avere funzioni “duali”, si è vista l’importanza della rete Starlink di Elon Musk per gli ucraini.
Stati Uniti e Giappone hanno cercato di “stanare” Putin presentando al Consiglio di sicurezza Onu una proposta di risoluzione che ribadisca il divieto di mettere in orbita armi nucleari, contenuto nel Trattato sullo spazio del 1967. La Russia ha posto il veto contro quella risoluzione.
La Cina a sua volta è iperattiva nello spazio. L’evento più importante del 2024 sotto questo aspetto è stato il lancio della missione lunare Chang’e 6. Il suo obiettivo è raccogliere campioni minerali e chimici al Polo Sud della luna: quello che resta invisibile dalla terra, ma contiene ghiaccio da cui si possono estrarre acqua, ossigeno e idrogeno. Acqua e ossigeno potrebbero consentire una lunga permanenza di astronauti. L’idrogeno potrebbe essere il combustibile per lanci dalla luna verso Marte. Qui spunta la cooperazione con la Russia: l’obiettivo di Xi Jinping è costruire una base lunare permanente insieme con i russi entro il prossimo decennio. Gli americani sostengono che anche in questo caso ci sono obiettivi militari, non solo di tipo scientifico.
In cambio del suo aiuto la Russia ha ricevuto un regalo prezioso nell’isola cinese di Hainan, la base tropicale per i lanci della Repubblica Popolare nello spazio. Ai tempi del suo fondatore Mao Zedong e dello "scisma" fra Pechino e Mosca, la Cina comunista arrivò a temere che l’Unione sovietica potesse attaccarla con armi nucleari. Perciò la base di lancio per i missili cinesi fu situata nel deserto di Gobi, considerato meno vulnerabile all’attacco sovietico. Hainan è una collocazione molto più favorevole, perché ai tropici la rotazione terrestre aumenta la potenza di lancio. Ora nella base spaziale di Wenchang situata su quell’isola, si aprirà un Politecnico russo in grado di formare diecimila studenti nelle discipline aerospaziali. Anche questo è un segnale di cooperazione rafforzata tra i due paesi, in un settore dove le sinergie tra scienza e armamenti sono note.
"Il nuovo impero arabo" eccolo qua
Esce questo martedì 21 maggio il mio libro "Il nuovo impero arabo" edito da Solferino, e sarò in Italia a presentarlo. Intanto due sviluppi recenti di attualità sembrano confermare alcuni dei temi che approfondisco nel libro.
Primo, uno dei più autorevoli osservatori americani del Medio Oriente, il collega Thomas Friedman del New York Times, ha scritto che "l'Arabia diventa il nuovo Egitto". A cosa si riferiva? Non certo alla situazione economica: l'Egitto è dissanguato dalla corruzione dei suoi militari, è in bancarotta, e sono proprio i capitali sauditi a tenerlo a galla. No, Friedman si riferisce al fatto che dopo la guerra dello Yom Kippur (1973) l'America sviluppò una "strategia egiziana" con Sadat: tra i frutti di quella strategia ci fu l'accordo di pace Egitto-Israele, ma anche lo sviluppo di un rapporto autonomo tra Washington e Il Cairo, che non dipendeva dalla triangolazione con Israele. Friedman sostiene che l'America di Biden (e Trump) propende verso un'alleanza strategica con l'Arabia, anche a prescindere se quest'ultima accetta di riconoscere Israele.
L'altro sviluppo recente dell'attualità sono i segnali di crisi di alcuni progetti avveniristici all'interno di Neom, la nuova "città-Stato" che il principe saudita Mohammed bin Salman (MbS) sta costruendo. Nel mio libro illustro i piani visionari e ambiziosi di questo giovane sovrano, ne cito anche la vulnerabilità. Qualcosa può andare storto, forse anche molte cose possono andare storte (già il 7 ottobre 2023 ha inferto un colpo alla strategia saudita). Ma bisogna pensare a MbS come una specie di Elon Musk in versione araba e monarchica. Un chief executive con altissimo spirito di rischio, che forse dà per scontato il fallimento di alcuni dei suoi progetti...
Nel libro troverete risposte anche a molti quesiti che alcuni di voi mi avevano rivolto negli ultimi mesi, in particolare durante i miei lunghi viaggi nel Golfo arabico-persico: sui diritti umani, sulla condizione dei lavoratori nei cantieri sauditi, sull'omicidio di Khashoggi, sull'Iran, e altro ancora.
Federico Rampini, New York 18 maggio 2024
Ricevi questa email in quanto iscritto alla newsletter. Titolare del Trattamento Dati è RCS MediaGroup S.p.A. Se intendi disiscriverti dalla Newsletter "Global" fai click qui. Se desideri rettificare, modificare, consultare i tuoi dati o comunque esercitare i diritti riconosciuti ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679 scrivi a
privacy@rcsdigital.it