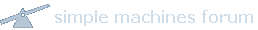|
Admin
|
 |
« inserito:: Maggio 28, 2024, 06:54:00 pm » |
|
Benvenuti alla newsletter che è il nostro appuntamento settimanale, ogni sabato mattina. Vi prometto una lettura molto personale di alcuni eventi globali che selezionerò come "la chiave" per dare un senso alla settimana. Con una particolare attenzione alle mie due sedi di lavoro, l'attuale e la precedente: New York e Pechino. "The place to be, and the place to look at..."
Non esitate a scrivermi: commenti o domande, contestazioni e proposte.
Classe 2024 o Generazione Gaza: e ora cosa succede all'America?
Prima di giudicare, cerchiamo di capire i campus
Classe 2024 ovvero Generazione Gaza. Per i disagi e le perturbazioni che provocano nella vita quotidiana di molte famiglie e in molte città, le proteste studentesche di questi giorni forse sono il tema più dibattuto fra gli americani (molto più del processo newyorchese a Donald Trump). L’America intera s’interroga sul significato di quest’agitazione, le sue ragioni o i suoi torti, l’impatto e le conseguenze che potrà avere in varie direzioni. Politica interna, politica estera, battaglia delle idee, egemonia culturale: tutto s’intreccia. Oltre ovviamente alla tragedia in corso in Medio Oriente. Vorrei cercare di vederci chiaro al di là del giudizio specifico sui contenuti di questo movimento, i suoi slogan, i suoi metodi di lotta.
La protesta si sta allargando
Prima constatazione, obiettiva: la protesta dilaga. Era cominciata in alcuni bastioni dell’accademia più élitaria come Harvard Columbia Yale, luoghi dove – nonostante la meritocrazia e le borse di studio – si formano soprattutto i figli della classe dirigente, con rette dai settantamila dollari annui in su (ormai si arriva facilmente a quota centomila). Ora le manifestazioni, gli accampamenti di occupazione, gli scontri con la polizia (quando questa viene chiamata a intervenire dalle autorità) si estendono ben oltre. A New York è entrato in agitazione anche il City College, che costa poco ed è frequentato dai figli dei ceti medio-bassi inclusi molti immigrati. Se i focolai iniziali erano concentrati soprattutto nell’America delle due coste dove domina la sinistra, ora si segnalano proteste in Stati del Sud che votano repubblicano.
Classi in remoto come nella pandemia
Le prime conseguenze, più immediate e facilmente verificabili, incidono sullo studio. Queste ragazze e ragazzi, appartenenti alla più ampia Generazione Z (i nati fra il 1997 e il 2012), spesso sono gli stessi che finirono il liceo o iniziarono il percorso universitario con la pandemia; pertanto hanno già sofferto un deficit di apprendimento oltre che di socializzazione. Ora alcuni atenei tornano ai corsi in remoto, quindi si rischia una sorta di prolungamento dell’esperimento Covid che non fu certo felice. In certe università si discute se cancellare la cerimonia della “graduation”, la consegna solenne e festosa dei titoli di laurea, un appuntamento molto sentito nella tradizione e molto partecipato dalle famiglie. Tutto ciò contribuisce a creare un’atmosfera di emergenza, che resterà scolpita nella memoria della Generazione 2024 o Generazione Gaza.
Autorità accademiche nella tempesta
Attorno a queste turbolenze, a cerchi concentrici, si agitano anche la vita politica e la classe di governo, a livello locale e nazionale. Presidenti e rettori delle università sono sotto assedio da più parti. Molti di questi leader sono donne, appartenenti a minoranze etniche, ed erano abituati ad amministrare sofficemente le regole del gioco della cultura “woke”, in ambienti accademici dall’egemonia culturale progressista. Gli studenti filo-palestinesi ora accusano presidenti/rettori di limitare la libertà di espressione se cercano di sgomberare i campus e di garantire l’agibilità delle aule. Fino a ieri però le stesse autorità accademiche erano accusate di aver consentito un clima di censura e intimidazione imposto dalla sinistra radicale, l’esclusione di voci conservatrici, e dal 7 ottobre 2023 avevano tollerato un’escalation di aggressioni antisemite. Se chiamano la polizia le autorità accademiche sono descritte come repressive, se non la chiamano sono succubi di frange estremiste e violente. Un altro argomento polemico che affiora da sinistra è il "ricatto" esercitato dai ricchi donatori della Jewish community per penalizzare università che hanno condonato l'antisemitismo. Ma nessuno storceva il naso quando gli stessi miliardari ebrei finanziavano centri studi e cattedre controllati dalla sinistra radicale. Su Gaza si sta consumando, tra l'altro, anche un divorzio tra due anime storiche del partito democratico Usa: ebrei progressisti e sinistra filo-araba.
Il mondo politico è coinvolto in tutti i modi. A New York è stato un sindaco democratico e black, Eric Adams, a chiamare la polizia al City College. Poco prima il presidente della Camera, il repubblicano Mike Johnson, aveva visitato la Columbia University per denunciarvi l’antisemitismo.
L' "altro Sessantotto" fece avanzare le destre
Nei sei mesi da qui alle elezioni l’uso politico di queste proteste è destinato a crescere. A metà strada (agosto) c’è un appuntamento come la convention democratica di Chicago che evoca inquietanti analogie con quella convention che nella stessa città si tenne nel 1968, in un crescendo di scontri fra la polizia e i manifestanti contro la guerra del Vietnam.
Se questo sia destinato a passare alla storia come un nuovo Sessantotto americano, oppure qualcosa di meno importante, è presto per dirlo. I bilanci sono prematuri e del resto anche la storia di 56 anni fa continua ad essere reinterpretata da revisionismi di ogni colore ideologico. Di sicuro quello che sta accadendo quest’anno è rilevante. A prescindere dalle nostre opinioni sul merito della questione – cioè su Gaza – questo movimento ci dice qualcosa sullo stato della società americana, e sullo stato dell’America nel mondo. L’agitazione studentesca rafforza l’influenza che la politica estera può avere nell’elezione del 5 novembre. D’altronde non riesco a ricordare in vita mia un anno elettorale con due guerre della gravità di Ucraina e Medio Oriente. I cortei violenti e gli scontri rilanciano anche temi più domestici come la sicurezza e l’ordine pubblico. Qui ricordo che il Sessantotto originario fa vincere le elezioni americane al conservatore Richard Nixon e quelle francesi al conservatore Charles De Gaulle: allora si parlava di una rivincita della “maggioranza silenziosa” contro la minoranza che occupava le piazze. In Italia il riflusso a destra arriva solo un po’ più tardi, con il governo Andreotti-Malagodi nel 1972.
Politica estera Usa, i problemi sono reali
La politica estera americana è un bersaglio proclamato di questo movimento studentesco. Non l’Ucraina, che lascia indifferenti i giovani, ma la Palestina. Sorvolo qui sui tanti (troppi) segnali di ignoranza o disinformazione tra i ragazzi di questa generazione (onestamente non erano meglio istruiti i ragazzi del ’68 né quelli del ’77). Invece voglio sottolineare due questioni serie e ineludibili, che sollevano i meglio preparati tra di loro. La prima va al cuore di una contraddizione di Joe Biden. Questo presidente eredita decenni di una politica di sostegno “incondizionato” a Israele (dal 1967). Quell’aggettivo messo tra virgolette è stato contestato a lungo e da più parti: l’America ha continuato a fornire aiuti militari ed economici a Israele anche quando i governi di Tel Aviv ignoravano le pressanti richieste di Washington e facevano scelte contrarie agli interessi veri degli Stati Uniti. Oggi quella contraddizione è esplosa più che mai. Pur difendendo il diritto all’esistenza dello Stato d’Israele, Biden è in forte contrasto con Netanyahu, sulla questione dello Stato palestinese, sugli aiuti umanitari, sulla condotta della guerra contro Hamas e sugli insediamenti di coloni in Cisgiordania. Però Biden non osa cancellare nei fatti l’aggettivo “incondizionato”: da una parte critica duramente Netanyahu, dall’altra continua a fornire aiuti militari decisivi alle forze armate israeliane. Gli studenti vorrebbero farli cessare subito. I contestatori considerano Biden politicamente e moralmente corresponsabile di quello che definiscono il genocidio dei civili a Gaza. Comunque si veda la questione, è un dato oggettivo che Gaza sta diventando “la guerra di Biden” come il Vietnam fu “la guerra di Lyndon Johnson”. Con le dovute e significative differenze: dal Vietnam ogni giorno tornavano delle bare con salme di giovani americani caduti al fronte. Nel 2024 l’America non combatte direttamente, o almeno non a Gaza, anche se alcune sue basi militari e le sue flotte sono intervenute: contro i missili e droni iraniani, contro gli Hezbollah, contro gli Houthi nel Mar Rosso.
"Disinvestimento" come in Sudafrica contro l'apartheid
In parallelo alle accuse a Biden, c’è un’altra campagna portata avanti dal movimento studentesco, quella sui “disinvestimenti”: i manifestanti esigono dalle loro ricchissime istituzioni universitarie (e in prospettiva dall’America tutta intera: aziende, banche) che chiudano ogni investimento suscettibile di aiutare gli insediamenti illegali di coloni israeliani in Cisgiordania o altre forme di sfruttamento della popolazione palestinese. Si ispirano esplicitamente alla campagna di disinvestimento che colpì il Sudafrica ai tempi del dominio razzista della minoranza bianca. Quel movimento di boicottaggio economico contribuì alla fine dell’apartheid e alla vittoria di Nelson Mandela contro l’apartheid (anche se non fu così decisivo come si tende a credere).
A ispirare la Classe 2024 o Generazione Gaza c’è una visione etica della politica estera: l’America dovrebbe comportarsi nel mondo intero in conformità con i valori e gli ideali a cui dice di ispirarsi nella sua Costituzione. Questo movimento si iscrive in una tradizione antica e nobile, radicata soprattutto nel partito democratico. E’ quella che ispirò il presidente Woodrow Wilson a fondare la Società delle Nazioni dopo la prima guerra mondiale e il presidente Franklin Roosevelt a fondare le Nazioni Unite dopo la seconda, per far rispettare principi di legalità a livello globale.
I peccati originali di questo movimento
All’interno di questa ispirazione molto apprezzabile, il movimento studentesco però si è macchiato di un peccato originale, o più d’uno. Il primo è ben noto e divenne evidente fin dalle prime ore successive al massacro di Hamas il 7 ottobre. Benvenuti alla newsletter che è il nostro appuntamento settimanale, ogni sabato mattina. Vi prometto una lettura molto personale di alcuni eventi globali che selezionerò come "la chiave" per dare un senso alla settimana. Con una particolare attenzione alle mie due sedi di lavoro, l'attuale e la precedente: New York e Pechino. "The place to be, and the place to look at..."
Non esitate a scrivermi: commenti o domande, contestazioni e proposte.
Classe 2024 o Generazione Gaza: e ora cosa succede all'America?
Prima di giudicare, cerchiamo di capire i campus
Classe 2024 ovvero Generazione Gaza. Per i disagi e le perturbazioni che provocano nella vita quotidiana di molte famiglie e in molte città, le proteste studentesche di questi giorni forse sono il tema più dibattuto fra gli americani (molto più del processo newyorchese a Donald Trump). L’America intera s’interroga sul significato di quest’agitazione, le sue ragioni o i suoi torti, l’impatto e le conseguenze che potrà avere in varie direzioni. Politica interna, politica estera, battaglia delle idee, egemonia culturale: tutto s’intreccia. Oltre ovviamente alla tragedia in corso in Medio Oriente. Vorrei cercare di vederci chiaro al di là del giudizio specifico sui contenuti di questo movimento, i suoi slogan, i suoi metodi di lotta.
La protesta si sta allargando
Prima constatazione, obiettiva: la protesta dilaga. Era cominciata in alcuni bastioni dell’accademia più élitaria come Harvard Columbia Yale, luoghi dove – nonostante la meritocrazia e le borse di studio – si formano soprattutto i figli della classe dirigente, con rette dai settantamila dollari annui in su (ormai si arriva facilmente a quota centomila). Ora le manifestazioni, gli accampamenti di occupazione, gli scontri con la polizia (quando questa viene chiamata a intervenire dalle autorità) si estendono ben oltre. A New York è entrato in agitazione anche il City College, che costa poco ed è frequentato dai figli dei ceti medio-bassi inclusi molti immigrati. Se i focolai iniziali erano concentrati soprattutto nell’America delle due coste dove domina la sinistra, ora si segnalano proteste in Stati del Sud che votano repubblicano.
Classi in remoto come nella pandemia
Le prime conseguenze, più immediate e facilmente verificabili, incidono sullo studio. Queste ragazze e ragazzi, appartenenti alla più ampia Generazione Z (i nati fra il 1997 e il 2012), spesso sono gli stessi che finirono il liceo o iniziarono il percorso universitario con la pandemia; pertanto hanno già sofferto un deficit di apprendimento oltre che di socializzazione. Ora alcuni atenei tornano ai corsi in remoto, quindi si rischia una sorta di prolungamento dell’esperimento Covid che non fu certo felice. In certe università si discute se cancellare la cerimonia della “graduation”, la consegna solenne e festosa dei titoli di laurea, un appuntamento molto sentito nella tradizione e molto partecipato dalle famiglie. Tutto ciò contribuisce a creare un’atmosfera di emergenza, che resterà scolpita nella memoria della Generazione 2024 o Generazione Gaza.
Autorità accademiche nella tempesta
Attorno a queste turbolenze, a cerchi concentrici, si agitano anche la vita politica e la classe di governo, a livello locale e nazionale. Presidenti e rettori delle università sono sotto assedio da più parti. Molti di questi leader sono donne, appartenenti a minoranze etniche, ed erano abituati ad amministrare sofficemente le regole del gioco della cultura “woke”, in ambienti accademici dall’egemonia culturale progressista. Gli studenti filo-palestinesi ora accusano presidenti/rettori di limitare la libertà di espressione se cercano di sgomberare i campus e di garantire l’agibilità delle aule. Fino a ieri però le stesse autorità accademiche erano accusate di aver consentito un clima di censura e intimidazione imposto dalla sinistra radicale, l’esclusione di voci conservatrici, e dal 7 ottobre 2023 avevano tollerato un’escalation di aggressioni antisemite. Se chiamano la polizia le autorità accademiche sono descritte come repressive, se non la chiamano sono succubi di frange estremiste e violente. Un altro argomento polemico che affiora da sinistra è il "ricatto" esercitato dai ricchi donatori della Jewish community per penalizzare università che hanno condonato l'antisemitismo. Ma nessuno storceva il naso quando gli stessi miliardari ebrei finanziavano centri studi e cattedre controllati dalla sinistra radicale. Su Gaza si sta consumando, tra l'altro, anche un divorzio tra due anime storiche del partito democratico Usa: ebrei progressisti e sinistra filo-araba.
Il mondo politico è coinvolto in tutti i modi. A New York è stato un sindaco democratico e black, Eric Adams, a chiamare la polizia al City College. Poco prima il presidente della Camera, il repubblicano Mike Johnson, aveva visitato la Columbia University per denunciarvi l’antisemitismo.
L' "altro Sessantotto" fece avanzare le destre
Nei sei mesi da qui alle elezioni l’uso politico di queste proteste è destinato a crescere. A metà strada (agosto) c’è un appuntamento come la convention democratica di Chicago che evoca inquietanti analogie con quella convention che nella stessa città si tenne nel 1968, in un crescendo di scontri fra la polizia e i manifestanti contro la guerra del Vietnam.
Se questo sia destinato a passare alla storia come un nuovo Sessantotto americano, oppure qualcosa di meno importante, è presto per dirlo. I bilanci sono prematuri e del resto anche la storia di 56 anni fa continua ad essere reinterpretata da revisionismi di ogni colore ideologico. Di sicuro quello che sta accadendo quest’anno è rilevante. A prescindere dalle nostre opinioni sul merito della questione – cioè su Gaza – questo movimento ci dice qualcosa sullo stato della società americana, e sullo stato dell’America nel mondo. L’agitazione studentesca rafforza l’influenza che la politica estera può avere nell’elezione del 5 novembre. D’altronde non riesco a ricordare in vita mia un anno elettorale con due guerre della gravità di Ucraina e Medio Oriente. I cortei violenti e gli scontri rilanciano anche temi più domestici come la sicurezza e l’ordine pubblico. Qui ricordo che il Sessantotto originario fa vincere le elezioni americane al conservatore Richard Nixon e quelle francesi al conservatore Charles De Gaulle: allora si parlava di una rivincita della “maggioranza silenziosa” contro la minoranza che occupava le piazze. In Italia il riflusso a destra arriva solo un po’ più tardi, con il governo Andreotti-Malagodi nel 1972.
Politica estera Usa, i problemi sono reali
La politica estera americana è un bersaglio proclamato di questo movimento studentesco. Non l’Ucraina, che lascia indifferenti i giovani, ma la Palestina. Sorvolo qui sui tanti (troppi) segnali di ignoranza o disinformazione tra i ragazzi di questa generazione (onestamente non erano meglio istruiti i ragazzi del ’68 né quelli del ’77). Invece voglio sottolineare due questioni serie e ineludibili, che sollevano i meglio preparati tra di loro. La prima va al cuore di una contraddizione di Joe Biden. Questo presidente eredita decenni di una politica di sostegno “incondizionato” a Israele (dal 1967). Quell’aggettivo messo tra virgolette è stato contestato a lungo e da più parti: l’America ha continuato a fornire aiuti militari ed economici a Israele anche quando i governi di Tel Aviv ignoravano le pressanti richieste di Washington e facevano scelte contrarie agli interessi veri degli Stati Uniti. Oggi quella contraddizione è esplosa più che mai. Pur difendendo il diritto all’esistenza dello Stato d’Israele, Biden è in forte contrasto con Netanyahu, sulla questione dello Stato palestinese, sugli aiuti umanitari, sulla condotta della guerra contro Hamas e sugli insediamenti di coloni in Cisgiordania. Però Biden non osa cancellare nei fatti l’aggettivo “incondizionato”: da una parte critica duramente Netanyahu, dall’altra continua a fornire aiuti militari decisivi alle forze armate israeliane. Gli studenti vorrebbero farli cessare subito. I contestatori considerano Biden politicamente e moralmente corresponsabile di quello che definiscono il genocidio dei civili a Gaza. Comunque si veda la questione, è un dato oggettivo che Gaza sta diventando “la guerra di Biden” come il Vietnam fu “la guerra di Lyndon Johnson”. Con le dovute e significative differenze: dal Vietnam ogni giorno tornavano delle bare con salme di giovani americani caduti al fronte. Nel 2024 l’America non combatte direttamente, o almeno non a Gaza, anche se alcune sue basi militari e le sue flotte sono intervenute: contro i missili e droni iraniani, contro gli Hezbollah, contro gli Houthi nel Mar Rosso.
"Disinvestimento" come in Sudafrica contro l'apartheid
In parallelo alle accuse a Biden, c’è un’altra campagna portata avanti dal movimento studentesco, quella sui “disinvestimenti”: i manifestanti esigono dalle loro ricchissime istituzioni universitarie (e in prospettiva dall’America tutta intera: aziende, banche) che chiudano ogni investimento suscettibile di aiutare gli insediamenti illegali di coloni israeliani in Cisgiordania o altre forme di sfruttamento della popolazione palestinese. Si ispirano esplicitamente alla campagna di disinvestimento che colpì il Sudafrica ai tempi del dominio razzista della minoranza bianca. Quel movimento di boicottaggio economico contribuì alla fine dell’apartheid e alla vittoria di Nelson Mandela contro l’apartheid (anche se non fu così decisivo come si tende a credere).
A ispirare la Classe 2024 o Generazione Gaza c’è una visione etica della politica estera: l’America dovrebbe comportarsi nel mondo intero in conformità con i valori e gli ideali a cui dice di ispirarsi nella sua Costituzione. Questo movimento si iscrive in una tradizione antica e nobile, radicata soprattutto nel partito democratico. E’ quella che ispirò il presidente Woodrow Wilson a fondare la Società delle Nazioni dopo la prima guerra mondiale e il presidente Franklin Roosevelt a fondare le Nazioni Unite dopo la seconda, per far rispettare principi di legalità a livello globale.
I peccati originali di questo movimento
All’interno di questa ispirazione molto apprezzabile, il movimento studentesco però si è macchiato di un peccato originale, o più d’uno. Il primo è ben noto e divenne evidente fin dalle prime ore successive al massacro di Hamas il 7 ottobre. Una miriade di associazioni studentesche presero posizioni ignobili, immorali, inaccettabili: approvarono subito e con entusiasmo la strage di civili israeliani, lo stupro in massa di donne, il rapimento di bambini. Molto prima che arrivasse la controffensiva israeliana a fare un'ecatombe a Gaza. La violenza feroce, le torture crudeli, gli stupri, tutto fu assolto in quanto giusta vendetta per i torti subiti dai palestinesi. Quell’usare due pesi e due misure – la violenza israeliana è orribile, quella di Hamas è sacrosanta – continua tuttora e perseguita il movimento. Lo espone alle accuse di antisemitismo, che sono giustificate da innumerevoli atti di aggressione avvenuti nei campus, molti dei quali sono diventati dei luoghi non solo inospitali ma perfino insicuri per studenti di origini ebraiche o di nazionalità israeliana.
Indottrinamento e fanatismo
Questa macchia si collega ad un altro peccato originale, che non si riferisce solo a Gaza ma all’ideologia prevalente nella Generazione 2024. Ne ho scritto altre volte, è un’ideologia che risale a cattivi maestri come Michel Foucault o Toni Negri. Interpreta l’intera storia delle civiltà e l’universo mondo attraverso il trittico Potere Oppressione Privilegio; divide l’umanità in oppressi e oppressori, sfruttati e sfruttatori; schiaccia la complessità dentro categorie manichee (buoni-cattivi, bianco-nero); riduce quindi il mondo contemporaneo a una massa di vittime (il Grande Sud globale, gli ex-colonizzati, le minoranze etniche dei nostri paesi) e un unico carnefice che è la razza bianca, dominatrice, aggressiva. Fanatismo, intolleranza, perfino l’apologia della violenza (quella di Hamas) derivano da questa visione del mondo.
Non è una novità. Tutte le rivoluzioni di ogni colore, dai giacobini di Robespierre ai bolscevichi di Lenin, dagli squadristi di Mussolini nella marcia su Roma alle Guardie rosse di Mao Zedong, fino alle rivoluzioni religiose come quella di Khomeini in Iran, tutte senza eccezioni hanno avuto bisogno di disumanizzare la storia, demonizzare l’avversario, dividere il mondo in buoni e cattivi, per aizzare le masse e giustificare la violenza.
Leggete questa intellettuale progressista, e poi Musk
Se pensate che esagero nell’avvicinare quel tipo di precedenti storici alla società americana del 2024, ecco cosa scrive una brava opinionista del New York Times, una “progressista critica”, Pamela Paul, in un commento efficacemente intitolato Hai subito un torto, non vuol dire che tu abbia ragione.: “Viviamo in un’età dell’oro della lamentela per i torti subiti. … Se sei di sinistra sei stato oppresso, escluso, emarginato, silenziato, cancellato, ferito, sottorappresentato, traumatizzato e danneggiato. Se sei di destra sei stato ignorato, disprezzato, sottovalutato, zittito, caricaturizzato e irriso. … Gli esseri umani si sono sempre combattuti per l’accesso ineguale a risorse scarse. Però mai come oggi la nostra cultura ha fatto della lamentela una forza motrice così vigorosa, e un gioco a somma zero in cui ciascuna parte si sente lesa. … Riflettiamo su un fenomeno progressista: la gerarchia del privilegio viene rovesciata così che le voci marginalizzate in precedenza ora hanno la priorità. Valido, in teoria. Ma chi decide, e su quali basi? Chi è più oppresso: un vecchio bianco veterano dell’esercito e portatore di handicap, o un giovane gay di origini latinos? Individui o tribù vengono classificati secondo categorie binarie: colonizzatore contro colonizzato, oppressore contro oppresso, privilegiato e non. Nelle università e nelle ong, nei luoghi di lavoro e nelle istituzioni statali, la gente può recitare la propria lamentela e vittimizzazione, trasformandola in un’arma, sa che può appellarsi allo Stato, all’ufficio del personale o al tribunale dei social, dove sarà ricompensata con attenzione”.
Sul versante opposto dello spettro politico rispetto a Pamela Paul, l’anarco-libertario-capitalista Elon Musk scrive su X: “L’assiomatico errore che mina alle fondamenta gran parte della civiltà occidentale è il concetto che la debolezza ti dà ragione. Se si accetta che gli oppressi sono sempre i buoni la conclusione naturale è che i forti sono cattivi”.
Se sei ricco hai rubato a un povero? Marx se la ride...
L’assioma descritto da Musk comanda la Generazione Gaza. Di fronte a qualsiasi evento storico ci si chiede prima di tutto qual è la parte meno forte o meno ricca; quindi, ci si schiera in sua difesa perché quella è la parte moralmente superiore.
Traducendo Musk, la Generazione Gaza è cresciuta nella certezza che “se sei ricco devi aver derubato un povero”: grottesca caricatura del marxismo, che non è così banale. Da quando le università hanno smesso di insegnare una storia positiva del Progresso? (Risposta: dagli anni Sessanta, basta verificare l’evoluzione dei programmi e dei titoli dei corsi nelle università Usa). Nella demonizzazione del Progresso, oggi obbligatoria, è proibito studiare se alcune nazioni, civiltà, classi dirigenti abbiano adottato ricette efficaci per creare e diffondere prosperità e diritti; mentre i popoli poveri possono anche essere vittime di leader oppressivi autoctoni, sistemi di valori retrogradi.
Applicato ai palestinesi questo meccanismo impedisce di addentrarsi nei meandri di una storia labirintica, evita di fare i conti con i molteplici errori commessi dagli stessi palestinesi (leader e popolo) fino alla tragica impasse attuale, sorvola su forze potentissime che aizzano i deboli (l’Iran con il suo petrolio, i suoi arsenali e il suo fanatismo religioso, le varie milizie terroristiche che hanno fatto della violenza una rendita politica). Ignora che gli ebrei residenti nel territorio d’Israele non sono tutti “bianchi”. Eccetera eccetera. Non è questo il luogo per accennare ai mille capitoli controversi della storia mediorientale e della questione israelo-palestinese. Il luogo adatto sarebbero proprio le aule universitarie. Dove però da molti anni non si dibatte, si indottrina e si fa lavaggio del cervello.
Quella situazione descritta da Pamela Paul chiama in causa non solo la Generazione Gaza bensì pure i suoi cattivi maestri.
6 gennaio 2021, la destra "legittimata"?
Richiamo l’attenzione su un passaggio iniziale della Paul, in cui si riferisce alla destra trumpiana. Lei ci torna con questa frase: “Cosa fu in fondo il 6 gennaio 2021 se non una gigantesca esplosione di rabbia da parte di coloro che si sentivano ingannati e volevano ottenere risarcimenti, con qualsiasi mezzo?”
Ecco, quel che accade nei campus universitari in questi giorni come viene visto dagli elettori repubblicani? Come una conferma che la sinistra in fatto di violenza ha due pesi e due misure, vede una violenza “fascista” e una violenza “giusta” perché viene dagli “oppressi”. Fu così anche in quella terribile estate del 2020 che precedette l’insurrezione del 6 gennaio al Campidoglio. Dopo l’assassinio dell’afroamericano George Floyd per settimane fu normale vedere commissariati di polizia e altre sedi istituzionali assaltati e incendiati da manifestanti di Black Lives Matter. Poi per altri mesi alcune zone del paese (ad esempio il centro di Portland nell’Oregon) divennero ufficialmente delle zone “liberate dalla polizia”, dove le forze dell’ordine non potevano più mettere piede.
Oggi corriamo il rischio che la Generazione Gaza si senta legittimata all’uso della violenza, a tal punto da farvi ricorso in modo sistematico? L’altro Sessantotto, quello di 56 anni fa, vide la diffusione della lotta armata negli Stati Uniti, in Italia, Francia, Germania. Onestamente, non siamo ancora arrivati a questo punto, non mi pare proprio.
Forza dell'economia Usa, un fattore di pace sociale
Una delle ragioni che prevengono il contagio delle proteste e della violenza, forse, è l’ottima situazione economica di cui l’America ha goduto finora: alta crescita, piena occupazione. L'altroieri è uscito un dato che segnala un rallentamento della crescita, e l'inflazione non è stata debellata. Però nell'insieme il quadro rimane positivo, migliore che in molte parti del mondo. E ne beneficiano un po' tutti.
La Generazione Z è ricca, economicamente sta meglio di come stavano le generazioni dei suoi fratelli maggiori o dei suoi genitori quando avevano la stessa età. E’ turbata, è sofferente, per mille motivi, ma non vive in un periodo di crisi economica o di ingiustizie sociali acute. Gli aumenti salariali e gli aiuti pubblici del periodo pandemico hanno perfino attenuato certe diseguaglianze. I lavoratori appartenenti a minoranze etniche – black, latinos – non sono mai stati così bene. Le tensioni politiche e culturali sono acute, ma non poggiano su problemi materiali.
Non è detto che questa situazione duri, però. La forza dell’economia americana in parte è virtuosa, è legata alla sua capacità d’innovazione e al dinamismo delle sue imprese. In parte invece è drogata da una spesa pubblica in deficit che aumentò a dismisura sotto Trump per il Covid, e ha continuato a crescere sotto Biden (ivi compreso per un “voto di scambio” a vantaggio degli studenti universitari: la generosa, costosa e iniqua cancellazione dei loro debiti a carico del contribuente). Non ho la capacità di distinguere quanta parte della crescita economica Usa sia “sana” e quanta “malsana”.
Il quadro mondiale: perdita di consensi
Alla forza di questa economia si contrappone un crescente isolamento dell’America rispetto al resto del mondo. Isolamento relativo, s’intende: la comunità transatlantica rimane un blocco straordinariamente ricco e influente. Se all’Europa si aggiungono i numerosi alleati asiatici – Giappone, Corea del Sud, Filippine – più Australia e Nuova Zelanda, “l’Occidente allargato” è molto grosso. Però in termini di popolazione il resto del mondo è ancora più grosso, e cresce di più.
Come il Vietnam negli anni Sessanta segnò una ferita grave per la legittimità, credibilità, autorevolezza degli Stati Uniti nel mondo, così in una certa misura sta avvenendo oggi per Gaza. “La guerra di Biden” fa perdere all’America consensi preziosi nel Grande Sud globale. Non è del tutto casuale che altri due paesi africani – Niger e Ciad – abbiano appena cacciato i militari americani.
La sorpresa "finale" degli anni Sessanta
I paragoni storici vanno maneggiati con prudenza e umiltà. Voglio ricordare tuttavia che negli anni Sessanta l’America sembrava “perduta”: sia agli occhi della sua Generazione Sessantotto, sia agli occhi di gran parte del mondo affascinato dal comunismo sovietico o cubano, dal maoismo cinese, dalle varie rivoluzioni post-coloniali, dalle rivolte studentesche. Poi invece dell’America fu l’Unione sovietica a implodere, e fu la Cina ad abbandonare il maoismo.
L’America lacerata e sgomenta degli anni Sessanta senza saperlo stava soffrendo anche le doglie di un parto molto speciale: la rivoluzione informatica, l’avvento del computer, la primavera della Silicon Valley. Nonché tante forme di ambientalismo, femminismo, anti-razzismo che la Generazione Gaza forse crede di avere inventato.
Il confronto-sfida tra l’America di questi giorni e i suoi grandi rivali come la Cina, continuerà a dipanarsi per anni, con chissà quanti colpi di scena. Un frammento di lezione dagli anni Sessanta forse è questo: le crisi che esplodono alla luce del sole, quelle crisi visibili e rumorose che vengono recitate in piazza nelle nostre democrazie, non sono necessariamente quelle più pericolose per la sopravvivenza di un sistema. Quando un sistema è stato disegnato all'origine per essere elastico e assorbire gli urti.
Perché non ci sono "cure economiche" per la denatalità (e cosa ci unisce alla Cina)
Gli allarmi sulla denatalità si susseguono e si assomigliano: in Italia come in tante altre parti del mondo, Cina inclusa. In genere nei paesi democratici chi sta all’opposizione accusa chi sta al governo di non fare abbastanza per aiutare le donne, per sostenere le famiglie, per promuovere le nascite. (In Cina non può esistere un’opposizione, ma il governo è preoccupato lo stesso).
I cosiddetti esperti, che pochi anni prima gridavano al disastro per la “bomba demografica” e la “sovrappopolazione”, ora lanciano urli di terrore per lo “spopolamento”, e così via.
In mezzo a tanto frastuono inutile, è una bella sorpresa trovare un’analisi lucida, precisa, fattuale. L’ha scritta John Burn Murdoch sul Financial Times. E’ una sintesi di vari studi sulla denatalità, che convergono su questa conclusione: gli aiuti alle giovani donne, alle future mamme, o alle coppie, sono una bella cosa in sé ma non influenzano affatto la decisione di fare figli. L’aspetto economico è irrilevante, in quella decisione.
Questo del resto dovrebbe essere abbastanza ovvio, è una conclusione di buon senso, di fronte a un’osservazione empirica: i tassi di fertilità e natalità rimangono più elevati in paesi più poveri, quindi non è certo la mancanza di mezzi a giustificare il crollo delle nascite nei paesi ricchi.
Sono fondamentali invece dei fattori culturali. Il più importante di tutti sembra essere la fiducia nel futuro. Una generazione convinta di essere alla vigilia dell’Apocalisse, o di vivere in una civiltà malvagia, in un mondo infernale segnato dalle peggiori ingiustizie, perché mai dovrebbe fare figli? Per condannarli all’inferno?
Un altro fattore culturale si può riassumere nel concetto esagerato e iperprotettivo dei diritti del nascituro: se questa creatura deve assorbire il massimo dell’attenzione, delle cure, degli investimenti in educazione, l’asticella forse è un po’ troppo alta, la responsabilità genitoriale fa tremare le vene ai polsi. Fin qui ho riassunto con parole mie.
Ecco invece la sintesi degli studi su natalità e demografia raccolti da Burn-Murdoch. Dal 1980 al 2019 l’insieme dei paesi ricchi e sviluppati ha triplicato (al netto dell’inflazione, quindi in potere d’acquisto reale) gli aiuti pro-capite per la natalità: assegni familiari, asili nido gratuiti, permessi di maternità-paternità, e altri sussidi pubblici. Nello stesso periodo il numero di nascite è sceso inesorabilmente, in media da 1,85 a 1,53 per ogni donna.
La Finlandia è un paese egualitario, con un Welfare generosissimo. Ha uno dei sistemi più avanzati al mondo per assistere e sostenere le famiglie (tradizionali e non) che vogliono avere figli. Nonostante questo il tasso di fertilità finlandese è caduto di un terzo dal 2010. L’Ungheria, che per motivi ideologici fa di tutto per promuovere le nascite, ha toccato il suo minimo storico. In Corea del Sud il governo ha lanciato un programma munifico di pagamenti a chi fa figli, detto “baby bonus”: il bilancio è semplice, quel programma ha pagato donne che avevano già deciso di farli per conto proprio, mentre non ha spostato il trend di calo della natalità che prosegue imperterrito. Come si vede non ci sono differenze tra politiche di sinistra (Finlandia) e di destra (Ungheria), né tra Oriente e Occidente.
L’autore di questa sintesi commenta: “Il legame tra le nascite e la spesa pubblica per politiche in favore della famiglia, è trascurabile. Si scopre che la decisione se avere figli oppure no, e quanti farne, è influenzata da molte altre cose anziché dal denaro”. Questo non significa che sia sbagliato dare aiuti alle mamme o future mamme. Può essere giusto per tante ragioni. Può rendere la vita un po’ più facile a quelle donne che hanno comunque deciso di avere figli, un obiettivo in sé lodevole. Può servire a ridurre la povertà infantile nelle famiglie a basso reddito. Tutte cose buone, basta non illudersi che servano a invertire la tendenza alla denatalità. “I fattori culturali intervengono a monte nelle decisioni, molto prima che i costi di allevare un figlio siano presi in considerazione”.
Uno studio di Matthias Doepke e Fabrizio Zillibotti del 2019, intitolato “Money and Parenting: How Economics Explain the Way We Raise Our Kids”, viene usato per le sue conclusioni illuminanti. Cita la convinzione diffusa tra le giovani generazioni, che per dare a un figlio un futuro soddisfacente bisogna occuparsi moltissimo di lui o lei, garantirgli la massima attenzione dei genitori, e investire in un’istruzione di livello superlativo, in concorrenza sfrenata con i figli degli altri. La sfida, descritta in termini così impegnativi da risultare quasi spaventosi, finisce per apparire irraggiungibile a molti. Meglio accontentarsi di una vita “normale”, da single o da sposati senza figli, anziché sobbarcarsi una responsabilità simile. In parallelo, un’altra evoluzione culturale ha spostato le priorità della vita per i giovani adulti. Nel 1993 il 61% degli americani intervistati in un’indagine del Pew Research diceva che avere figli è importante per una vita appagante; oggi solo il 26% condivide quell’affermazione. Le giovani donne in particolare hanno spostato le priorità mettendo al vertice la “crescita personale” e la “carriera professionale”. Le paure legate all’eccesso di responsabilità come genitori figurano in modo rilevante tra le ragioni per non avere figli. I costi economici appaiono solo al 14esimo posto.
Infine interviene il livello di angoscia delle giovani generazioni. “Più una potenziale mamma è preoccupata sul futuro, meno vuole avere figli. In America, in Europa, in Estremo Oriente, la generazione sotto i trent’anni è più impaurita dal futuro e più stressata rispetto alle altre generazioni”.
Concludo con la Cina, stavolta attingendo al racconto di Peter Hessler sul magazine The New Yorker dell’8 aprile 2024. Prima ancora di essere stato un corrispondente in Cina per quel settimanale, Hessler aveva insegnato l’inglese in una università del Sichuan. E’ rimasto in contatto con i suoi ex-studenti e spesso li consulta per capire lo stato d’animo della gioventù cinese. Quasi nessuno di loro ha avuto o vuole avere figli. Le risposte negative raggiungono il massimo tra le ragazze: 76%. Questo suo sondaggio empirico, su un campione limitato, coincide con i risultati di altre indagini più vaste. Del resto è noto che la Cina è entrata in una fase di decrescita della popolazione per effetto di un crollo delle nascite. A nulla sono serviti i provvedimenti presi dal governo. Le autorità di Pechino sono passate a gran velocità dalla politica del “figlio unico” alla libertà di fare due, tre figli. Infine dalla libertà il regime è passato agli incentivi: ora paga le mamme perché facciano bambini. I risultati sono insignificanti. Ecco la spiegazione offerta da una ex-studentessa di Hassler: “Io penso che i bambini cinesi sono stressati e turbati. Siamo già noi una generazione turbata. Allevare dei figli richiede lunghi periodi di affiatamento e di osservazione e di guida, tutte cose difficili da garantire in un contesto di pressione sociale intensa. Il futuro della società cinese è un’incognita. I bambini non ci chiedono di essere messi al mondo. Io ho paura che i miei figli potenziali non siano dei guerrieri, e finiscano per perdersi”.
La Cina in cui abitai io era una nazione molto più ottimista e fiduciosa nel suo futuro. Quella di oggi, nella mentalità dei giovani, sembra molto più simile all’Occidente. Le politiche in favore della natalità sono un falso problema.
Perché l'Africa caccia gli americani (c'entra Putin)
In poco più di una settimana, l'America ha perso due alleati africani, o quantomeno due presenze militari in questo continente. Prima il Niger poi il Ciad hanno dato il benservito ai militari Usa. Sono destinati a essere sostituiti dai russi: quasi certamente in Niger, mentre la situazione in Ciad è più aperta.
Il contraccolpo è stato sentito a Washington che vede arretrare la sua strategia africana. Accade in parallelo con le bocciature subite nei mesi e anni precedenti dalla Francia, i cui militari sono stati anch'essi espulsi da molti paesi. Spesso per essere sostituiti dai russi o dal Gruppo Wagner, i mercenari controllati da Mosca.
L'espulsione dei militari americani dal Niger è stata definita da diversi esperti Usa come un duro colpo alla strategia di Washington contro le forze jihadiste in Africa occidentale. Il Niger era un pilastro di quella strategia, ospitava la più grossa base militare Usa di tutta l'Africa occidentale, con mille soldati; e una base di droni costruita ad Agadez con un investimento di 110 milioni di dollari. Fino all'anno scorso i Berretti Verdi americani di stanza in Niger addestravano le truppe locali a combattere contro una delle più ampie guerriglie jihadiste del mondo, e i droni made in Usa contribuivano a spiare le milizie islamiste. A questo punto l'America deve ripiegare su un piano B, più limitato e difensivo: cercando di arginare il contagio jihadista in paesi vicini che ancora accolgono la presenza Usa, anziché andare all'offensiva contro il cuore delle forze islamiste.
Cos'ha provocato la cacciata? L'anno scorso in Niger c'è stato un colpo di Stato militare, condannato dalla Casa Bianca. L'Amministrazione Biden ha fatto pressione sulla giunta golpista perché ristabilisca un governo civile e legittimo. A quel punto i generali, guidati dal presidente Mohamed Bazoum, hanno cominciato a spostarsi verso un'alleanza con Mosca. Di recente la capitale del Niger Niamey è stata il teatro di manifestazioni anti-americane, probabilmente orchestrate dal regime. Ed è arrivata la richiesta formale di riportare a casa i mille soldati americani.
La situazione nel Ciad sembra più fluida. Lì la presenza militare Usa era molto più limitata: 75 soldati dei reparti speciali a Ndjamena, capitale del Ciad. Al momento sono stati rimpatriati anche loro. Come nel Niger, pure questi Berretti Verdi (del 20th Special Forces Group, un reparto della Guardia Nazionale dell'Alabama) erano lì come consiglieri e addestratori anti-terrorismo. Il Ciad ha un ruolo essenziale nelle operazioni contro Boko Haram. Pentagono e Dipartimento di Stato hanno l'impressione che la loro cacciata possa essere temporanea, una mossa negoziale con cui il presidente del Ciad potrebbe alzare il prezzo della sua cooperazione, mettendo in concorrenza Stati Uniti e Russia.
La Francia a sua volta era stata allontanata da Mali e Burkina Faso, in favore dei russi.
Federico Rampini, New York 27 aprile 2024
approvarono subito e con entusiasmo la strage di civili israeliani, lo stupro in massa di donne, il rapimento di bambini. Molto prima che arrivasse la controffensiva israeliana a fare un'ecatombe a Gaza. La violenza feroce, le torture crudeli, gli stupri, tutto fu assolto in quanto giusta vendetta per i torti subiti dai palestinesi. Quell’usare due pesi e due misure – la violenza israeliana è orribile, quella di Hamas è sacrosanta – continua tuttora e perseguita il movimento. Lo espone alle accuse di antisemitismo, che sono giustificate da innumerevoli atti di aggressione avvenuti nei campus, molti dei quali sono diventati dei luoghi non solo inospitali ma perfino insicuri per studenti di origini ebraiche o di nazionalità israeliana.
Indottrinamento e fanatismo
Questa macchia si collega ad un altro peccato originale, che non si riferisce solo a Gaza ma all’ideologia prevalente nella Generazione 2024. Ne ho scritto altre volte, è un’ideologia che risale a cattivi maestri come Michel Foucault o Toni Negri. Interpreta l’intera storia delle civiltà e l’universo mondo attraverso il trittico Potere Oppressione Privilegio; divide l’umanità in oppressi e oppressori, sfruttati e sfruttatori; schiaccia la complessità dentro categorie manichee (buoni-cattivi, bianco-nero); riduce quindi il mondo contemporaneo a una massa di vittime (il Grande Sud globale, gli ex-colonizzati, le minoranze etniche dei nostri paesi) e un unico carnefice che è la razza bianca, dominatrice, aggressiva. Fanatismo, intolleranza, perfino l’apologia della violenza (quella di Hamas) derivano da questa visione del mondo.
Non è una novità. Tutte le rivoluzioni di ogni colore, dai giacobini di Robespierre ai bolscevichi di Lenin, dagli squadristi di Mussolini nella marcia su Roma alle Guardie rosse di Mao Zedong, fino alle rivoluzioni religiose come quella di Khomeini in Iran, tutte senza eccezioni hanno avuto bisogno di disumanizzare la storia, demonizzare l’avversario, dividere il mondo in buoni e cattivi, per aizzare le masse e giustificare la violenza.
Leggete questa intellettuale progressista, e poi Musk
Se pensate che esagero nell’avvicinare quel tipo di precedenti storici alla società americana del 2024, ecco cosa scrive una brava opinionista del New York Times, una “progressista critica”, Pamela Paul, in un commento efficacemente intitolato Hai subito un torto, non vuol dire che tu abbia ragione.: “Viviamo in un’età dell’oro della lamentela per i torti subiti. … Se sei di sinistra sei stato oppresso, escluso, emarginato, silenziato, cancellato, ferito, sottorappresentato, traumatizzato e danneggiato. Se sei di destra sei stato ignorato, disprezzato, sottovalutato, zittito, caricaturizzato e irriso. … Gli esseri umani si sono sempre combattuti per l’accesso ineguale a risorse scarse. Però mai come oggi la nostra cultura ha fatto della lamentela una forza motrice così vigorosa, e un gioco a somma zero in cui ciascuna parte si sente lesa. … Riflettiamo su un fenomeno progressista: la gerarchia del privilegio viene rovesciata così che le voci marginalizzate in precedenza ora hanno la priorità. Valido, in teoria. Ma chi decide, e su quali basi? Chi è più oppresso: un vecchio bianco veterano dell’esercito e portatore di handicap, o un giovane gay di origini latinos? Individui o tribù vengono classificati secondo categorie binarie: colonizzatore contro colonizzato, oppressore contro oppresso, privilegiato e non. Nelle università e nelle ong, nei luoghi di lavoro e nelle istituzioni statali, la gente può recitare la propria lamentela e vittimizzazione, trasformandola in un’arma, sa che può appellarsi allo Stato, all’ufficio del personale o al tribunale dei social, dove sarà ricompensata con attenzione”.
Sul versante opposto dello spettro politico rispetto a Pamela Paul, l’anarco-libertario-capitalista Elon Musk scrive su X: “L’assiomatico errore che mina alle fondamenta gran parte della civiltà occidentale è il concetto che la debolezza ti dà ragione. Se si accetta che gli oppressi sono sempre i buoni la conclusione naturale è che i forti sono cattivi”.
Se sei ricco hai rubato a un povero? Marx se la ride...
L’assioma descritto da Musk comanda la Generazione Gaza. Di fronte a qualsiasi evento storico ci si chiede prima di tutto qual è la parte meno forte o meno ricca; quindi, ci si schiera in sua difesa perché quella è la parte moralmente superiore.
Traducendo Musk, la Generazione Gaza è cresciuta nella certezza che “se sei ricco devi aver derubato un povero”: grottesca caricatura del marxismo, che non è così banale. Da quando le università hanno smesso di insegnare una storia positiva del Progresso? (Risposta: dagli anni Sessanta, basta verificare l’evoluzione dei programmi e dei titoli dei corsi nelle università Usa). Nella demonizzazione del Progresso, oggi obbligatoria, è proibito studiare se alcune nazioni, civiltà, classi dirigenti abbiano adottato ricette efficaci per creare e diffondere prosperità e diritti; mentre i popoli poveri possono anche essere vittime di leader oppressivi autoctoni, sistemi di valori retrogradi.
Applicato ai palestinesi questo meccanismo impedisce di addentrarsi nei meandri di una storia labirintica, evita di fare i conti con i molteplici errori commessi dagli stessi palestinesi (leader e popolo) fino alla tragica impasse attuale, sorvola su forze potentissime che aizzano i deboli (l’Iran con il suo petrolio, i suoi arsenali e il suo fanatismo religioso, le varie milizie terroristiche che hanno fatto della violenza una rendita politica). Ignora che gli ebrei residenti nel territorio d’Israele non sono tutti “bianchi”. Eccetera eccetera. Non è questo il luogo per accennare ai mille capitoli controversi della storia mediorientale e della questione israelo-palestinese. Il luogo adatto sarebbero proprio le aule universitarie. Dove però da molti anni non si dibatte, si indottrina e si fa lavaggio del cervello.
Quella situazione descritta da Pamela Paul chiama in causa non solo la Generazione Gaza bensì pure i suoi cattivi maestri.
6 gennaio 2021, la destra "legittimata"?
Richiamo l’attenzione su un passaggio iniziale della Paul, in cui si riferisce alla destra trumpiana. Lei ci torna con questa frase: “Cosa fu in fondo il 6 gennaio 2021 se non una gigantesca esplosione di rabbia da parte di coloro che si sentivano ingannati e volevano ottenere risarcimenti, con qualsiasi mezzo?”
Ecco, quel che accade nei campus universitari in questi giorni come viene visto dagli elettori repubblicani? Come una conferma che la sinistra in fatto di violenza ha due pesi e due misure, vede una violenza “fascista” e una violenza “giusta” perché viene dagli “oppressi”. Fu così anche in quella terribile estate del 2020 che precedette l’insurrezione del 6 gennaio al Campidoglio. Dopo l’assassinio dell’afroamericano George Floyd per settimane fu normale vedere commissariati di polizia e altre sedi istituzionali assaltati e incendiati da manifestanti di Black Lives Matter. Poi per altri mesi alcune zone del paese (ad esempio il centro di Portland nell’Oregon) divennero ufficialmente delle zone “liberate dalla polizia”, dove le forze dell’ordine non potevano più mettere piede.
Oggi corriamo il rischio che la Generazione Gaza si senta legittimata all’uso della violenza, a tal punto da farvi ricorso in modo sistematico? L’altro Sessantotto, quello di 56 anni fa, vide la diffusione della lotta armata negli Stati Uniti, in Italia, Francia, Germania. Onestamente, non siamo ancora arrivati a questo punto, non mi pare proprio.
Forza dell'economia Usa, un fattore di pace sociale
Una delle ragioni che prevengono il contagio delle proteste e della violenza, forse, è l’ottima situazione economica di cui l’America ha goduto finora: alta crescita, piena occupazione. L'altroieri è uscito un dato che segnala un rallentamento della crescita, e l'inflazione non è stata debellata. Però nell'insieme il quadro rimane positivo, migliore che in molte parti del mondo. E ne beneficiano un po' tutti.
La Generazione Z è ricca, economicamente sta meglio di come stavano le generazioni dei suoi fratelli maggiori o dei suoi genitori quando avevano la stessa età. E’ turbata, è sofferente, per mille motivi, ma non vive in un periodo di crisi economica o di ingiustizie sociali acute. Gli aumenti salariali e gli aiuti pubblici del periodo pandemico hanno perfino attenuato certe diseguaglianze. I lavoratori appartenenti a minoranze etniche – black, latinos – non sono mai stati così bene. Le tensioni politiche e culturali sono acute, ma non poggiano su problemi materiali.
Non è detto che questa situazione duri, però. La forza dell’economia americana in parte è virtuosa, è legata alla sua capacità d’innovazione e al dinamismo delle sue imprese. In parte invece è drogata da una spesa pubblica in deficit che aumentò a dismisura sotto Trump per il Covid, e ha continuato a crescere sotto Biden (ivi compreso per un “voto di scambio” a vantaggio degli studenti universitari: la generosa, costosa e iniqua cancellazione dei loro debiti a carico del contribuente). Non ho la capacità di distinguere quanta parte della crescita economica Usa sia “sana” e quanta “malsana”.
Il quadro mondiale: perdita di consensi
Alla forza di questa economia si contrappone un crescente isolamento dell’America rispetto al resto del mondo. Isolamento relativo, s’intende: la comunità transatlantica rimane un blocco straordinariamente ricco e influente. Se all’Europa si aggiungono i numerosi alleati asiatici – Giappone, Corea del Sud, Filippine – più Australia e Nuova Zelanda, “l’Occidente allargato” è molto grosso. Però in termini di popolazione il resto del mondo è ancora più grosso, e cresce di più.
Come il Vietnam negli anni Sessanta segnò una ferita grave per la legittimità, credibilità, autorevolezza degli Stati Uniti nel mondo, così in una certa misura sta avvenendo oggi per Gaza. “La guerra di Biden” fa perdere all’America consensi preziosi nel Grande Sud globale. Non è del tutto casuale che altri due paesi africani – Niger e Ciad – abbiano appena cacciato i militari americani.
La sorpresa "finale" degli anni Sessanta
I paragoni storici vanno maneggiati con prudenza e umiltà. Voglio ricordare tuttavia che negli anni Sessanta l’America sembrava “perduta”: sia agli occhi della sua Generazione Sessantotto, sia agli occhi di gran parte del mondo affascinato dal comunismo sovietico o cubano, dal maoismo cinese, dalle varie rivoluzioni post-coloniali, dalle rivolte studentesche. Poi invece dell’America fu l’Unione sovietica a implodere, e fu la Cina ad abbandonare il maoismo.
L’America lacerata e sgomenta degli anni Sessanta senza saperlo stava soffrendo anche le doglie di un parto molto speciale: la rivoluzione informatica, l’avvento del computer, la primavera della Silicon Valley. Nonché tante forme di ambientalismo, femminismo, anti-razzismo che la Generazione Gaza forse crede di avere inventato.
Il confronto-sfida tra l’America di questi giorni e i suoi grandi rivali come la Cina, continuerà a dipanarsi per anni, con chissà quanti colpi di scena. Un frammento di lezione dagli anni Sessanta forse è questo: le crisi che esplodono alla luce del sole, quelle crisi visibili e rumorose che vengono recitate in piazza nelle nostre democrazie, non sono necessariamente quelle più pericolose per la sopravvivenza di un sistema. Quando un sistema è stato disegnato all'origine per essere elastico e assorbire gli urti.
Perché non ci sono "cure economiche" per la denatalità (e cosa ci unisce alla Cina)
Gli allarmi sulla denatalità si susseguono e si assomigliano: in Italia come in tante altre parti del mondo, Cina inclusa. In genere nei paesi democratici chi sta all’opposizione accusa chi sta al governo di non fare abbastanza per aiutare le donne, per sostenere le famiglie, per promuovere le nascite. (In Cina non può esistere un’opposizione, ma il governo è preoccupato lo stesso).
I cosiddetti esperti, che pochi anni prima gridavano al disastro per la “bomba demografica” e la “sovrappopolazione”, ora lanciano urli di terrore per lo “spopolamento”, e così via.
In mezzo a tanto frastuono inutile, è una bella sorpresa trovare un’analisi lucida, precisa, fattuale. L’ha scritta John Burn Murdoch sul Financial Times. E’ una sintesi di vari studi sulla denatalità, che convergono su questa conclusione: gli aiuti alle giovani donne, alle future mamme, o alle coppie, sono una bella cosa in sé ma non influenzano affatto la decisione di fare figli. L’aspetto economico è irrilevante, in quella decisione.
Questo del resto dovrebbe essere abbastanza ovvio, è una conclusione di buon senso, di fronte a un’osservazione empirica: i tassi di fertilità e natalità rimangono più elevati in paesi più poveri, quindi non è certo la mancanza di mezzi a giustificare il crollo delle nascite nei paesi ricchi.
Sono fondamentali invece dei fattori culturali. Il più importante di tutti sembra essere la fiducia nel futuro. Una generazione convinta di essere alla vigilia dell’Apocalisse, o di vivere in una civiltà malvagia, in un mondo infernale segnato dalle peggiori ingiustizie, perché mai dovrebbe fare figli? Per condannarli all’inferno?
Un altro fattore culturale si può riassumere nel concetto esagerato e iperprotettivo dei diritti del nascituro: se questa creatura deve assorbire il massimo dell’attenzione, delle cure, degli investimenti in educazione, l’asticella forse è un po’ troppo alta, la responsabilità genitoriale fa tremare le vene ai polsi. Fin qui ho riassunto con parole mie.
Ecco invece la sintesi degli studi su natalità e demografia raccolti da Burn-Murdoch. Dal 1980 al 2019 l’insieme dei paesi ricchi e sviluppati ha triplicato (al netto dell’inflazione, quindi in potere d’acquisto reale) gli aiuti pro-capite per la natalità: assegni familiari, asili nido gratuiti, permessi di maternità-paternità, e altri sussidi pubblici. Nello stesso periodo il numero di nascite è sceso inesorabilmente, in media da 1,85 a 1,53 per ogni donna.
La Finlandia è un paese egualitario, con un Welfare generosissimo. Ha uno dei sistemi più avanzati al mondo per assistere e sostenere le famiglie (tradizionali e non) che vogliono avere figli. Nonostante questo il tasso di fertilità finlandese è caduto di un terzo dal 2010. L’Ungheria, che per motivi ideologici fa di tutto per promuovere le nascite, ha toccato il suo minimo storico. In Corea del Sud il governo ha lanciato un programma munifico di pagamenti a chi fa figli, detto “baby bonus”: il bilancio è semplice, quel programma ha pagato donne che avevano già deciso di farli per conto proprio, mentre non ha spostato il trend di calo della natalità che prosegue imperterrito. Come si vede non ci sono differenze tra politiche di sinistra (Finlandia) e di destra (Ungheria), né tra Oriente e Occidente.
L’autore di questa sintesi commenta: “Il legame tra le nascite e la spesa pubblica per politiche in favore della famiglia, è trascurabile. Si scopre che la decisione se avere figli oppure no, e quanti farne, è influenzata da molte altre cose anziché dal denaro”. Questo non significa che sia sbagliato dare aiuti alle mamme o future mamme. Può essere giusto per tante ragioni. Può rendere la vita un po’ più facile a quelle donne che hanno comunque deciso di avere figli, un obiettivo in sé lodevole. Può servire a ridurre la povertà infantile nelle famiglie a basso reddito. Tutte cose buone, basta non illudersi che servano a invertire la tendenza alla denatalità. “I fattori culturali intervengono a monte nelle decisioni, molto prima che i costi di allevare un figlio siano presi in considerazione”.
Uno studio di Matthias Doepke e Fabrizio Zillibotti del 2019, intitolato “Money and Parenting: How Economics Explain the Way We Raise Our Kids”, viene usato per le sue conclusioni illuminanti. Cita la convinzione diffusa tra le giovani generazioni, che per dare a un figlio un futuro soddisfacente bisogna occuparsi moltissimo di lui o lei, garantirgli la massima attenzione dei genitori, e investire in un’istruzione di livello superlativo, in concorrenza sfrenata con i figli degli altri. La sfida, descritta in termini così impegnativi da risultare quasi spaventosi, finisce per apparire irraggiungibile a molti. Meglio accontentarsi di una vita “normale”, da single o da sposati senza figli, anziché sobbarcarsi una responsabilità simile. In parallelo, un’altra evoluzione culturale ha spostato le priorità della vita per i giovani adulti. Nel 1993 il 61% degli americani intervistati in un’indagine del Pew Research diceva che avere figli è importante per una vita appagante; oggi solo il 26% condivide quell’affermazione. Le giovani donne in particolare hanno spostato le priorità mettendo al vertice la “crescita personale” e la “carriera professionale”. Le paure legate all’eccesso di responsabilità come genitori figurano in modo rilevante tra le ragioni per non avere figli. I costi economici appaiono solo al 14esimo posto.
Infine interviene il livello di angoscia delle giovani generazioni. “Più una potenziale mamma è preoccupata sul futuro, meno vuole avere figli. In America, in Europa, in Estremo Oriente, la generazione sotto i trent’anni è più impaurita dal futuro e più stressata rispetto alle altre generazioni”.
Concludo con la Cina, stavolta attingendo al racconto di Peter Hessler sul magazine The New Yorker dell’8 aprile 2024. Prima ancora di essere stato un corrispondente in Cina per quel settimanale, Hessler aveva insegnato l’inglese in una università del Sichuan. E’ rimasto in contatto con i suoi ex-studenti e spesso li consulta per capire lo stato d’animo della gioventù cinese. Quasi nessuno di loro ha avuto o vuole avere figli. Le risposte negative raggiungono il massimo tra le ragazze: 76%. Questo suo sondaggio empirico, su un campione limitato, coincide con i risultati di altre indagini più vaste. Del resto è noto che la Cina è entrata in una fase di decrescita della popolazione per effetto di un crollo delle nascite. A nulla sono serviti i provvedimenti presi dal governo. Le autorità di Pechino sono passate a gran velocità dalla politica del “figlio unico” alla libertà di fare due, tre figli. Infine dalla libertà il regime è passato agli incentivi: ora paga le mamme perché facciano bambini. I risultati sono insignificanti. Ecco la spiegazione offerta da una ex-studentessa di Hassler: “Io penso che i bambini cinesi sono stressati e turbati. Siamo già noi una generazione turbata. Allevare dei figli richiede lunghi periodi di affiatamento e di osservazione e di guida, tutte cose difficili da garantire in un contesto di pressione sociale intensa. Il futuro della società cinese è un’incognita. I bambini non ci chiedono di essere messi al mondo. Io ho paura che i miei figli potenziali non siano dei guerrieri, e finiscano per perdersi”.
La Cina in cui abitai io era una nazione molto più ottimista e fiduciosa nel suo futuro. Quella di oggi, nella mentalità dei giovani, sembra molto più simile all’Occidente. Le politiche in favore della natalità sono un falso problema.
Perché l'Africa caccia gli americani (c'entra Putin)
In poco più di una settimana, l'America ha perso due alleati africani, o quantomeno due presenze militari in questo continente. Prima il Niger poi il Ciad hanno dato il benservito ai militari Usa. Sono destinati a essere sostituiti dai russi: quasi certamente in Niger, mentre la situazione in Ciad è più aperta.
Il contraccolpo è stato sentito a Washington che vede arretrare la sua strategia africana. Accade in parallelo con le bocciature subite nei mesi e anni precedenti dalla Francia, i cui militari sono stati anch'essi espulsi da molti paesi. Spesso per essere sostituiti dai russi o dal Gruppo Wagner, i mercenari controllati da Mosca.
L'espulsione dei militari americani dal Niger è stata definita da diversi esperti Usa come un duro colpo alla strategia di Washington contro le forze jihadiste in Africa occidentale. Il Niger era un pilastro di quella strategia, ospitava la più grossa base militare Usa di tutta l'Africa occidentale, con mille soldati; e una base di droni costruita ad Agadez con un investimento di 110 milioni di dollari. Fino all'anno scorso i Berretti Verdi americani di stanza in Niger addestravano le truppe locali a combattere contro una delle più ampie guerriglie jihadiste del mondo, e i droni made in Usa contribuivano a spiare le milizie islamiste. A questo punto l'America deve ripiegare su un piano B, più limitato e difensivo: cercando di arginare il contagio jihadista in paesi vicini che ancora accolgono la presenza Usa, anziché andare all'offensiva contro il cuore delle forze islamiste.
Cos'ha provocato la cacciata? L'anno scorso in Niger c'è stato un colpo di Stato militare, condannato dalla Casa Bianca. L'Amministrazione Biden ha fatto pressione sulla giunta golpista perché ristabilisca un governo civile e legittimo. A quel punto i generali, guidati dal presidente Mohamed Bazoum, hanno cominciato a spostarsi verso un'alleanza con Mosca. Di recente la capitale del Niger Niamey è stata i
|