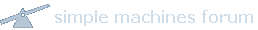La crisi che cambiò l’Europa
Silvano Andriani
Alla fine è stato deciso, come era necessario, un salvataggio totale e coordinato a livello mondiale dei sistemi bancari. Per quanto riguarda la ricapitalizzazione delle banche è stata seguita la strada intrapresa dal governo inglese con la eventuale nazionalizzazione delle banche dissestate e non quella intrapresa dal Governo Usa con l’acquisto col denaro pubblico dei titoli tossici, ora ripudiato, pare, da chi lo aveva proposto.
Restano da abolire o, quanto meno sospendere, le regole contabili che accentuano piuttosto che attenuare le criticità del ciclo economico e che rischiano di scaricare la evidente irrazionalità dei mercati nei bilanci delle imprese finanziarie aggravandone la situazione. Riconoscere che gli interventi decisi erano necessari per evitare il collasso non esime dal valutare cosa essi comportino.
Gli interventi di salvataggio decisi dagli Usa - Bearn Stern, Aig, piano Paulson - si avvicinano ai 1000 miliardi di dollari. Ma la nazionalizzazione di Fannie e Mac, i due giganti dei mutui, ha imbarcato nel bilancio pubblico oltre 5000 miliardi di rischi di credito. Non sappiamo quante saranno le perdite. Nel caso del salvataggio delle Casse di risparmio su un fondo di 400 miliardi di dollari le perdite furono di un terzo. Se tale percentuale si ripetesse il costo complessivo dei salvataggi ammonterebbe a circa il 17% del prodotto nazionale lordo. I 250 miliardi di sterline del piano inglese ed i 400 miliardi di euro ipotizzati per il piano tedesco rappresentano rispettivamente il 25% ed il 20% circa del prodotto lordo dei due Paesi.
È evidente che la regola per la quale gli Stati non debbono alterare la concorrenza favorendo singole imprese viene platealmente violata da questi interventi: banche che dovrebbero fallire saranno salvate e saranno sfavorite le banche che hanno svolto la loro attività con oculatezza. E poiché andiamo verso una recessione e saranno possibili dissesti di grandi imprese non bancarie, come si farà a negare l’intervento in difesa di quelle imprese? Un caso potrebbe essere proprio Alitalia. Il piano del governo italiano viola chiaramente le regole della concorrenza, ma come farà l’Unione europea a contestarlo ora che chiude gli occhi su tanti e così massicci salvataggi di banche?
Il “patto di stabilità” dell’Unione Europea viene polverizzato. Anni di discussione non sono serviti ad introdurre in esso piccole sensatissime modifiche e ora, senza battere ciglio, si accettano sfondamenti che comporteranno nel 2009 deficit pubblici mostruosi ed un balzo in alto del livello dell’indebitamento pubblico. Certo bisogna evitare il disastro, ma si potrebbe notare che queste non sono le prime crisi: negli ultimi 20 anni possiamo contare cinque crisi finanziarie che hanno creato rischi di collasso dei sistemi finanziari. Nello stesso periodo si possono ricordare il salvataggio della Casse di risparmio Usa, la nazionalizzazione dei sistemi bancari di tutti i paesi scandinavi, Il maxisalvataggio di Credit Lyonnes, due interventi di salvataggio a favore del sistema bancario giapponese, numerosi salvataggi in Asia ed in America latina durante le crisi finanziarie della seconda metà degli anni ‘90. Il paradosso per cui proprio nella fase in cui si predicavano le privatizzazioni, lo “Stato minimo” ed il divieto di interventi pubblici a favore di singole imprese sono stati effettuati per le banche i salvataggi pubblici più numerosi ed importanti della storia del capitalismo non lo si è voluto vedere né da parte dei politici, né da quella della generalità degli economisti. Non si è così voluto prendere atto che nell’epoca del neo-liberismo la forma più importante dell’instabilità dei sistemi economici sono le crisi finanziarie e bancarie. E si è continuato a sostenere che i mercati sono in grado di autoregolarsi.
La crescita dell’indebitamento privato è stata una delle caratteristiche di fondo dello sviluppo a partire dagli anni ‘90, questa tendenza, originata nei Paesi anglosassoni, è andata estendendosi anche agli altri Paesi avanzati. Le retribuzioni sono rimaste stagnanti, alla maggioranza della popolazione è stato preclusa la possibilità di partecipare ai benefici della crescita della produttività, ma le è stato concesso di indebitarsi facilmente. Anche la fascia di popolazione nella quale andava concentrandosi la ricchezza ha usato questa come leva per indebitarsi ed aumentare gli asset posseduti. Il livello di indebitamento privato nei Paesi anglosassoni ha largamente superato il record del 1929.
Da anni si è giustamente affermata la convinzione che un eccesso di indebitamento pubblico sia cosa cattiva: il “patto di stabilità” dell’Unione europea è basato su questo assunto. Ma non è detto che un eccesso di indebitamento privato sia cosa buona o meno cattiva. Ora esso, con la crisi che ha generato e gli interventi statali per evitare la catastrofe, si tradurrà in un repentino e formidabile aumento del già eccessivo indebitamento pubblico e questo aggraverà il connotato più negativo assunto dalle società nell’epoca del liberismo: l’irresponsabilità verso le generazioni future che saranno chiamate a onorare quei debiti.
Una conclusione che si può trarre riguarda la necessità di una sostanziale revisione del “patto di stabilità” e non solo per apportare le modifiche da tempo richieste, ma per modificarne la ratio. Ormai è chiaro che assumere come indicatore dell’instabilità dei sistemi economici solo il livello di indebitamento pubblico è riduttivo: il contributo che ciascun Paese dà alla stabilità o instabilità mondiale andrebbe misurato tenendo conto dell’indebitamento pubblico, di quello privato e del tasso di risparmio. Se così si facesse risulterebbe che alcuni Paesi, come l’Italia, ritenuti molto viziosi, lo sono assai meno ed altri, ritenuti virtuosi, come Usa ed Inghilterra, sono tra i più viziosi.
Dalla fase più acuta della crisi usciremo con un livello di indebitamento complessivo ancora più elevato e questo getta un’ombra sulle possibilità di sviluppo futuro. Fino a ieri ci si chiedeva se sarebbe arrivata una recessione oggi ci si dovrebbe chiedere se si tratterà di recessione o di depressione. In questi frangenti avere una politica economica rivolta a sostenere uno sviluppo sostenibile con ogni mezzo è di vitale importanza. Va cambiata l’attitudine europea a ritenere che unico obbiettivo della politica economica sia il controllo dell’inflazione esso, anzi, non dovrebbe nemmeno essere considerato un obbiettivo, ma una semplice vincolo. La politica economica dovrebbe essere orientata a realizzare il tasso di sviluppo potenziale dell’Europa al tasso di inflazione ritenuto in quel momento accettabile.
Per realizzare un tale obbiettivo, che negli ultimi venti anni l’Europa ha sistematicamente mancato, sarebbe necessario modificare la distribuzione del reddito allo scopo di avere una crescita adeguata della domanda interna senza aumentare l’indebitamento delle famiglie e mettere in campo una strategia di investimenti pubblici anche a livello europeo del tipo di quelli a suo tempo proposto dal piano Delors.
www.silvanoandriani.it Pubblicato il: 15.10.08
Modificato il: 15.10.08 alle ore 8.13
© l'Unità.